
da Antonio Jacolina | Nov 18, 2021
Alexander (Pierfrancesco Favino), figlio di madre inglese e padre italiano, ha solo 10 anni quando suo padre muore annegato sotto i suoi occhi. Pur vivendo un’adolescenza in un contesto agiato fra la madre a Londra ed il nonno paterno (Jean Reno) a Roma, ne resterà segnato per sempre nel carattere. Quando la vita gli farà incontrare il vero amore e la vera passione in Laura (Kelly Reilly) non saprà osare per prendere la giusta decisione al giusto momento … la ricercherà e la rimpiangerà tutta la vita …
Presentato e recensito poche settimane fa alla 16ma Festa del Cinema di Roma ove è stato accolto con giudizi contrastanti, esce oggi sugli schermi l’ultimo lavoro di Amanda Sthers. Apprezzata scrittrice, sceneggiatrice e regista, la francese Sthers ha adattato per questo suo 4° lungometraggio lo script dal suo stesso romanzo omonimo uscito nel 2015. Al centro del suo film c’è una grande storia d’amore inespressa ed incompiuta, che avrebbe potuto concretizzarsi ed essere vissuta se solo il protagonista avesse avuto la forza, il coraggio e l’egoistica determinazione di prendere una decisione.
Un intrigo esistenziale sull’incapacità soprattutto degli uomini, di taluni uomini, di saper cogliere l’opportunità di essere felici e prendere su di sé il rischio di amare. Chi? Chi allora meglio di una donna autrice e regista può provare a trovare la giusta modalità per scrivere prima, e rappresentare poi, questa incapacità ed anche il rimpianto che la felicità e l’occasione perduta genererà per tutta la vita? Una storia di sicuro vista e rivista, tanto nella Vita quanto al Cinema, ma, ciò non di meno, è una storia ogni volta sempre coinvolgente perché tocca nel profondo l’essenza stessa dell’Essere Umano: la costante ricerca della Felicità e dell’Amore e con loro la ricerca del Tempo perduto e delle opportunità perdute fino … alla presa di coscienza finale che non esisterà un’altra opportunità per una seconda occasione.
Alexander il protagonista, è bloccato emotivamente per non soffrire, vincolato fra famiglia, amicizie e lavoro. Un uomo in bilico fra due anime, che cerca di fuggire i fantasmi di un passato che lo ha segnato e lo segna. Vive un effimero presente senza nemmeno darsi spazio per sognare un futuro o lottare per averlo. Così, quando incontra l’Amore ed intuisce che può essere la Felicità di cui ha bisogno, non è però in grado di agire per riuscire a viverlo perché è abituato a subire e non sa più osare.
Il film, come fosse una riflessione del pensiero, è costruito a spirali in un’alternanza continua fra passato, presente e flashforward che creano quasi una dimensione narrativa atemporale come in effetti è il pensiero, così come al di là del tempo e dell’attimo è, di per se stessa, anche la domanda se si è felici. Il montaggio dà ritmo e scansione, ora lenta ora rapida, alla narrazione che procede come sospesa in un mare di pensieri. La regista però, pur operando con eleganza ed essendo sufficientemente abile ad evitare di scadere nel melodramma, sembra talora perdersi proprio nelle tante, troppe, spirali dell’intreccio narrativo e la sua direzione conseguentemente risulta insicura e discontinua. Favino, di contro, è veramente bravo e dimostra di saper essere a suo agio anche in una realizzazione internazionale recitando in modo partecipe, tenero ed intenso, un po’ più sottotono è invece la bella Reilly. Precisi, come sempre in questo tipo di produzioni, quasi tutti i secondi ruoli.
Al film, di per sé gradevole, manca però qualcosa … qualcosa per essere veramente un buon film! la continuità narrativa soffre infatti per l’eccessiva frammentazione, manca un pieno coinvolgimento emotivo e l’insieme appare fin troppo distaccato ed alla fine non riesce affatto a smuovere le emozioni profonde dello spettatore che osserva sì le pene del protagonista ma non ce la fa proprio a commuoversi per la sua felicità perduta!
data di pubblicazione:18/11/2021
Scopri con un click il nostro voto: 

da Daniele Poto | Nov 18, 2021
(Teatro Argentina – Roma, 17 novembre/9 dicembre 2021)
Lo spettacolo più rappresentato e universale in una versione ariosa e incandescente con alcune punte di eccentricità. Eccezionale omogeneità della compagnia per un classico immortale che è bel biglietto da visita per la stagione del Teatro che si farà Fondazione.
Senza limiti di spese per la scenografia, varia e di facile smontabilità interattiva, e senza limiti di tempo per il dramma scespiriano che fa faticare a tratti nel primo tempo mentre digrada verso l’immaginabile sviluppo liberando lo spettatore dopo tre ore di tensione. Fausto Cabra che declama l’essere o non essere in avvio, svelando la missione programmatica di quanto succederà di lì a poco, è un’autentica rivelazione. Di bravura inversamente proporzionale alla ancora ridotta popolarità. Esibizione anche fisica e muscolare, non tanto per l’accenno mimico nella simulazione dei duelli quanto per l’ardore con cui alimenta un corpo che asseconda il declamare nella forbita traduzione di Garboli. Spettacoli come quasi non se ne fanno più per la pandemia con un numero generoso di attori e con l’uso indiscriminato degli spazi. L’Amleto rappresenta l’inquietudine e una progressiva montante ansia di vendetta. L’adattamento non tradizionale incuriosisce e a tratti strega riscattando la grande conoscenza del plot. Attori in abiti borghesi, con estrema libertà interpretativa. La macchina teatrale va a frugare dentro l’anima interiore, interrogata sulle sue pulsioni non sempre benevole. Danimarca, Inghilterra, Italia, Elsinore. Il mondo è lontano (il secolo di Shakespeare, anche) ma è anche terribilmente vicino. Usurpazione e oltraggio di una storia che ci si ripresenta ogni giorno con altri linguaggi e altre situazioni. Alla prima teatro stipato in ogni ordine di posti, nonostante la difficoltà della prova spettatoriale. Buon segno per il futuro e per il più importante teatro di Roma: quello che dovrebbe indicare la strada agli altri. Anche quelli attualmente chiusi.
data di pubblicazione:18/11/2021
Il nostro voto: 

da Daniele Poto | Nov 17, 2021
(Teatro Olimpico – Roma, 16/21 novembre 2021)
One woman show che parte con le marce basse ma poi passa gradualmente alla quarta e alla quinta in un crescendo autoriale. La gattamorta è la quintessenza di un certo tipo di donna. Molto italiana.
Due anni in standby per uno spettacolo che si arricchisce nell’attualità con gli ovvi spunti della pandemia e dell’overdose di virologi. L’avvio lascia perplessi perché i video imitatori di Ilaria Capua e Vittorio Andreoli mostrano protagonisti che non sono proprio al top della popolarità anche se la capacità mimetica della Reggiani è autorevole. Lo spettacolo cresce con colpi di coda e in presenza fino ad approdare al succo polposo evocato dal titolo. La Reggiani ha corpo e volto d’attrice uscendo fuori dai limitati panni del comico in perfetta empatia con il suo ritrovato pubblico, che l’approva di testa quando esprime verità consacrate e mai abbastanza dette (le giravolte sul Covid, la difficoltà di mantenere un rapporto sentimentale in regime di virtuali arresti domiciliari) e ride di pancia in progressione. Lo spettacolo monta quando, riproducendo un format di successo, si sfidano al video Giorgia Meloni e Concita Di Gregorio ovvero la coattona politica di destra e la radical chic di sinistra. E qui la Reggiani è perfetta nell’intonazione, nella forma e nel contenuto. Ma l’hit parade è indubbiamente il monologo finto dialogo telefonico, sulla scia di Franca Valori, Bice Valori, Cinzia Leone. La veterana tiene bene l’immenso spazio teatrale con una resa a cui contribuiscono le musiche (Vivaldi, Buena Vista Social Club), i raggi di luce multicolori, la sua corposa presenza. Quanta verità nella caricatura delle donna italiana messa a confronto con la donna russa! Un match a vantaggio della seconda nella prime riprese ma che a gioco lungo si chiude a favore della prima: i mariti tornano sempre a casa a fronte di pretese sempre più smodate delle donne dell’est.
data di pubblicazione:17/11/2021
Il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Nov 16, 2021
Dopo un burrascoso colloquio con il fratello Renato, Gabriele sente la necessità di recarsi a trovare l’anziano padre, un ex magistrato in pensione, che durante il loro incontro gli confessa: “se dovessi scegliere tra la legge e l’amore, oggi sceglierei l’amore”. Da quel momento Gabriele capirà di non volersi più sottrarre a quella insolita ed inaspettata “paternità” che il destino gli ha regalato, travolgendolo come solo la vita vera sa fare.
Gabriele Santoro è un rispettato insegnate di pianoforte con un passato da concertista. La sua vita scorre monotona ed in totale solitudine in un appartamento nei quartieri spagnoli di Napoli, dove quest’uomo taciturno e schivo ha scelto di vivere nonostante le sue origini borghesi. Le sue giornate sono tutte uguali e la musica è la sua unica vera ragione di vita; conscio che quella solitudine può intaccare la sua lucidità, recita a memoria ogni mattina brani di poesie per tenere in esercizio la memoria. Tra le mura del suo appartamento, dove Gabriele si difende nascondendosi dal mondo esterno, un giorno come tanti entra furtivamente Ciro, il figlio di un vicino. L’uomo preferisce non vessare di domande il bambino, dichiaratamente in fuga dalla sua famiglia per qualcosa che inizialmente non riesce a confessare: in poco tempo, costretti dai loro reciproci “segreti “ a vivere e confrontarsi sotto quello stesso tetto, tra i due nasce una meravigliosa storia che ha a che fare proprio con quell’amore che l’anziano genitore aveva profeticamente indicato a Gabriele come l’unica scelta di vita possibile.
“La casa diventa un luogo di tensione e decantazione che conduce i personaggi a un nuovo stato affettivo, come se stessero creando le basi di una nuova famiglia”, spiega lo scrittore Roberto Andò che ha anche diretto l’adattamento cinematografico del suo omonimo romanzo. Il parallelismo tra una vita “normale” e ciò che drammaticamente si consuma in certi contesti criminali, rappresenta la struttura di tutto il film sino a quando quei due mondi, incontrandosi, inevitabilmente si contaminano, inducendo Gabriele a prendere coscienza di ciò che sino ad allora era rimasto fuori dalla propria porta di casa e Ciro a fuggire dalla realtà in cui era cresciuto sino a quel momento.
La narrazione, tuttavia, seppur intrisa di una certa drammatica elettricità sin dalle prime scene, è fatta prevalentemente di silenzi e sguardi, in cui si impongono la bravura indiscussa di Silvio Orlando e la spontaneità di Giuseppe Pirozzi che interpreta Ciro. Splendidi i camei di Roberto Herlitzka e Gianfelice Imparato rispettivamente nei ruoli del padre e del fratello di Gabriele, due facce di una stessa medaglia con cui l’uomo finalmente farà i conti, senza più nascondersi, in un viaggio verso la consapevolezza di quello che è il suo vero mondo, come recitano alcuni versi che declama la mattina per mantenere allenata la propria memoria: “quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure ed esperienze”. Un altro bel film da non perdere.
data di pubblicazione:16/11/2021
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Jacolina | Nov 14, 2021
Francia Anni ’60/’70… Il fondatore e direttore di un magazine americano con base nella fittizia cittadina di Ennui-sur-Blasé muore all’improvviso lasciando dietro di sé una redazione addolorata. La rivista chiuderà e l’ultimo numero antologico sarà composto dai migliori articoli pubblicati che costituiscono la trama del film. L’occasione per mettere in scena una raccolta di storie e di un mondo idealizzato da parte di un geniale e visionario creatore di immagini con un cast eccezionale da scoprire di volta in volta….
Wes Anderson dal 1995 ad oggi ha realizzato solo 10 lungometraggi ma è già un mito assoluto nel mondo della Settima Arte per la sua genialità, eccentricità ed estetica personale che, unitamente ad una capacità di trasfigurazione fiabesca della realtà, sono la sua inconfondibile cifra stilistica. Ognuno ama od odia il suo personale Anderson: quello de I Tannenbaum, de Il Treno per Darjeeling, di Grand Budapest Hotel o anche di Moonrise Kingdom. Si può solo amare od odiare l’artista. Non ci sono mezze misure! Si amerà o si odierà quindi, a maggior ragione, The French Dispatch perché è un divertissement che il regista e la banda dei suoi attori si sono concessi. Un divertissement che è la summa dell’arte di Anderson, più film in uno e quindi più Anderson in uno.
The French Dispatch, presentato quest’anno a Cannes, è un film strutturato in segmenti e in sketches che sono a loro volta anche un viaggio fantasioso attraverso il grande cinema francese dagli anni ‘30 ai ‘70, un omaggio affettuoso al The New Yorker (il mito dell’editoria e del giornalismo americano) ed alle bandes dessinées, i fumetti francesi. Un divertissement, un gioco, in cui attori celebri recitano o passano sullo schermo senza soffermarcisi più di tanto. Sono tutti bravi, belli e ben diretti e si vede che si divertono a recitare, quale che sia il trucco dietro cui si nascondono. Attorno a loro Anderson si diverte a sua volta a rifare, per la gioia sua e dei cinefili, Tati, Renoir, Truffaut, Godard, Cluzot, Melville… come solo un appassionato del cinema francese – come lui notoriamente è – potrebbe fare ed apprezzare. Tanti Anderson, dunque, ma l’ispirazione nei vari episodi non è sempre la stessa. Talora l’idea iniziale, pur se geniale, si spegne dopo un po’, comunque sia il marchio autoriale è sempre presente anche nei momenti di stanca: la padronanza della regia, la direzione artistica fenomenale, la straordinaria capacità di pianificazione di ogni sequenza, la creatività scenografica senza limiti, il perfetto senso del ritmo, la capacità di rendere credibile l’incredibile e reale il surreale, alternando attori e cartoons, colori pastello e bianco e nero in modo quasi naturale e normale.
Una capacità creativa a tratti poetica che, libera dai legami di una narrazione classica, dà spazio a tutta la fervida immaginazione dell’autore ed al suo esuberante gusto pittorico e formale.
Però, c’è un però… come dicevamo a tratti il ritmo rallenta, zoppica e l’ispirazione geniale svanisce. L’autore sembra quasi compiacersi nelle citazioni e nell’autocitazione e diviene troppo sofisticato, poco sorretto dalla flebilità delle storie. Alla fine gli sketches sono sì belli ma sono pur sempre degli sketches, per loro natura ineguali e di breve respiro.
The French Dispatch è quindi un film autoriale ma un po’ ineguale che sicuramente sedurrà i fedelissimi del regista restando probabimente un’opera minore nella sua filmografia, un lavoro interessante teoricamente e tecnicamente ma talora evanescente che potrà tanto affascinare quanto anche stancare. Una vera summa di immagini, anzi il sogno smisurato di un collezionista di immagini! Una messa in scena eccentrica che è una ghiottoneria per gli occhi ed un’antologia del cinema di Anderson.
Ognuno continuerà così ad amare o ad odiare il proprio Wes Anderson.
data di pubblicazione:14/11/2021
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Nov 12, 2021
Joanna sbarca a New York con la grande aspirazione di diventare un giorno una scrittrice. Siamo a metà degli anni novanta e non è certamente facile per una giovane donna trovarsi da sola ad affrontare tutta una serie di difficoltà pur di realizzare il proprio sogno. Il lavoro come assistente di Margaret, a capo di un’importante agenzia letteraria, sarà per Joanna una buona opportunità per entrare in un mondo a lei sino ad allora sconosciuto…
E’ uscito finalmente nelle sale italiane Un anno con Salinger del regista e sceneggiatore canadese Philippe Falardeau, presentato nel 2020 come film di apertura della settantesima edizione della Berlinale. Un film leggero, una tipica commedia american style divertente, niente affatto superficiale, che ci porta in una New York degli anni novanta ancora tradizionalmente legata ai propri principi sociali, ma già pronta per accogliere quella rivoluzione socio-culturale che sarebbe presto scaturita con l’avvento e la diffusione di Internet. Joanna lavora in una prestigiosa agenzia che cura gli interessi di scrittori di grosso calibro quali F. Scott Fitzgerald, Agatha Christie e Dylan Thomas, anche se il suo principale compito è quello di raccogliere accuratamente le decine di lettere che ogni giorno arrivano per J. D. Salinger da parte dei suoi numerosi fan, leggerle per poi cestinarle, con il divieto categorico di rispondere. La ragazza si misura con una realtà dove non tutto procede con regolare razionalità e, senza volerlo, entrerà nel mondo del giovane Holden, protagonista appunto del romanzo di Salinger che, agli inizi degli anni cinquanta, diventò appena pubblicato un best seller in tutto il mondo.
Il film ci vuole ricordare come i giovani di quella generazione non si sottrassero al fascino di un giovane, appena sedicenne, che con il suo spiccato senso critico, ma psicologicamente emotivo e fragile, si sarebbe comunque ribellato a un establishment deviato, tipico della società americana di quel tempo.
Margaret Qualley, già famosa per la sua partecipazione in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino, nel film interpreta una intensa e spontanea Joanna, riuscendo ad esprimere al meglio le emozioni di questa giovane ambiziosa e sognatrice, che si trova catapultata in un mondo nuovo ma ancora decisamente condizionato dal passato. Sigourney Weaver invece è Margaret, una donna intransigente, diffidente e rigida verso qualsiasi iniziativa che non nasca direttamente da se stessa, ed è perfetta nel ruolo del capo che, seppur con le dovute differenze, sembra appartenerle sin dai tempi de Una donna in carriera.
My Salinger Year è un film dai tempi e i ritmi giusti, senza lungaggini e inutili divagazioni, mirando alla vera essenza delle cose e dei sentimenti.
data di pubblicazione:12/11/2021
Scopri con un click il nostro voto: 

da Daniele Poto | Nov 12, 2021
Tre ore per entrare nel mondo giapponese fatto dialoghi elegante in salsa Cechov. Cinema dentro teatro o viceversa con la massima attenzione per la parole, gemme di dialogo.
Entrando in sala per un film che ha avuto citazioni da Oscar bisogna acclimatarsi a un altro ritmo: un ritmo diverso da quello adrenalinico dei film americani, ma anche da quello a volte troppo auto-compiaciuto di tanta cinematografia italiana. Il protagonista vive un dolore trattenuto e non espresso. Una serie di sciagure collassano la sua vita. Un glaucoma gli impedisce di guidare (scorciatoia per introdurre il fondamentale personaggio dell’autista donna) e, in sequenza, perde la figlia e la moglie. Questa serie di circostanze lo indirizza verso il lavoro e la solitudine. Sarà l’incontro con la persona che non appartiene al suo mondo riservato e in fondo privilegiato a fargli riscoprire l’umanità perduta. Riscoprire la sofferenza e la sua metabolizzazione sarà un passaggio obbligato.
A fare da sfondo alla storia c’è sullo sfondo il Giappone così diverso dal clima italico. Tradimenti senza risentimento, sesso che non ha bisogno di paludamenti a parte la sua assoluta necessità e inderogabilità. Cechov sul grande schermo era stato il canovaccio di un film di Louis Malle. Ma questo cinema restituisce l’amore per il teatro, per la memoria dell’attore e la memoria della vita. Film ipnotico da incantamento che, come si può immaginare, non ha avuto una grande distribuzione nazionale se non per la cura e la passione di alcuni esercenti. Chi si è innamorato del fil trova che non ci sia una parola fuori posto e un movimento sbagliato di macchina. Puerile definirlo intimista quando il veicolo della comunicazione mimetica passa anche per il cibo, le bevande e una carezza a un cane, la guida di un’antiquata autovettura Saab.
“Per quanto si può leggere nel cuore di una persona non si può leggere in lei come un libro aperto”. Questa citazione riassume molto dello spirito della pellicola.
data di pubblicazione: 12/11/2021
Scopri con un click il nostro voto: 
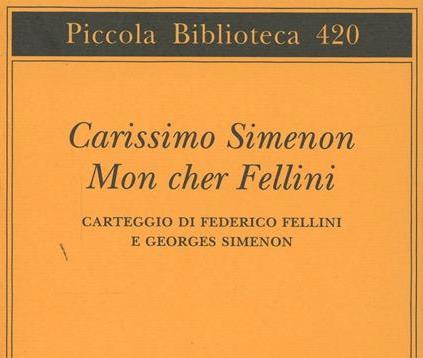
da Antonio Jacolina | Nov 10, 2021
 La Festa del Cinema di Roma proiettando in anteprima pochi giorni fa il breve documentario prodotto da Rai Movie Fellini e Simenon di Giovanna Ventura sull’amicizia dei due grandi del Cinema e della Letteratura, offre agli appassionati dell’uno o dell’altro l’opportunità di andare a rileggersi o ad acquistare il libricino prontamente ristampato da Adelphi e rimesso in libreria proprio per l’occasione.
La Festa del Cinema di Roma proiettando in anteprima pochi giorni fa il breve documentario prodotto da Rai Movie Fellini e Simenon di Giovanna Ventura sull’amicizia dei due grandi del Cinema e della Letteratura, offre agli appassionati dell’uno o dell’altro l’opportunità di andare a rileggersi o ad acquistare il libricino prontamente ristampato da Adelphi e rimesso in libreria proprio per l’occasione.
Si tratta del breve carteggio intercorso fra i due artisti dal 1969 al 1989 anno di morte di Simenon. L’amicizia, o meglio, il legame culturale ed umano fra i due autori era in effetti nato già in occasione del Festival di Cannes 1960 quando Simenon, presidente della giuria, consegnò la palma d’oro a Fellini per la sua Dolce Vita. A prima vista nulla può apparire più antitetico dei due personaggi, perché nulla dei loro metodi e della loro produzione sembra apparentemente mostrare elementi di somiglianza; tanto il regista è onirico, effervescente, barocco e surreale, tanto lo scrittore è invece metodico, minimalista, organizzato ed austero. Come nacque allora il rapporto fra due artisti così diversi?
Leggendo le pagine di questa breve ma interessante raccolta epistolare si potrà comprendere che pur diversi come produzione, i due erano simili come uomini, Simili erano infatti le loro affinità psicologiche e spirituali. Entrambi erano soggetti a ricorrenti momenti di depressione, erano ossessionati dai ricordi d’infanzia, dal mondo circense, dall’immagine femminile e dalle stesse dinamiche creative caratterizzate ora da momenti di alta ispirazione ed ora da blocchi assoluti.
E’ Simenon che con acume particolare coglie il senso vero della filmografia di Fellini, lo compara con se stesso, affermando che entrambi indagano sull’essenza dell’essere umano e sulla capacità di cogliere una speranza nella rappresentazione della fallacità delle azioni e dei progetti umani. Uno opera con le parole, l’altro con le immagini. Ambedue risultano affascinati dai misteri della psiche ed interessati alla psicanalisi di Jung e quindi convinti della forte influenza del subconscio sulla loro produzione artistica e sui loro impulsi.
Il libretto è una vera opportunità, rapida e scorrevole di entrare nel mondo e nel privato di due personalità sensibili e curiose. Un’opportunità per gli appassionati di Simenon per scoprire l’uomo e le sue motivazioni artistiche e, con l’occasione, svelare anche l’uomo Fellini. Scopriremo un Simenon di 17 anni più anziano del regista che assume il ruolo di fratello maggiore pronto a trasmettere incoraggiamenti, esperienza e saggezza.
Non si tratta certamente di un capolavoro della letteratura epistolare, ma, ciò non di meno, il libretto è un documento interessantissimo, testimonianza sincera della reciproca stima professionale ed umana fra due sommi artisti che si articola fra rispetto, pudore di sentimenti, fratellanza umana e complicità. La singolarità è che i due pur impegnandosi a volersi incontrare ad ogni possibile occasione, nella realtà dei fatti in 20 anni si videro ben pochissime volte.
data di pubblicazione:10/11/2021

da Daniele Poto | Nov 9, 2021
 Una fotografia in movimento sull’attuale politica italiana, frugata nei due rami del Parlamento alla ricerca delle personalità più estemporanee, delle uscite fuori del coro, nella variopinta materia prima umana sfornata dalle elezioni. Roncone ha la penna leggera ma pur non soffermandosi sull’analisi, trapela una palese insoddisfazione istituzionale per il livello mediocre dei nostri rappresentanti. Il libro risente dell’attualità perché è una silloge degli articoli pubblicati sul Corriere della Sera, disposti per argomenti e non per cronologia, quindi con imprevedibili salti in avanti e indietro. Per sottrazione si capisce anche quale sia il rassicurante quadro di riferimento dell’autore. Ovviamente non la destra, non il Movimento Cinque Stelle ma il rassicurante Partito Democratico, sempre più partito di centro e della cosiddetta zona ZTL. Libro di folclorismi puri e non di ideologia frequentando ambienti che dovrebbero essere pregiati ma che, all’esplorazione, rivelano tutta la propria pochezza. L’avvento di Draghi forse restituisce dignità e speranza ma la percentuale degli elettori che vanno alle urne è lo specchio della delusione crescente del popolo italiano e una eloquente risposta a quello che gli viene propinato in sede parlamentare. Con la girandola dei continui cambi di partito dove il presunto vincolo di mandato è ormai purissima utopia. Si può dire che predomini il disincanto realista dell’autore. Fatti, fattacci, nefandezze, meschinità, rivalità e duelli: tutto quanto viene espresso per permettere al lettore di farsi un’idea compiuta sull’attuale livello della classe politica italiana. L’ultima illusione è stata quella fornita da Grillo ma una serie di esempi sfornati da Roncone è una doccia fredda su un’utopia che non si è tradotta in fatti concreti. La seconda Repubblica così è una serie di ritratti poco consolatori da sfogliare in cerca di un futuro politicamente più rassicurante. Se mai avremo l’occasione di coglierlo.
Una fotografia in movimento sull’attuale politica italiana, frugata nei due rami del Parlamento alla ricerca delle personalità più estemporanee, delle uscite fuori del coro, nella variopinta materia prima umana sfornata dalle elezioni. Roncone ha la penna leggera ma pur non soffermandosi sull’analisi, trapela una palese insoddisfazione istituzionale per il livello mediocre dei nostri rappresentanti. Il libro risente dell’attualità perché è una silloge degli articoli pubblicati sul Corriere della Sera, disposti per argomenti e non per cronologia, quindi con imprevedibili salti in avanti e indietro. Per sottrazione si capisce anche quale sia il rassicurante quadro di riferimento dell’autore. Ovviamente non la destra, non il Movimento Cinque Stelle ma il rassicurante Partito Democratico, sempre più partito di centro e della cosiddetta zona ZTL. Libro di folclorismi puri e non di ideologia frequentando ambienti che dovrebbero essere pregiati ma che, all’esplorazione, rivelano tutta la propria pochezza. L’avvento di Draghi forse restituisce dignità e speranza ma la percentuale degli elettori che vanno alle urne è lo specchio della delusione crescente del popolo italiano e una eloquente risposta a quello che gli viene propinato in sede parlamentare. Con la girandola dei continui cambi di partito dove il presunto vincolo di mandato è ormai purissima utopia. Si può dire che predomini il disincanto realista dell’autore. Fatti, fattacci, nefandezze, meschinità, rivalità e duelli: tutto quanto viene espresso per permettere al lettore di farsi un’idea compiuta sull’attuale livello della classe politica italiana. L’ultima illusione è stata quella fornita da Grillo ma una serie di esempi sfornati da Roncone è una doccia fredda su un’utopia che non si è tradotta in fatti concreti. La seconda Repubblica così è una serie di ritratti poco consolatori da sfogliare in cerca di un futuro politicamente più rassicurante. Se mai avremo l’occasione di coglierlo.
data di pubblicazione:09/11/2021

da Rossano Giuppa | Nov 9, 2021
(Teatro India – Roma, 2/7 novembre 2021)
Daria Deflorian e Antonio Tagliarini firmano la regia di Chi ha ucciso mio padre, tratto dall’omonimo testo letterario del giovanissimo scrittore Edouard Louis, andato in scena al Teatro India di Roma dal 2 al 7 novembre. Una lettera al padre in cui il figlio, interpretato Francesco Alberici, si mette di fronte a quell’uomo che per anni gli ha negato ogni confronto, eludendo in tal modo il confronto con sé stesso, un confronto scontro fra un figlio omosessuale e un padre ossessionato dal maschile, terrorizzato dalla consapevolezza di essere un perdente.
Il giovane scrittore torna al cospetto del padre che non vede da quando, quindicenne, aveva abbandonato il piccolo paese nel nord della Francia alla volta di Parigi, per fuggire da un’adolescenza di discriminazione e violenza e da piccola provincia omofoba e xenofoba quanto lo stesso padre. Ora i due sono lì, a qualche metro di distanza uno dall’altro in un grande spazio asettico e vuoto. Nel genitore, abbandonato anche dalla moglie, nel suo corpo di operaio invecchiato e vittima di un grave infortunio in fabbrica, si fanno largo stima e interesse per il figlio. Qualcosa è cambiato, perché? Una inattesa vicinanza che per Louis è e diviene anche un momento di riflessione sull’identità politica di un Paese sempre più a destra.
Il tornare da lui genera inizialmente nel ragazzo una rabbia sorda e profonda che cerca sfogo nei violenti calci dati a sacchi di spazzatura neri. Ma quei sacchi picchiati, calpestati e lacerati racchiudono i ricordi, raccontano il passato, l’infanzia, la spensieratezza e l’incomprensione, il baratro di una felicità non ottenuta. Louis si racconta, secondo un dialogo, per voce sola, tra l’esponente di classe operaia ormai condannata al declino ed il figlio omosessuale desideroso di far accettare la propria identità ad un padre ossessionato dal maschile e dalla consapevolezza di essere a sua volta un emarginato, un dominato, un perdente, proprio come le persone che più odia e a cui più teme di rassomigliare, gli arabi, le donne, gli effeminati. Ma è uno sguardo non più rabbioso, ma conciliante ed anche malinconico verso l’incapacità del padre a capire ed ad accettare, ma di certo non ad odiare. Si materializza così il VHS del film Titanic, regalo di compleanno chiesto da Eddy bambino al padre, che seccamente aveva risposto quanto fosse quello un film per femminucce, che non potevano essere dei regali da maschio e che se le cose stavano così, allora non avrebbe ricevuto alcun regalo. Tanta sofferenza ma anche la sorpresa di trovare poi la mattina del compleanno ai piedi del letto un bel cofanetto bianco, con su scritto “Titanic” in lettere dorate.
Il vero dramma non è pertanto la mancanza d’amore ma il dolore di non poter essere capiti da chi si ama per una sorta di buco culturale che non si colmerà mai. Il padre dello scrittore può soffrire per la sofferenza inferta al figlio e può soffrire perché ha fallito come marito, padre e lavoratore, perché non si è arricchito, non ha svoltato, non ha saputo dare un futuro sicuro alla sua famiglia, ma forse non capirà fino in fondo, con precisione, che il dolore di Edouard da grande, da figlio, da scrittore, sta soprattutto in questo dialogo mancante, nel suo sapere più di lui, che pure le ha subite sulla propria pelle, delle ingiustizie della vita.
Per la prima volta Deflorian/Tagliarini portano in scena un testo non scritto da loro, ma da un autore certamente affine alle tematiche trattate dai due registi ed interpreti, quali la relazione tra realtà e finzione o il rapporto tra individuo e società. Una drammaturgia performativa che guarda sempre di più alla letteratura. Tuttavia, è proprio la fedeltà al testo che permette di cogliere al meglio la qualità della drammaturgia scenica, fatta di sostanziali dettagli, di luci e respiri, di liason perfette ed efficaci tra scrittura ed interpretazione che permettono al bravissimo Francesco Alberici di raccontare il disagio familiare e generazionale in uno spazio sospeso e denso in cui riflettere.
data di pubblicazione:09/11/2021
Il nostro voto: 










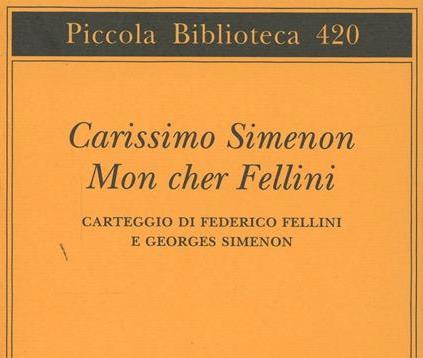









Gli ultimi commenti…