
da Giovanni M. Ripoli | Mar 30, 2022
Per eventi misteriosi e inconcepibili la luna esce dall’orbita terrestre e rischia di schiantarsi sul nostro amato pianeta con prevedibili disastrose conseguenze. Fortuna che la NASA vigila e prima di lei un appassionato cospirazionista, astronomo improvvisato. Si crea dunque un’improbabile “ammucchiata” di esperti e dilettanti che insieme all’ex astronauta Jo Fowler intuisce una soluzione e ahinoi ce la propina…
Se è vero che la prima scena di un film di azione targato USA può costare quanto un medio film di casa nostra, è altrettanto vero che, nel caso di cui trattasi , il livello di scempiaggini raggiunto è direttamente proporzionale ai costi. In generale, non sono incline alle stroncature, ma se, per errore, ci si imbatte in pellicole come Moonfall, l’etica professionale impone una severa censura e un affettuoso sconsiglio. La doverosa premessa non esclude naturalmente che ci siano state e ci siano pellicole di genere (fantascienza, disaster movies, fantasy, super eroi) pienamente riuscite e altamente spettacolari. Non così Moonfall, peraltro diretta da un buon artigiano come Roland Emmerich che senza essere Kubrick ci aveva regalato il godibile Indipendence Day.
Questa volta il pateracchio è completo e dal menù estraggo a caso pagine di complottismo che neanche un no vax, ansie artificiose che neanche Crepet…, teorie scientifiche che neanche Paperino sotto allucinogeni (la Luna, tutt’al più si allontana dalla terra…). Purtroppo non esagero nel segnalare che per due ore e dieci minuti, confortati – si fa per dire- da un commento sonoro assordante e distonico ci si sottopone alla visione di un campionario misto che va dall’incredulità, all’impossibile transitando per una ingenuità fanciullesca. Se quanto sopra non bastasse a dissuadervi da insani propositi (lo so, non è che al cinema ci sia tanto in questo periodo!), e sorvolando sulla trama per decenza, non posso che evidenziare lo scarso contributo dei poveri attori, il premio Oscar, Halle Berry e John Bradley, sbiaditissima copia del grande Paul Newman, immeritatamente coinvolti nella scombicchieratissima e irresponsabile sceneggiatura e incapaci di dare un sia pur minimo spessore ai personaggi. Ma, almeno gli effetti speciali? Non mancano e non oso pensare a quanto siano costati, ma sono lì anche loro come un corpo estraneo, confusi e slegati, roboanti ma poco coinvolgenti come purtroppo tutto il film.
data di pubblicazione:30/03/2022
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Jacolina | Mar 30, 2022
 Per singolare coincidenza, quasi a volersi scusare con i cultori di Simenon della “colpa” di aver recentemente dato alle stampe una raccolta di raccontini: Il capanno di Flipke che più che appunti di un grande scrittore sono da considerarsi invece solo veri e propri Scarti d’Autore o Avanzi di Cassetto, la casa editrice Adelphi si riscatta pubblicando ora un bel libro del nostro scrittore belga. Un libro già apparso in Italia nel 1964 nella celebre collana della Medusa. Questa volta si tratta di un vero Roman Dur o Roman Roman come amava definirli l’Autore stesso. Un vero romanzo scritto nel 1939, appartenente quindi, per periodo ed ispirazione, proprio alla stagione più creativa dello scrittore, quella che ha dato i migliori frutti letterari Il periodo in cui Simenon definisce magistralmente, libro dopo libro, il suo universo. Un mondo in cui ogni lettore poteva e può ancora identificarsi in una galleria di personaggi autentici, senza tempo e quindi universali. Poco importa che siano francesi, cittadini, paesani o come questa volta, piccoli professionisti di provincia, su tutti grava, ieri come oggi, il Destino da cui non si può sfuggire!
Per singolare coincidenza, quasi a volersi scusare con i cultori di Simenon della “colpa” di aver recentemente dato alle stampe una raccolta di raccontini: Il capanno di Flipke che più che appunti di un grande scrittore sono da considerarsi invece solo veri e propri Scarti d’Autore o Avanzi di Cassetto, la casa editrice Adelphi si riscatta pubblicando ora un bel libro del nostro scrittore belga. Un libro già apparso in Italia nel 1964 nella celebre collana della Medusa. Questa volta si tratta di un vero Roman Dur o Roman Roman come amava definirli l’Autore stesso. Un vero romanzo scritto nel 1939, appartenente quindi, per periodo ed ispirazione, proprio alla stagione più creativa dello scrittore, quella che ha dato i migliori frutti letterari Il periodo in cui Simenon definisce magistralmente, libro dopo libro, il suo universo. Un mondo in cui ogni lettore poteva e può ancora identificarsi in una galleria di personaggi autentici, senza tempo e quindi universali. Poco importa che siano francesi, cittadini, paesani o come questa volta, piccoli professionisti di provincia, su tutti grava, ieri come oggi, il Destino da cui non si può sfuggire!
Bergelon è un piccolo medico di quartiere in una cittadina di provincia. Coglie al volo l’allettante offerta di un suo collega più fortunato di intascare l’intero onorario previsto per la degenza del primo paziente che farà ricoverare nella clinica di lusso gestita dal collega e poi di dividersi metà e metà gli introiti dei successivi. Il mediocre Bergelon fa ricoverare una sua paziente prossima al parto. Purtroppo per colpa del collega che era ubriaco durante l’intervento, sia la puerpera che il neonato muoiono. Il giovane vedovo, venuto a conoscenza della realtà dei fatti, decide di vendicarsi su Bergelon per il cattivo consiglio. Il “dottorino” si sente responsabile e… fugge. Fugge senza una vera meta, fino ad Anversa… fugge dal rimorso della morte che ha causato… fugge dal marito assetato di vendetta… fugge soprattutto da una vita, la sua, segnata dalla mediocrità e dal fallimento professionale… fugge dalla sua famiglia… fugge per provare a cambiare vita, per sfuggire al Destino, o… almeno provarci! Ma … il “dottorino” apprenderà che nulla si può fare e che arriva sempre il momento in cui si devono pagare le proprie colpe! Apprenderà altresì che alcune punizioni sono ben peggiori della morte!!
Più che un noir Il Dottor Bergelon è un dramma psicologico, un racconto diretto ed oggettivo, scritto in modo magistrale con la solita bella prosa scorrevole, asciutta ed essenziale. Al centro di tutto è la provincia francese, eguale però a tutte le province quale che sia la loro latitudine o l’epoca. Un mondo fatto di aspirazioni frustrate e di mediocrità, un mondo sempre sospeso fra il sogno ed il bisogno di un cambiamento con le connesse illusioni e poi le amare rassegnazioni. Simenon ne riproduce i contesti esistenziali, le persone, i loro pensieri e le atmosfere con tocchi realistici e naturalistici. Da profondo conoscitore della natura umana, al di là dei fatti narrati, i suoi veri protagonisti sono gli animi e le coscienze dei vari personaggi. Coscienze che Simenon svela progressivamente con la sola forza della sua capacità analitica. Il romanzo delinea infatti una duplice analisi psicologica: da una parte quella di Bergelon sconvolto dalla presa d’atto della propria meschina esistenza e dello squallore di tutto il suo ambiente, dall’altra quella del giovane vedovo cui il dramma subìto innesca la constatazione del proprio fallimento esistenziale. Due crisi umane frutto della propria superficialità e fragile essenza.
Il Dottor Bergelon è un romanzo che risponde in pieno alla giusta fama che merita Simenon! Molto più di un giallo o di un noir! E’ una vera opera narrativa, un romanzo che si divora fino alla fine pur con una crescente sensazione di turbamento e di inquietudine, proprio come Simenon voleva che dovesse essere leggendo della Realtà.
data di pubblicazione:30/03/2022
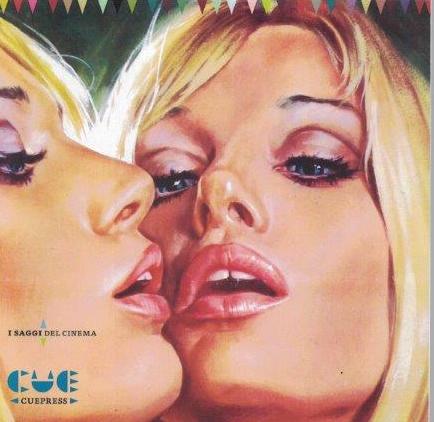
da Daniele Poto | Mar 29, 2022
 Quando c’erano le seconde e le terze visioni, una catena vasta di cinema porno, anche il cinema di serie B o C era preso in alta considerazione e si meritava delle recensioni che non erano semplici trafiletti sui principali quotidiani nazionali. Renato Palazzi si prestava a questo umile compito di filtraggio filmico sulla più diffusa testata nazionale e lo faceva senza sciatteria ma con un preciso senso del dovere, applicando le categorie estetiche che avrebbe utilizzato per una pellicola di Fellini o di Bunuel. Dunque questa è un’antologia vintage di un mondo che non c’è più, circoscritto alla commedia pecoreccia all’italiana, al filone del kung fu caro a Bruce Lee, alla moda dei poliziotteschi tutti eguali con registi e attori che ci hanno costruito sopra una discreta carriera. Carrellata sul film di genere e degenere con notazioni vintage che possono essere care a una generazione over. Libro di nicchia ma prezioso perché documenta un felice momento al botteghino perché c’erano film capostipite e modello che aprivano una lunga scia di imitazioni, con l’occhio mirato agli incassi. Sulla qualità si può discutere ma la quantità è indiscutibile. La sorpresa è trovare uno scrittore di vaglia come Daniele Del Giudice come autore di uno di queste non memorabili sceneggiature (si doveva pure campare, il film in questione è L’assassino è costretto a uccidere ancora, 1975). È anche vero che dall’horror ruspante dei Bava e dei Fulci è scaturito un maestro come Dario Argento. Così questo cinema marginale e residuale, nella rievocazione, acquista dignità e consistenza. E forse i nomi di Femi Benussi, Ria De Simone o Orchidea De Santis diranno qualcosa a un vasto pubblico di estimatori, direi soprattutto maschili. Corpi di attrice ma anche voci ed espressioni. Il sottotitolo ironico veicola il profilo basso dell’intenzione ma la scrittura di Palazzi è sempre controllata e inappuntabile. Onore al merito.
Quando c’erano le seconde e le terze visioni, una catena vasta di cinema porno, anche il cinema di serie B o C era preso in alta considerazione e si meritava delle recensioni che non erano semplici trafiletti sui principali quotidiani nazionali. Renato Palazzi si prestava a questo umile compito di filtraggio filmico sulla più diffusa testata nazionale e lo faceva senza sciatteria ma con un preciso senso del dovere, applicando le categorie estetiche che avrebbe utilizzato per una pellicola di Fellini o di Bunuel. Dunque questa è un’antologia vintage di un mondo che non c’è più, circoscritto alla commedia pecoreccia all’italiana, al filone del kung fu caro a Bruce Lee, alla moda dei poliziotteschi tutti eguali con registi e attori che ci hanno costruito sopra una discreta carriera. Carrellata sul film di genere e degenere con notazioni vintage che possono essere care a una generazione over. Libro di nicchia ma prezioso perché documenta un felice momento al botteghino perché c’erano film capostipite e modello che aprivano una lunga scia di imitazioni, con l’occhio mirato agli incassi. Sulla qualità si può discutere ma la quantità è indiscutibile. La sorpresa è trovare uno scrittore di vaglia come Daniele Del Giudice come autore di uno di queste non memorabili sceneggiature (si doveva pure campare, il film in questione è L’assassino è costretto a uccidere ancora, 1975). È anche vero che dall’horror ruspante dei Bava e dei Fulci è scaturito un maestro come Dario Argento. Così questo cinema marginale e residuale, nella rievocazione, acquista dignità e consistenza. E forse i nomi di Femi Benussi, Ria De Simone o Orchidea De Santis diranno qualcosa a un vasto pubblico di estimatori, direi soprattutto maschili. Corpi di attrice ma anche voci ed espressioni. Il sottotitolo ironico veicola il profilo basso dell’intenzione ma la scrittura di Palazzi è sempre controllata e inappuntabile. Onore al merito.
data di pubblicazione:29/03/2022

da Antonio Jacolina | Mar 28, 2022
Dicevamo che è dopo le nomination che si delinea lo scenario reale per il vero rush finale e che è solo allora che il gioco si fa veramente duro e … può anche capitare allora che la pulce vinca sui grandi favoriti … Tutto come previsto! Nulla come previsto! Si sa che i voti dell’Academy spesso non tengono conto né delle graduatorie di merito formulate dalla Critica Internazionale né degli apprezzamenti del Pubblico nelle sale cinematografiche. Mai però come questa volta le valutazioni tecniche, razionali od emotive, le illusioni o le aspettative del cuore sono state così disattese. Questa 94ma edizione degli Oscar attenta alla necessità dell’Industria Cinematografica di recuperare consensi di pubblico dopo i devastanti effetti della Pandemia si è difatti, più che mai, appiattita sul politically correct dando un contentino a tutte le sensibilità.
Quindi … più che un premiare la qualità è stato un voler premiare le opportunità!
Ecco allora che Miglior Film risulta CODA di Sian Heder, piccolo film indipendente che è solo il remake americano del fortunatissimo film francese del 2014 La famiglia Bélier. Un film delicato che tocca i sentimenti, un feeling good movie … Il solo riproporre con sensibilità la storia della giovane ragazza che aspira a cantare e della sua famiglia sordomuta può però far vincere anche l’Oscar per Migliore Attore Non Protagonista e quello per la Migliore Sceneggiatura Non Originale! Addirittura tre Oscar! Troppa grazia! Rivedetevi l’originale francese!
Delle sue 12 nomination, quello che era il vero grande preferito, il western anomalo e psicologico di Jane Campion: Il Potere del Cane si aggiudica solo il premio per la Migliore Regia, mentre lo spettacolare Dune con ben 10 nomination altrettanto qualificanti si merita invece solo 6 “Premi Minori”, premi prettamente tecnici. L’accreditatissimo, tenero ed autoriale Belfast di Branagh con 7 candidature si prende la sola statuetta per la Migliore Sceneggiatura Originale e … il grande sconfitto, lo Spielberg del bel remake di West Side Story con 7 candidature anche lui, porta a casa solo quella per la Migliore Attrice Non Protagonista.
Il resto delle candidature? Il resto è silenzio! Ma allora che senso hanno le nomination?
Le nuove regole hanno generato un eccesso di candidature, un’inflazione di nomination che può probabilmente tornar molto buona per promuovere la distribuzione di più film nelle sale ma di certo non giova nella definizione della pari qualità della rosa finale e poi dei premiati.
Jessica Chastain ha meritatamente ottenuto il premio come Miglior Attrice per la sua esuberante ma buona interpretazione de Gli occhi di Tammy Faye e così anche Will Smith quello di Migliore Attore per il volitivo padre delle sorelle Williams ne Una Famiglia Vincente.
Quanto poi al Miglior film Straniero, purtroppo per il Cinema Italiano, il film di Sorrentino non ce l’ha fatta, e … senza l’aiuto della mano di Dio, l’Oscar è stato assegnato al profondo e sensibile film giapponese Drive my Car, di sicuro il più favorito che, d’altra parte, concorreva anche per la Migliore Regia ed il Miglior Film.
Le altre presenze italiane per i costumi di Cyrano e per il piccolo film d’animazione Luca non hanno avuto la giusta fortuna.
Oscar 2022, un’edizione da non ricordare fra le migliori. Con dei film premiati che non verranno di certo ricordati o che non hanno assolutamente meriti superiori agli altri concorrenti. Verrebbe da farsi qualche domanda provocatoria, ma limitiamoci solo a segnalare: che con L’Oscar a Jane Campion sono arrivate a ben tre le registe donna premiate; che non c’è stato il previsto trionfo di Netflix; che a 60 anni di distanza West Side Story porta a vincere lo stesso ruolo di attrice non protagonista, e che CODA a fine Gennaio non era stato giudicato idoneo per uscire in sala ma solo in DVD!!
data di pubblicazione:28/03/2022

da Rossano Giuppa | Mar 27, 2022
(Teatro India – Roma, 19/27 marzo 2022)
Un corpo di legno mutilato giace in proscenio mentre i suoi pezzi sono sparsi e in parte bruciati. La catarsi è dura e dolorosa: quale è il percorso per diventare essere umani? Una partitura di canto e suono dal vivo liberamente ispirata al burattino di Collodi è il nuovo lavoro del Teatro Valdoca in scena al teatro India di Roma dal 19 marzo, Enigma. Requiem per Pinocchio (foto Simona Diacci Trinity).
Un canto malinconico e una voce ancestrale guidano la riscrittura della vicenda di Pinocchio secondo i versi originali scritti da Mariangela Gualtieri, all’interno di un panorama onirico che vede al centro due attrici portentose nella loro bravura e particolarità, Silvia Calderoni e Chiara Bersani, alla quale la Gualtieri dal vivo presta la voce e il corpo espressivo, potente e leggero di Matteo Ramponi enfatizzato dal canto di Silvia Curreli ed Elena Griggio, e dal suono di Enrico Malatesta, Attila Faravelli, Ilaria Lemmo. Un’opera che Cesare Ronconi disegna alla perfezione su tutti gli interpreti, in totale armonia esaltandone le unicità.
Silvia Calderoni, straordinaria e sensibile interprete, è il burattino curioso e triste che deve percorrere il suo sentiero di crescita. Inoltre in scena c’è una fata totalmente fuori dagli schemi, Chiara Bersani e la sua fisicità poetica e c’è la forza gentile di Mangiafuoco, Matteo Ramponi.
Si affronta il tema dell’infanzia in cui la mente è brillantissima e pura ed il passaggio all’adolescenza, quando il corpo comincia ad avere una potenza sfrenata che si contrappone al senso.
Ma come si può fare per preservare l’essenza dell’infanzia? La strada forse è quella di seguire il mantra meditativo formulato dalla Fatina e dal suo femminile potente e magico, mentre un maschile ammutolito, forte come un Mangiafuoco, lo sostiene e lo diffonde nell’aria.
Pinocchio viene ad immunizzarci dalla paura della morte, ad insegnarci la speranza e la rinascita.
Ancora una volta il Teatro Valdoca ci sorprende per unicità ed attualità del suo messaggio, grazie al suo sguardo mai banale sul passato ed il futuro, sul senso della fisicità, sul valore della parola, del gesto, degli oggetti, della luce, sulla natura dell’uomo.
data di pubblicazione:27/03/2022
Il nostro voto: 

da Antonio Jacolina | Mar 25, 2022
Il lato oscuro del Mondo dell’Arte! Il “dietro le quinte” dell’incredibile storia del Salvator mundi: un quadro di Leonardo, oppure attribuibile a Leonardo, o alla sua Scuola, o una copia o, magari, un falso! Tutto e niente! Un’avventura che parte da New Orleans nel 2005 ove viene acquistato per poco più di 1000 dollari fino ad essere poi rivenduto da Christie’s nel 2017 a ben 450 milioni di dollari. Da allora è nuovamente scomparso nel nulla: forse nelle mani di un principe arabo, che, forse è l’erede al trono Saudita …
Presentato con positivi giudizi all’ultima Festa del Cinema di Roma, arriva finalmente sugli schermi cinematografici una storia che, se fosse stata inventata da uno sceneggiatore, potrebbe apparire eccessiva ed assurda, ma che, invece, racconta una vicenda tratta direttamente dalla realtà. Una storia che è un mix di dubbi ed intrighi che coinvolgono personaggi inverosimili: cacciatori d’opere d’arte, falsari, mercanti, restauratori, direttori di grandi musei, critici ed esperti, media internazionali, finanzieri, oligarchi russi e poi la politica internazionale. Giochi di Potere, geopolitica post petrolifera, orientamento delle masse e gli Arabi. Colpi di scena, doppi e tripli giochi, l’FBI ed anche la CIA.
Un affascinante ed insolito documentario girato dal danese Koefoed come fosse un vero film: un vero heist thriller movie che, al di là delle vicende narrate, vuole anche denunciare il cinismo di un potere che per i propri fini si avvale, ancora una volta, persino del bello, dell’arte, e della storia della nostra civiltà. Il film è un racconto vivo e coinvolgente che, come un lungo filo, parte da New Orleans e si snoda per New York, la National Gallery di Londra, passa per Parigi, Ginevra, di nuovo al Louvre, poi le più prestigiose Case d’Asta per perdersi infine … di nuovo nel buio … forse in un bunker, in un “porto franco”, forse in … un mare di dune di sabbia.
Il ritmo narrativo usato dal regista è sempre incalzante, vivace, incisivo, mai tedioso o eccessivo. Riesce a tener viva la curiosità e il dubbio con continui colpi di scena narrativi, combinando sapientemente interviste, belle riprese originali e filmati d’epoca. Così facendo, l’autore esamina tutti i possibili punti di vista svelando le sfaccettature del mistero o della truffa. Il viaggio del Leonardo perduto subito dopo essere stato “ritrovato” diviene così un’interessante, emozionante odissea fra arte, commercio, mistificazione, avidità, finanza, speculazione e politica.
La fondatezza o meno dell’attribuzione, i misteriosi movimenti di denaro, sono misteri, dubbi affascinanti già di per se. Se poi si trovano combinati tra loro in un contesto ambiguo, attraversando una storia lunga 15 anni (dopo ben 600 anni di silenzio e buio assoluto), è evidente quanta abbondanza di materiale ci sia per dare spazio alle fantasie più fervide ed all’affascinazione filmica. Ne risulta, infatti, una buona realizzazione cinematografica, accattivante, ricca di suspense, interessante e coraggiosa, che combina intelligentemente ironia, sarcasmo e serietà. Una storia che coinvolge gli intervistati (liberi di essere se stessi) e gli spettatori (anche i più informati dei fatti).
Perché, alla fine, le persone credono perché hanno bisogno di credere che qualcosa sia vera! Il fatto he poi non lo sia, in fondo, non ha più alcuna importanza. L’evento diviene un Mito perché serve sempre un Mito!
data di pubblicazione: 25/03/2022
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Mar 25, 2022
Benedetta ha 15 anni: scontrosa, cicciona e piena di brufoli. Vive nella periferia romana, in una famiglia con tante aspirazioni fallite che la copre di attenzioni e dice di volerle bene, anche se tutto ciò ha il sapore di un atto dovuto. Un giorno conosce Amanda, trans che ufficialmente si guadagna la vita in un parco giochi ambulante. Da questo incontro casuale la ragazza inizierà a coltivare maggiore stima di sé e imparerà a emanciparsi, lasciandosi alle spalle un’adolescenza grigia e priva di qualsiasi prospettiva.
Chiara Bellosi con Calcinculo è al suo secondo lungometraggio dopo Palazzo di Giustizia, sua opera prima. Presentato all’ultima Berlinale, nella Sezione Panorama, il film già accolto favorevolmente in quella sede è arrivato finalmente in sala. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio percorso di formazione perché Benedetta, la protagonista, a seguito di un incontro fortuito con Amanda, si troverà repentinamente a passare da una fase adolescenziale a quello di una donna matura capace di guardare la propria fisicità con un tratto diverso, proiettandosi verso un futuro nuovo. La regista parla della vita vera utilizzando un linguaggio cinematografico asciutto, dove non c’è spazio per situazioni artificiose, costruite e prive di qualsiasi substrato reale.
L’incontro con Amanda, trans privo di qualsiasi retorica morale ma genuino nell’esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni, sarà determinante per la crescita della ragazza: Benedetta imparerà a guardarsi con un occhio diverso e soprattutto a capire da sé che anche lei può essere oggetto di attenzione, lasciandosi alle spalle la percezione di essere brutta e grassa a confronto delle sue due graziose sorelline e di quella madre, mancata ballerina, presenza ingombrante con cui è costretta a confrontarsi ogni giorno.
Il film riesce a trattare con raro equilibrio un tema che poteva risultare banale, evitando situazioni eccessive o compiacimenti morbosi, sussurrandoci all’orecchio cose vere e importanti in tono amichevole e confidenziale, senza note dissonanti o tragiche. L’esordiente Gaia Di Pietro (Benedetta) appare molto sicura nel suo ruolo accanto ad un bravissimo Andrea Carpenzano, diventato un attore molto conosciuto dal pubblico italiano che imparò ad apprezzarlo al suo esordio a Berlino nel 2018 come protagonista ne La terra dell’abbastanza dei fratelli D’Innocenzo.
A parte il titolo poco felice che in realtà potrebbe indicare la giostra dove la ragazza inizia a prendere visione della vita o, metaforicamente, ci suggerisce che si cresce anche a calci nel sedere, Calcinculo merita sicuramente un’attenzione particolare e per questo se ne consiglia la visione.
data di pubblicazione:25/03/2022
Scopri con un click il nostro voto: 

da Daniele Poto | Mar 20, 2022
(Teatro Quirino Gassmann – Roma, 16/28 marzo 2022)
Farsa evergreen con efficace adattamento italiano. La Quattrini vicina agli 80 anni è il trait d’union con la gloriosa storia di uno degli spettacoli di punta della Premiata Ditta Garinei & Giovannini.
Immaginate una commedia di Feydeau riattualizzata per un pubblico borghese dei nostri tempi. Munitevi di una bacchetta magica e riesumate la pochade trenta o quaranta anni dopo i fasti della prima al Sistina. Funziona lo stesso e con vivacità scoppiettante. Tra giochi di porte, scambi di coppie, equivoci, l’ammiccamento al politicamente scorretto sui gay. E con palesi luoghi comuni (il politico con aspirazione all’adulterio, la bonona che non si fa troppi scrupoli, la moglie ancora vogliosa, il portaborse a tutto pronto) rivitalizzati dalla verve degli affiatatissimi attori tra cui non sfigura, nonostante chiari limiti, la stessa Barale. Catania si conosce: un gattone pronto a giocare di rimessa. Ramazzotti è un guastatore comico capace anche di notevoli contorsioni fisiche, vera anima dello spettacolo, oltre che abile manipolatore del progetto originale. E la Quattrini con la sua aria disincantata da oca giuliva (ma fino a un certo punto) che mette a segno zampate esulceranti. Così la mayonese non impazzisce ma si posa su un tessuto di spettacolo divertente e arioso con le brave caratterizzazioni di Marco Cavallaro e Alessandro D’Ambrosi. Contribuisce alla riuscita l’indefettibile scenografia. Un parallepipedo girevole che ci porta all’interno dell’intimità delle stanze da letto fino alla reception, nodo di snodo dei complessi intrighi della piece. La saga di questa commedia porta a raffronti generazionali. Il ruolo della Barale è stato sostenuto in passato da Gloria Guida e Anna Falchi e le motivazioni estetiche sono di facile decifrazione. Era dal 2000 che il progetto originario non veniva ripreso e il riprovarci più di venti anni dopo è segno di calcolato coraggio.
data di pubblicazione:20/03/2022
Il nostro voto: 

da Antonio Jacolina | Mar 19, 2022
1973, S. Fernando Valley, due adolescenti – Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour) – si incontrano il giorno della foto per l’annuario scolastico. Lontani per età e per carattere, si confrontano, si attraggono, si respingono, si sfuggono, si cercano. Corrono, corrono e si rincorrono, crescono muovendo i primi passi nel mondo degli adulti. Archetipi di vita, di bellezza e di libertà in un ricordo agrodolce…
Nuovamente candidato all’Oscar, questa volta con tre nomination (Miglior Film, Migliore Regia, Migliore Sceneggiatura Originale), P.T. Anderson, regista, sceneggiatore ed anche direttore della fotografia è, a poco più di 50 anni, un Maestro del Cinema. In assoluto uno dei migliori autori del “Nuovo Cinema Americano”: suoi Magnolia, Il Petroliere, The Master ed Il Filo Nascosto.
Questo suo 9° lungometraggio porta con sé il profumo, appena velato di nostalgia, della giovinezza. Nei suoi 25 anni di carriera e di successi il regista non ha mai cessato di diversificarsi e cimentarsi con nuovi temi, seri o leggeri che siano. Il filo nascosto della sua filmografia resta però pur sempre l’analisi dei sentimenti, la ricerca costante da parte dei suoi personaggi del senso del loro esistere e del doversi confrontare con “l’Altro” rispetto a se stessi.
Il piano sequenza iniziale cattura subito lo spettatore e dà immediatamente il tono e la misura di questo nuovo bel film. La cinepresa gioca con virtuosità attorno ai due ragazzi, li osserva, li scruta, si intreccia e li intreccia fra loro. Il regista fissa così l’istante, l’attimo atemporale in cui, fra esitazioni, silenzi e contraddizioni, tutto nasce e si determina così il Futuro. Un futuro di cui noi spettatori saremo di lì in poi osservatori privilegiati.
Da quell’istante i due splendidi volti nuovi del cinema resteranno nel cuore della storia, perdendosi, ricercandosi e passandosi il centro della scena in un gioco alternato. Di lì in poi il regista, fra apparenti divagazioni bozzettistiche, procede in realtà dritto alla meta per elissi, con magistrali suggestioni in cui il non detto, il piccolo gesto, valgono più di grandi discorsi. In pochi secondi P.T. Anderson dice allo spettatore ciò che altri cineasti a malapena dicono in 90 minuti!Il risultato è un film di inaspettata delicatezza.
Il regista, si sa, ama gli Anni ‘70 ma questa volta, libero da influenze pregresse di altri grandi autori (Altman, Scorsese…), ci regala un innocente ricordo di un’epoca e di una certa America.
Una fotografia ultra sofisticata, un uso sapiente del colore, delle luci e delle inquadrature, ambientazioni e messe in scena perfette, giochi della cinepresa, ritmo e montaggio rapido delle sequenze, una splendida e coinvolgente colonna sonora, un casting perfetto, danno al lavoro uno spessore ammirevole di autenticità e di verità, ben lontano da ogni nostalgica rivisitazione.
Davvero un bel film!
Un film dolce e paradossale: dolce per la freschezza della storia, pulita, leggera, romantica e vintage; paradossale per la maestria del regista pur nella splendida semplicità del suo universo cinematografico.
La giovane coppia è un’assoluta rivelazione. Sotto la direzione di Anderson i due ragazzi diventano sempre più bravi con il procedere del film. Un’autentica sincerità recitativa al servizio assoluto della storia.
Il resto del casting ha, fra i secondi ruoli, anche stelle del calibro di Bradley Cooper, di Tom Waits e di Sean Penn, che ci restituiscono con sensibilità, pur nelle caratterizzazioni, squarci del mondo hollywoodiano degli anni ’70 e di un’America perpetuamente minacciata dalle nevrosi.
Licorice Pizza – dal nome di una catena di negozi di dischi, di moda all’epoca – è la sintesi dell’estetica visiva di Anderson ed è anche un film molto buono, appena mascherato da teen-movie. Un film solare e tenero, una delicata commedia che ci restituisce, nello spirito di quegli anni, l’innamoramento di una giovane coppia e, soprattutto, il saper fare Cinema.
Un film di un grande Autore, alla cui capacità narrativa dobbiamo abbandonarci, apprezzandone il risultato di alta qualità, portando poi con noi quella tonificante sensazione di energia giovanile, di libertà e di sogni che lo pervade tutto. Vero Cinema!
Potrebbe anche non entusiasmare tutti, ma ben vengano allora questi film che generano un costruttivo confronto di opinioni.
data di pubblicazione:19/03/2022
Scopri con un click il nostro voto: 

da Rossano Giuppa | Mar 18, 2022
(Auditorium Parco della Musica – Roma, 15/20 marzo 2022)
In scena alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma in prima nazionale L’attesa per la regia di Michela Cescon con in scena Anna Foglietta e Paola Minaccioni. Due donne, una nobildonna ed una domestica, Cornelia e Rosa, condividono una convivenza forzata ed indesiderata. La nobile deve nascondere agli occhi di tutti una gravidanza conseguenza di un rapporto occasionale, ha un matrimonio in vista, siamo nel ‘700, e non ha alternative. Anche la serva è nelle medesime condizioni ed ad entrambe tocca l’isolamento. La separazione dall’esterno è dura, il tempo è immobile, mentre i corpi si modificano.
Michela Cescon dopo essersi misurata nella sua prima regia teatrale con la trasposizione scenica dell’ultimo romanzo di Alberto Moravia La donna leopardo, sceglie di portare in scena L’Attesa di Remo Binosi, testo che ha fatto conoscere l’autore veneto al grande pubblico, permettendogli di conquistare il “Biglietto d’oro Agis” come migliore novità teatrale italiana nel 1994.
Il dramma è costruito attorno a due donne che vengono allontanate e rinchiuse per nove mesi per nascondere una gravidanza. Si racconta una clausura, un’impossibilità ad uscire e vivere, una condivisione non solo di spazi quasi claustrofobici, ma anche di dolori e sentimenti. In tale contesto il gioco isterico padrona serva non può reggere a lungo, gli equilibri pian piano si ribaltano, la debolezza e la forza si alternano e si annientano a vicenda mentre l’elaborazione del dolore condiviso diviene l’elemento che dà forza ad entrambe, soprattutto quando poi si scopre di essere molto più simili di quanto si potesse inizialmente immaginare. L’affetto che le lega allora diventa profondo.
Il testo di Binosi ha una grande forza drammatica e di coinvolgimento e nonostante l’azione sia ambientata in un’epoca lontana i temi e i contenuti sono estremamente attuali. La mano registica della Cescon segue con attenzione l’evoluzione del rapporto tra le due donne e la loro distanza sociale, lavora sulla diversa fisicità tra l’essere serva o padrona, ricostruisce la dignità delle due donne attraverso l’accettazione del dramma comune: il colpevole seduttore Casanova, la negazione e accettazione della maternità, la sofferenza del parto, il legame morboso che alla fine le unisce.
Le straordinarie Anna Foglietta e Paola Minaccioni sono semplicemente vere, emozionano. Il linguaggio è originale e sorprendente, desrammatico ma con naturali sprazzi di vis comica che coinvolgono.
Costumi, luci e allestimento enfatizzano ancora di più questo racconto tutto al femminile, un racconto sul corpo femminile e sulla punizione per il desiderio, un racconto sulla forza di scoprirsi madre, amica, complice, donna.
data di pubblicazione:18/03/2022
Il nostro voto: 





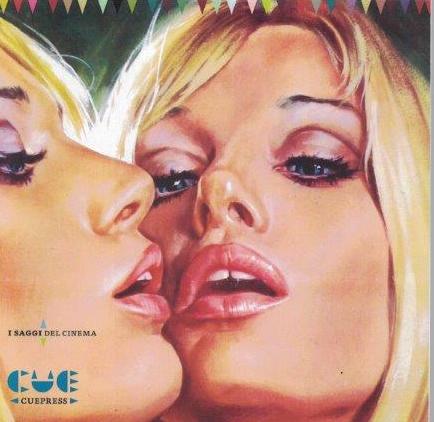














Gli ultimi commenti…