
da Antonella Massaro | Apr 16, 2015
Una commedia con sfumature noir, tenuta insieme dal collante del grottesco e dalle camaleontiche capacità di Micaela Ramazzotti (e di Libero De Rienzo). Questi, in breve, gli elementi caratterizzanti di Ho ucciso Napoleone, secondo lungometraggio diretto da Giorgia Farina, che torna in sala a distanza di due anni da Amiche da morire.
Anita (Micaela Ramazzotti), figlia del disinvolto modello pedagogico dei “genitori-amici” di matrice sessantottina, ha cura di nascondere le proprie debolezze dietro la corazza protettiva di un “sofficino surgelato”. La sua tanto ostentata quanto poco credibile anaffettività, della quale farà le spese anche (e soprattutto) quel Napoleone il cui epitaffio, pronunciato direttamente dal suo carnefice, risuona nel titolo del film, diviene l’elemento catalizzatore di un’ascesa lavorativa apparentemente inarrestabile, condita da tutti i più irrinunciabili cliché del caso: dall’odio dei colleghi per la bella e giovane donna in carriera, alla relazione con il capo sposato e con prole (Adriano Giannini), per concludere con l’altrettanto immancabile gravidanza frutto di imperdonabile disattenzione.
Costretta inaspettatamente ad abbandonare i lussuosi locali della casa farmaceutica per la quale lavora, Anita cerca di riorganizzare la propria vita dalle altalene dal parco di fronte, divenute l’ufficio della “spacciatrice di farmaci” Olga (Elena Sofia Ricci) e il crocevia del nutrito “pacchetto clienti” di quest’ultima (tra cui Gianna, interpretata da Iaia Forte). Il ponte tra “fuori” e “dentro”, attraverso il quale riprendere la poltrona che sente di meritare, sembra esserle gettato da Biagio (Libero De Rienzo). Ma le storie, si sa, possono sempre essere raccontate da più prospettive e quel cambio di soggettiva, che lo spettatore del cinema più recente (per quanto il parallelismo possa sembrare azzardato) ha avuto modo di sperimentare con L’amore bugiardo di David Fincher, rappresenta certamente uno degli elementi meglio riusciti della scrittura di Giorgia Farina e di Federica Pontremoli.
Il rovesciamento di fronte, indubbiamente repentino, pur non peccando di eccessivo senso dell’irrisolto, non pare fondarsi su un solido approfondimento dei personaggi, i cui tratti più complessi restano solo abbozzati e, in definitiva, risolti e “sviliti”, tanto per Anita quanto per Biagio, nel davvero troppo stereotipato rapporto tra genitori e figli. Anche il contorno dei personaggi secondari, dotati di buone potenzialità nella definizione del registro narrativo di tipo comico-grottesco, resta solo sullo sfondo, senza mai divenire autentica parte integrante del racconto. La cura per l’intreccio sfuma poi nel finale in perfetto stile “e tutti vissero felici e contenti nella famiglia allargata”, che, forse, risulta fuori contesto rispetto allo “spirito” che fino a quel momento sembrava aver ispirato il racconto.
Ho ucciso Napoleone rimane comunque una pellicola dalla quale traspare chiaramente la costante ricerca di uno stile, personale e riconoscibile, di una sceneggiatrice e regista, che merita appieno il titolo di “osservata speciale” nell’ambito del cinema italiano fatto dalla generazione anni Ottanta.
data di pubblicazione 16/04/2015
Scopri con un click il nostro voto: 

da T. Pica | Apr 13, 2015
(Teatro dell’Orologio – Roma, 7 aprile 2015 / 19 aprile 2015)
In questa primavera teatrale più Adamo & Eva di Mauro Santopietro per tutti! Un’Opera ben strutturata, una miniatura del Paradiso e del rovinoso allontanamento della coppia per antonomasia da Dio alla scoperta della Terra che incanta per le luci di scena, i colori, la scenografia e le musiche. Mauro Santopietro si conferma Attore e Regista di spessore della scena romana e non solo. Nel primo dei sette quadri che compongono Adamo & Eva siamo avvolti dall’aria rarefatta di soffici nuvole bianche e tra l’atmosfera candida e fumosa ecco le altalene fatte di funi – che poi altro non sono che i timori, i tabù, la proiezione delle complessità interne a ciascun individuo, sempre pronti a frenare l’uomo, rallentarne l’azione, la passione, l’iniziativa anche sottoforma di alibi – e poi mele, tante mele invitanti e succose sparse ai piedi dei dondoli fluttuanti. Siamo nell’Eden e subito è chiaro che fin “dai tempi di Adamo e Eva” la donna era, “ovviamente”, l’elemento passionale, curioso, ribelle, talvolta fastidioso e sciocco, imprudente e tentatore al quale si contrapponeva la razionalità, la prudenza, talvolta codarda, la cultura e l’intelligenza dell’uomo. Questa diversità, questa stereotipata distribuzione dei ruoli viene continuamente ribaltata nel passaggio da un quadro all’altro del viaggio spazio temporale con cui i due protagonisti, allontanandosi dal Paradiso, vivono il loro rapporto attraversando epoche storiche lontanissime ma al contempo incredibilmente vicine sotto il profilo della relazione uomo-donna. Dall’età delle Crociate, passando per l’Amor Cortese e la Rivoluzione Industriale fino ai giorni nostri uomo e donna, Adamo e Eva, sono due universi che si attraggono e respingono con pari forza: incomunicabilità da cui nascono incomprensioni e costanti interrogativi sul significato di “Amore”. Questo è il tema di fondo, il grande interrogativo che non trova risposte cristallizzabili in nozioni enciclopediche. Nonostante Eva offra ad Adamo un’impeccabile declinazione del significato di Amore, il senso continua ad essere inafferrabile. Ciò che invece appare una verità ineluttabile è che l’Amore non è eterno e che il matrimonio finisce con il rendere l’Amore una mela marcia minata dall’abitudine. Eva (una bravissima Alessia Giangiuliani), incantevole ed emozionante nel suo splendido abito di sposa bohémien che si infanga sotto la pioggia (compresa la “pioggia” miserevole che sgorga dalla bocca di Adamo, ma anche da quella di Eva), incarna tutte le donne: sognatrice, curiosa, romantica, generosa, fragile, forte e sempre risolutiva si scontra con un Adamo che non ha sentimenti ma passioni mutevoli in funzione del fluttuare delle sue fugaci sensazioni, dei suoi obiettivi primari e che, come tutti gli uomini, recrimina il suo spazio: bisogna lasciargli aria. Se Eva è assetata di conoscenza, se vuole capire trovare un senso per poter amare e costruire, Adamo, accecato dalla sola conoscenza accademica e scientifica, qualunque sia il contesto storico, ha una sola certezza: praticità, che spesso sfocia in semplicismo, e insofferenza quando dibatte con Eva perché ci sono sempre troppe parole, troppe parole inutili. E così, mentre ogni spettatore ha rivissuto, o sta rivivendo, su quel palcoscenico le proprie fragilità, una parte di se stesso e qualche tassello della propria vita di e in coppia, Adamo e Eva ricorrono al piano B, ovvero al divorzio: Eva “placa” le proprie domande e la sete di conoscenza arrendendosi alla vita terrena e, in attesa della morte, alleggerisce la mente dai suoi incessanti pensieri complessi dedicandosi a cure beauty e a letture “impegnate”; Adamo, invece, lasciato finalmente libero nel suo spazio punta verso l’infinito per morire tra le nuvole senza però apparire del tutto convinto e appagato dalla sua egoistica ricerca megalomane. Due universi apparentemente (ed eternamente?) inconciliabili destinati a rimanere soli? A ciascun Adamo spettatore e a ciascuna Eva spettatrice l’ardua risposta. Da non perdere!
data di pubblicazione 13/04/2015
Scopri con un click il nostro voto: 

da T. Pica | Apr 12, 2015
(Teatro dell’Orologio – Roma, 8 aprile 2015 / 19 aprile 2015)
Sulla scia del boom dei talent show dei fornelli va in scena al Teatro dell’Orologio la pièce Note di cucina che già in tempi non sospetti, lontani dalle luci della ribalta televisiva, aveva colto nella “cucina” – intesa come luogo di confronto/scontro e come vera e propria “arte” – la forza attrattiva, come una sorta di inconscio riconoscimento, che essa esercita sull’essere umano, donna o uomo che sia. La voce narrante, e non solo, del bravissimo Giorgio Carducci, avvolto nella sua impeccabile mise elisabettiana, introduce i quattro protagonisti, ma non prima di aver scrupolosamente ricordato a tutti il decalogo delle regole della buona tavola. E dalla “tavola” da cui tutto ha avuto inizio – che lascia presagire un incontro di commensali rievocativo della tavolata, con i suoi altrettanto bizzarri scambi di battute esistenzialistiche, della pellicola di Patroni Griffi Metti, una sera a cena – inizia il dialogo, o presunto tale, tra due uomini (Giancarlo Fares e Alessandro Porcu) e due donne (Sara Valerio e Mariasilvia Greco), cuochi e commensali al contempo. Uno dei due uomini si presenta affermando Io sono Stupido e subito si innesca un ritmato “doppio” di affermazioni, domande, risposte: tutte si rincorrono riflettendo la complessità dell’animo umano. Si susseguono riflessioni sulla vita, sulla società, sulla desolazione dell’anima, sul successo e l’affermazione del singolo, sul guadagnarsi la vita, sul senso della vita: annegare nella vita per qualcuno dei “cuochi” ha un’accezione positiva e si contrapporrebbe al negativo ed “affannoso” stare a galla; per altri invece annegare nella vita non è sinonimo di vitalità, passione, né vuol dire assaporare tutti i sapori e gli odori delle sfumature che la vita offre bensì altro non è che lo smarrimento di chi rimane fermo, e succube degli eventi senza sapere cosa fare, quale strada prendere. Ognuno percepisce e vive le cose in modo diverso. Il mondo è una trappola e ogni strada è sbagliata. Ad ogni nato è stato abortito il diritto di non nascere: i quattro protagonisti, durante un surreale banchetto di nozze sviscerano un dialogo che spesso diviene un “corale monologo” come individuale flusso di coscienza che li accomuna sovrapponendone i pensieri, i timori, i sogni infranti. Il tema della famiglia, della scuola, della precarietà, dell’amore e del rapporto di coppia e con i figli. I capisaldi della società sono affrontati con tratto forte, spregiudicato e ironico da Rodrigo Garcia con incredibili picchi di humor, paradossi e venature amare. In particolare, davvero spassoso e irresistibile è il “quadro” del papà (un bravissimo Giancarlo Fares) che denuncia la scuola, composta dai parassiti dell’educazione, e decide di far crescere suo figlio in “modo sano”, lontano dall’odore di famiglia – fatto di latte, miele, pane, marmellata – portandolo ogni mattina a fare una colazione a base di vermut, ma con olive, e Campari così trascorrerà le ore in classe ridendo continuamente senza ascoltare e “immagazzinare” l’educazione demenziale. Altrettanto acuto e tagliente è la proposta/organizzazione con epilogo finale di una cena “speciale” – Maxim’s di Parigi o dallo Zozzone?-. Visionarie ricette, come in una gara a chi è più bravo quantomeno nel destare meraviglia nei commensali – come la visionaria e iperbolica progettazione/competizione di un banchetto matrimoniale – “pepano” qua e là il testo dello spettacolo insieme all’incantevole voce dell’“elisabettiano” narratore che regala intermezzi musicali d’autore con la giusta ironia.
Da assaggiare e assaporare fino all’ultima goccia amarognola del no sense addolcita dal liuto di Simone Colavecchi.
data di pubblicazione 12/04/2015
Il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Apr 11, 2015
Di questa dissacrante commedia a carattere storico, vogliamo solo ricordare alcune frasi celebri dell’indimenticabile Alberto Sordi nelle vesti del Marchese Del Grillo, molto più dirette ed esplicite di un nostro breve ricordo: “Mi dispiace, ma io so’ io e voi nun siete un c****!” ed anche “Quanno se scherza, bisogna èsse’ seri!” ed ancora “Morto un papa se ne fa un altro”… maquesta frase ad oggi non più vera! Ed infine Mia cara Olimpia, méttete in pompa, che sto grillaccio der marchese sempre zompa! Zompa chi campa, allegramente… A proposito di quest’ultima frase, nel film c’è una scena in cui il Marchese portò la bella Olimpia in una hosteria a mangiare i rigatoni con la pajata (piatto tipico della cucina popolare romana) e fu lì che si accorse di avere un sosia, Gasperino er carbonaro, un ubriacone che divenne il protagonista di uno dei suoi più crudeli scherzi. Abbiniamo a questo film, da rivedere e gustare in tutta la sua scarsa sacralità, fulgido esempio assieme a tante altre pellicole della graffiante ironia del suo magnifico regista, proprio una ricetta a base di rigatoni, non con la pajata, ma con un sugo veloce e molto gustoso. Ecco i nostri rigatoni con provola affumicata.
INGREDIENTI:rigatoni (che tengano bene la cottura) o mezze maniche rigate – 3 o 4 cucchiai di passata di pomodoro – una generosa dose di provola affumicata stagionata e non fresca – 1 aglio – peperoncino (a chi piace) – basilico – origano –sale, pepe q.b. – olio extravergine d’oliva – parmigiano grattugiato e pecorino q.b..
PROCEDIMENTO: Mentre bolle l’acqua per la pasta, prendete una bella pentola larga antiaderente con il bordo alto (perché ci dovremo ripassare la pasta una volta cotta), e metteteci a rosolare un aglio in abbondante olio d’oliva con un peperoncino (facoltativo), versare poca passata di pomodoro, sale, pepe ed un pizzico di origano, oltre ad alcune foglie di basilico fresco sminuzzate. Dopo circa 10 minuti di cottura, abbassate la fiamma sotto il pomodoro togliendo l’aglio e, contemporaneamente, mettete a cuocere la pasta nell’acqua bollente; versate quindi nel pomodoro (che è ancora sul fuoco a fiamma bassa) un generoso spicchio di provola affumicata tagliata a pezzetti piccoli (per i quantitativi regolatevi in base al gusto). Appena la provola comincia a sciogliersi ed a filare, ripassateci i rigatoni appena scolati, girate con un mestolo e metteteci a pioggia una bella manciata di parmigiano grattugiato misto ad un po’ di pecorino (proporzione 2/3 parmigiano e 1/3 pecorino). Attenzione: non preparate il sugo molto tempo prima di cuocere la pasta, perché la provola tende a raggrumarsi e quando andrete a ripassare la pasta nel condimento sul fuoco non riuscirete ad amalgamare bene il tutto.

da Maria Letizia Panerai | Apr 10, 2015
La rossa Claire e la bionda Laura sono amiche sin dall’età di sette anni: si conoscono sui banchi di scuola e consolidano la loro amicizia nel tempo, con una frequentazione assidua e simbiotica. Laura è bella, solare e, crescendo, ha molto più successo con i ragazzi rispetto a Claire, che comunque non le fa mancare mai la sua complicità. Divenute oramai adulte, Claire sposa Giles a pochi mesi di distanza dal matrimonio dell’amica con David; ma la prematura morte di Laura, appena dopo la nascita della figlia Lucie, farà cadere Claire in uno sconforto abissale. Con il consenso di Giles, Claire (una convincente Anaïs Demoustier) si prenderà cura, giorno dopo giorno, del giovane marito dell’amica e della figlioletta di pochi mesi. Sarà l’arrivo della bionda Virginia a sconvolgere le loro vite, colmando (forse) quel vuoto lasciato da Laura nei loro cuori.
E’ assolutamente palese, sin dalla locandina, che “la nuova amica” di Claire e David, descritta da François Ozon, sia un uomo travestito da donna (un bravissimo Romain Duris); ciò che invece sorprende lo spettatore è il modo in cui il regista affronta l’argomento non solo del travestitismo, ma della presa di coscienza della diversità. Inevitabili i confronti con Almodòvar, anche se lo stile raffinato con cui Ozòn rappresenta il transgenderismo è del tutto particolare, lucido e diretto, senza ricorrere agli eccessi del regista spagnolo di cui è un grande ammiratore, ma non meno efficacie. La complicità tra Claire e Virginia appassiona lo spettatore, lo affascina e lo seduce, in un gioco di doppie identità nascoste e non sempre consapevoli. Sensuale e raffinata è la scena nella discoteca gay in cui una bellissima drag queen (Bruno Perard) canta Une femme avec toi. Il film è pieno di colpi di scena in cui il regista si concentra sul dolore esistenziale di un personaggio per parlarci, invece, di un altro percorso di autocoscienza ed accettazione di sé. Nonostante gli ingredienti da favola del “c’era una volta” e del “vissero tutti felici e contenti”, in cui la realtà e la finzione si fondono senza soluzione di continuità, Una nuova amica è soprattutto un gioco accattivante e concitato di ruoli, che si scambiano e cambiano continuamente, senza trascurare alcuna possibilità, e nulla torna ad essere com’era prima. Da vedere.
data di pubblicazione 10/04/2015
Scopri con un click il nostro voto: 

da Alessandro Pesce | Apr 9, 2015
Nel 1915, in Anatolia, durante le terribili vicende del genocidio degli armeni, il fabbro Nazaret ne passa di tutti i colori, perde persino la voce a causa di una ferita (il “cut” del titolo originale), pensa di aver perduto le sue due bimbe ma poi viene a sapere che sono ancora vive e parte per una difficile ricerca che lo porterà in giro per mezzo mondo.
Questo film del turco Fatih Akin dovrebbe essere il terzo di una trilogia sulla vita, la morte e il demonio, cominciata con La sposa turca, continuata con Ai confini del paradiso, due pregevoli pellicole abbastanza innovative dal punto di vista anche tecnico e drammaturgico, di cui questa attuale non sembra neppure lontana parente. Siamo infatti difronte a un corretto polpettone stile anni ‘60, ben girato e illustrato ma anche molto prevedibile da tutti i punti di vista che piacerà probabilmente a un grande pubblico sensibile alla commozione e magari, anche all’Academy, ma che non aggiunge nulla alla poetica dell’autore. A poco vale l’accurata colonna sonora volutamente straniante, mentre l’unica metasequenza intelligente e fantasiosa è quella del parallelo tra il mutismo del protagonista e quello di una comica di Charlot.
Inoltre c’è da dire che l’edizione italiana ha un doppiaggio troppo tipo “fiction di rai uno” ed infine il titolo scelto, Il padre, fatalmente sottolinea la parte melodrammatica del soggetto (il papà che sacrifica tutto per trovare le figlie), a scapito di un più lacerante significato esistenziale (una ferita di un uomo e di un popolo) a cui allude il titolo originale.
data di pubblicazione 09/04/2015
Scopri con un click il nostro voto: 
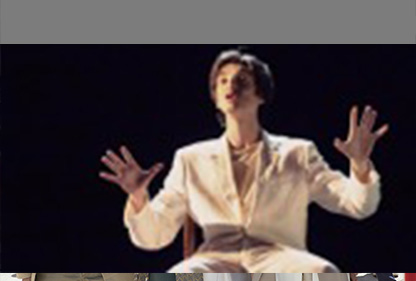
da T. Pica | Apr 3, 2015
(Teatro dell’Orologio – Roma, 31 marzo 2015 / 12 aprile 2015)
“Ma perché quando studiavo al Liceo non mi hanno portata a vedere spettacoli come quello in scena al Teatro dell’Orologio di Roma fino al 12 aprile?”. Questo mi sono domandata mentre riscoprivo la bellezza e la profondità della scrittura di Luigi Pirandello. Fabrizio Falco porta in scena Partitura P: un vero e proprio pentagramma – reso perfetto grazie alla simbiosi con il musicista Angelo Vitaliano che dialoga “live” con l’Attore creando suggestive atmosfere – in cui l’Attore/Autore compone la partitura delle tre novelle di Luigi Pirandello: i) L’uomo dal fiore in bocca, ii) Una giornata e iii) Il treno ha fischiato. Fil rouge che unisce le tre opere percorrendole come in un unico viaggio dell’anima è il “treno” che attraversa le tre storie lungo il binario della vita, che passa attraverso la complessità dell’animo umano, l’incessante giuoco tra l’essere, l’apparenza e la maschera e l’artificio come vie di fuga dall’arida e grigia realtà. Nella prima pagina dello “spartito” un viaggiatore che ha perso il treno e si ritrova suo malgrado a ciondolare alla stazione diviene il confidente de L’uomo dal fiore in bocca. Un uomo che proprio con un perfetto sconosciuto riesce a dichiarare la sua avversità verso la moglie, a lui così devota e con lui così premurosa, e per la vita. Il tema dell’apparenza e dell’immaginazione come strumento per rifuggire la realtà, divenire un’altra persona, avvicinarsi e “attaccarsi” alla “vita degli altri” per riuscire a disprezzare la pochezza della vita terrena e della società che lo circonda e forse illudersi di soffrire meno quando la morte, che si è affacciata lasciandogli in bocca quel fiore (un epitelioma), tornerà da lui per compiere il suo disegno. A scandire le giornate angosciate e tormentate del protagonista il tic tac della pendola della sala da pranzo – sala perfetta e ordinatissima come perfetta e ordinatissima è tutta la casa custodita e conservata dalla devota moglie -: il “tic tac” e l’ordine perfetto come sinonimi di alienazione e vita stantia. Dal treno perso dal confidente dell’Uomo con il fiore in bocca nel pentagramma prende poi ritmo un altro treno dal quale un uomo viene improvvisamente “espulso” – treno come simbolo della sua vita ordinata e retta dentro rigidi e rassicuranti binari – e si trova smarrito nel buio della notte fuori dal tracciato apparentemente perfetto di quei binari. Magistrale sunto del surrealismo Pirandelliano in Una giornata assistiamo rapiti al sogno del protagonista che proprio attraverso la visione onirica, e la buia notte, ripercorre tutta la sua vita terrena fino alla sua morte. Ed è qui, in questo preciso momento in cui il protagonista ripete ossessivamente vecchi figliuoli, vecchi figliuoli che senza alcuna soluzione di continuità Fabrizio Falco, con grande maturità artistica, diviene l’ilare e ritmato protagonista della terza novella, Il treno ha fischiato. Il pentagramma si chiude così con il treno – sempre inteso come vita, dinamismo, sangue che scorre brillante nelle vene – che fischiando stura le orecchie del sig. Belluca riportandolo alla vita, alla riscoperta della natura, dei suoni, degli odori. Il treno della Partitura di Fabrizio Falco esordisce con un uomo prossimo alla morte che si “allena” a detestare la vita, passa per Una giornata che riassume una vita intera, dalla nascita fino all’epilogo, e termina in un impeto positivo e ottimista con il sig. Belluca che grazie a quel lontano fischio del treno si riaffaccia entusiasta alla vita e diviene consapevole della forza dell’immaginazione: sarà sufficiente immaginare/ricordare quel fischio per ritornare alla vita ogniqualvolta il sistema grigio, alienato e burocratizzato, fondato sulla falsa apparenza, dovesse imprigionarlo di nuovo. Una Partitura P da vedere che fa riscoprire la modernità di Pirandello e correre agli scaffali della libreria per rileggere, e conoscere, le sue Novelle. Assolutamente da vedere!
data di pubblicazione 03/04/2015
Il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Apr 2, 2015
Meraviglioso film storico sulla Roma papalina del grande Luigi Magni, con un Nino Manfredi perfetto nella parte di un monsignore, giudice della Sacra Consulta, che scopre da una nobildonna sua amica di essere il padre di suo figlio, un giovane rivoluzionario destinato ad essere condannato a morte dal tribunale ecclesiastico. Quando il Monsignore (Manfredi) si reca in carcere a fargli visita, il giovane, per nulla pentito delle sue gesta e con fare strafottente, gli confessa che tra le persone che odia di più al mondo ci sono i preti come lui e quel padre che non ha mai conosciuto!
Il film segue il già fortunato Nell’anno del Signore e precede In nome del popolo Sovrano (1990), sempre di Magni e sempre interpretati dal grande Manfredi, seppur in ruoli diversi. Le musiche sono di Armando Trovajoli.
Abbiniamo a questo splendido film una ricetta molto popolare e decisamente romana: i supplì.
INGREDIENTI:300 gr. di riso carnaroli per risotti – sugo di pomodoro o di carne con macinato di vitella – 1 etto di parmigiano – 1 noce di burro – 3 uova – 200gr di pangrattato – 1 fior di latte tagliato a cubetti – sale e pepe q.b. – olio di arachidi per friggere.
PROCEDIMENTO: Bisogna fare un vero e proprio risotto con un sugo di pomodoro e basilico o se preferite con un sugo di carne (con del macinato di vitella); quando avrete raggiunto la cottura, aggiungere ½ etto di parmigiano e girare, pepe e sale, ed una noce di burro. Farlo freddare a temperatura ambiente. Preparare gli altri ingredienti sul tavolo da lavoro: mettere in un piatto piano il pangrattato, in un altro la mozzarella tagliata a cubetti, in una ciotolina il restante parmigiano e in una ciotola le uova sbattute regolate di sale e pepe nero. A questo punto, bagnarsi le mani e mettere nel centro della mano una noce di risotto freddo, inserire uno o due cubetti di fior di latte ed un po’ di parmigiano grattugiato, e richiudere con le mani il riso con il ripieno al centro sino a formare una specie di palla allungata; rotolare il supplì nell’uovo sbattuto, nel pangrattato, poi ancora nell’uovo ed infine nel pangrattato. Questa duplice operazione creerà una crosta molto croccante e spessa al supplì, che resterà al contrario morbido ed umido all’interno.
Friggere in abbondante olio di arachidi ben caldo. Scolare i supplì con un colino, salarli e servirli in un piatto da portata coperto di carta paglia.

da Antonella Massaro | Apr 1, 2015
(Teatro Vascello – Roma, 31 marzo/4 aprile 2015)
Dopo Pirandello e Beckett, Massimo Castri torna a immergersi nelle stranianti atmosfere dell’umoristico teatro dell’assurdo. La cantatrice calva di Ionesco. Quella che “si pettina sempre allo stesso modo”. Quella alla quale resta affidato il testamento artistico di Castri, scomparso nel gennaio del 2013.
“Interno borghese inglese, con poltrone inglesi”. La scena riproduce fedelmente la cornice della “serata inglese” entro cui si inscrive la pièce di Ionesco, mentre il rintocco dell’orologio scandisce con impeccabile precisione l’immobile scorrere del tempo che attraversa le vite dei signori Smith e dei signori Martin. Quando la maschera aderisce così perfettamente al volto fino a soffocarlo, non resta che adattarsi al tanto alienante quanto rassicurante conformismo delle convenzioni borghesi, fatto di cene sempre uguali e di persone interscambiabili persino nel nome (Bobby Watson), di aneddoti già sentiti e di sposi che non si riconoscono, di pompieri in cerca di incendi da spegnere e di cameriere che recitano versi ardenti di infuocato calore. Di frasi fatte e di coppie sfatte.
Il tutto supportato da dialoghi che sfruttano, esasperandolo ad arte, l’espediente di una “ovvietà fuori contesto”, amplificato dalla pressoché completa rinuncia di ogni verosimile nesso di conseguenzialità logica. Emblematico il dilemma epistemologico sintetizzato dall’interrogativo “Quando suonano alla porta c’è qualcuno o no?”: l’incalzante scambio di battute che ne deriva, sembra sintetizzare il superamento di una causalità a priori di matrice kantiana a favore di un falsificazionismo dal sapore popperiano, elevato a chiave di lettura di un’esistenza annoiata e (anche per questo) paradossale. E, dunque, “quando suonano alla porta, talvolta c’è qualcuno, talaltra non c’è nessuno”.
L’impegnativo peso di un classico che torna in scena per l’ennesima volta è ben sostenuto dalla mai tentennante maestria degli attori (Mauro Malinverno, Valentina Banci, Fabio Mascagni, Elisa Cecilia Langone, Sara Zanobbio e Francesco Borchi), capaci di coinvolgere e travolgere il pubblico nella serrata “battaglia di luoghi comuni” che prepara alla circolare chiusura dello spettacolo.
Una perla di indubbio valore, ospitata dalla deliziosa conchiglia del Teatro Vascello, immersa nelle acque di Monteverde Vecchio e offerta agli spettatori dalle sapienti mani della Direzione artistica di Manuela Kustermann.
data di pubblicazione 01/04/2015
Il nostro voto: 

da Alessandro Pesce | Mar 30, 2015
Quando Ted, professore di filosofia in un’università americana, torna con la moglie Ruth, nella casa della sua infanzia a Londra, trova la sua famiglia che non ha lasciato la vecchia dimora dove vivono ancora il vecchio padre, lo zio Sam e i due fratelli Lenny e Joey, La casa è rimasta tale e quale in maniera impressionante, con la poltrona del padre capofamiglia al centro della scena. Questo ritorno è l’occasione di una serie di incontri in cui i rapporti sono quelli tipici del Pinter prima maniera: caratterizzati da dialoghi e battute brevi, contradditorie, come i comportamenti dei personaggi; pause, silenzi, dettagli trascurabili o ingranditi in maniera deformata. Ogni azione, ogni parola ne sottintende altre, ogni insinuazione o silenzio potrebbe dar adito ai malintesi. La crudeltà dei rapporti familiari può ricomporsi al calore di un ricordo per poi smentirsi nuovamente, mentre il personaggio di Ruth catalizzerà l’interesse del microcosmo maschile e potrà, a fine commedia, occupare il posto del padre, la famosa poltrona del Capofamiglia, ma non è detto che invece la donna sarà una vittima sacrificale, mentre Ted lascerà definitivamente la casa perché ha capito che probabilmente è la sola via di salvezza. Questa pièce oggi non è più scandalosa come poteva apparire al momento della prima londinese (1964) ma colpisce ancora come coltello nella piaga dell’istituzione familiare e soprattutto piace perché aldilà di ogni lettura è una bellissima pièce, dove è stimolante soprattutto il linguaggio, il non detto. Un eterno problema dei registi è stato sempre: come mettere in scena il linguaggio di Pinter. C’è chi ha esagerato con le metafore e i silenzi, specialmente nei primi allestimenti; c’è chi ha piegato alla propria poetica i temi pinteriani, tradendoli del tutto (per esempio Visconti), c’è chi oggi sceglie la strada di un realismo alla Eduardo, come ha fatto molte volte Carlo Cecchi. Quando nel 1974 ci fu la prima italiana di Ritorno a casa, Carla Gravina chiese consiglio a Pinter sul personaggio di Ruth e l’autore le disse: “cerca di non farne una ninfomane”. Dunque si presume che volesse personaggi naturali, non grotteschi. Potrebbe quindi suscitare qualche perplessità quella recitazione imposta dal grande regista tedesco Peter Stein, tutta sopra le righe, sia nella voce sia nel linguaggio del corpo, ma tutto sommato gli attori sono efficacissimi (in primis Paolo Graziosi) e la messinscena del bellissimo spettacolo nel suo insieme è da ammirare per l’encomiabile sorvegliatissima e intelligente regia che sottolinea ogni battuta e ogni spazio, ogni vuoto. In definitiva il suo progetto registico ha vinto e gli applausi scrosciano.
data di pubblicazione di 30/03/2015
Il nostro voto: 









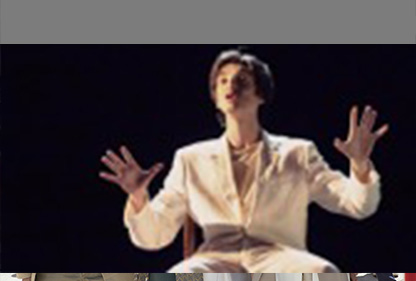








Gli ultimi commenti…