
da Antonio Iraci | Gen 6, 2016
(Teatro Eliseo – Roma, 5/24 gennaio 2016)
Dopo quasi cent’anni dalla prima rappresentazione a Roma al Teatro Valle, era un giorno di maggio del 1921, con un esordio tempestoso ed un pubblico in massima parte infuriato sicuramente in difficoltà per comprendere appieno la complessità del lavoro filosofico pirandelliano, i Sei personaggi si presentano oggi al Teatro Eliseo sotto l’eccellente regia di Gabriele Lavia, un marchio ed una garanzia per il teatro italiano.
Il regista, nonché attore principale, riesce ad rielaborare il testo, riveduto e corretto dallo stesso Pirandello in vari tempi, riprendendo tuttavia alcuni punti salienti della versione originaria e portandoci sul palcoscenico una edizione molto fedele a dettami scenografici imposti da una voce fuori campo che ci seguirà durante tutta la rappresentazione, come se lo stesso Pirandello desse voce a se stesso per curare in prima persona la messa in scena.
Il lavoro si presenta complesso, come lo stesso Lavia afferma, in quanto si rappresenta un teatro in disintegrazione che sovverte le regole sceniche classiche, per arrivare alla conclusione che l’attore non potrà mai identificarsi con il personaggio stesso recitato. L’attore interpreta la propria visione reale delle cose mentre il personaggio porta in sé la verità, perché interpreta sulla scena frammenti della propria vita vissuta: dunque una drammaturgia che nasce da dentro e che nessun attore potrà mai rendere credibile in quanto non sperimentata da lui stesso.
La scena si apre su una compagnia di attori che, seguiti da un intransigente capocomico, tenta di provare il secondo atto di un’opera dello stesso Pirandello, Il gioco delle parti. Ben presto irromperanno sul palcoscenico i “sei personaggi”, lugubri e luttuosi nei loro abiti neri, per cercare di vivere se stessi sulla scena grazie ad un autore che li rappresenti: solo che qui non occorrono né copioni da seguire né suggeritori, perché le parole dell’anima non possono essere scritte né suggerite. È proprio questa la rivoluzione pirandelliana: il passaggio dalla vita alla creazione artistica, la verità che prende dunque forma reale sulla scena.
Risulteranno vani i tentativi da parte del capocomico di assegnare alla propria compagnia le parti da recitare, in quanto pur riconoscendo la validità drammaturgica del lavoro, si renderà ben presto conto dell’impossibilità di rappresentare il dramma stesso, fuori dal contesto che coinvolge direttamente gli stessi personaggi.
Ecco che il teatro, grazie alla scena e alle luci dalle tonalità cromatiche molto forti, abbatte nella sua essenzialità le proprie barriere, per portare sul palcoscenico uno spazio di vita non più di finzione ma dove ognuno recita se stesso con la propria parte, portandosi il peso di colpe e rimorsi per qualcosa di non fatto o irrisolto.
Il dramma prosegue con un ritmo incalzante, quasi non curante delle interruzioni dovute alla originaria perplessità di portare in scena qualcosa che non trova riscontro concreto in un copione, fino alla conclusione tragica nel finale, dove emergono forti e chiari gli elementi della tragedia classica: l’abbandono, la pietà, la morte. Il ritmo a tratti claustrofobico viene esaltato dall’irrompere di tuoni come se un deus ex machina, burbero e collerico, volesse far sentire la propria presenza scenica con un ammonimento dall’alto quasi a sottolineare l’ineluttabilità del fato che travolge i personaggi e che non risparmia loro sofferenza e dolore.
Apparirebbe ridondante esaltare l’eccellenza interpretativa dell’intera compagnia, ma sicuramente va menzionato Gabriele Lavia nella parte del padre, e la figlia Lucia nella parte della figliastra, ruolo decisamente non facile perché si tratta di rappresentare una giovane, ancora quasi bambina, avviata per caso alla prostituzione, che ha già provato le avversità più crudeli della vita e che quindi non riesce a reprimere nei gesti la propria aggressività emotiva ed il proprio disprezzo.
Con Gabriele e Lucia Lavia sono in scena altri 19 grandi attori (Federica Di Martino è la Madre, Andrea Macaluso il Figlio, Silvia Biancalana il Giovinetto, Letizia Arnò la Bambina, Marta Pizzigallo Madame Pace mentre gli altri attori della Compagnia teatrale sono Michele Demaria, Giulia Gallone, Mario Pietramala, Giovanna Guida, Malvina Ruggiano, Luca Mascolo, Daniele Biagini, Maria Laura Caselli, Anna Scola, Carlo Sciaccaluga, Alessandro Baldinotti, Massimiliano Aceti, Matteo Ramundo e Alessio Sardelli). Scene di Alessandro Camera, costumi di Andrea Viotti e musiche di Giordano Corapi. Produzione della Fondazione Teatro della Toscana.
Alla prima dello spettacolo alta era la rappresentanza in sala di attori, personalità dello spettacolo e della cultura nazionale che hanno dimostrato unanimemente un altissimo gradimento.
data di pubblicazione 06/06/2016
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 3, 2016
Wendell Armbruster Jr. (Jack Lemmon), figlio di un ricco industriale di Baltimora, arriva ad Ischia per recuperare il corpo del padre morto in un incidente d’auto.
Ben presto viene a sapere che il padre, che ogni anno passava ad Ischia un intero mese per le cure termali, per molti anni ha mantenuto nell’isola una relazione con una donna inglese, di modeste condizioni sociali, anch’essa morta nello stesso incidente. A questo punto Wendell fa conoscenza con la romantica Pamela Piggott (Juliet Mills), figlia dell’amante del padre e anche lei ad Ischia per i funerali della madre, e se ne innamora. I due si ripromettono di incontrasi ogni anno ad Ischia, esattamente come avevano fatto i rispettivi genitori.
Il film, sotto la magica ed inconfondibile regia di Billy Wilder, con la sceneggiatura di I.A.L. Diamond, fece vincere un Golden Globe nel 1973 a Jack Lemmon come miglior attore per la sua eccellente interpretazione.
Il sapore ischitano della pellicola ci suggerisce questa ricetta di coniglio all’ischitana.
INGREDIENTI: Un coniglio – 500 grammi di pomodorini – 1 testa d’aglio – 2 bicchieri di vino bianco – prezzemolo, rosmarino, basilico, timo –peperoncino, sale e pepe q.b.- olio d’oliva.
PROCEDIMENTO: tagliare il coniglio a pezzi e lasciarlo marinare per una mezzora nel vino bianco. In una casseruola, preferibilmente di terracotta, mettere l’aglio e lasciarlo imbiondire. Togliere l’aglio e disporre i pezzi del coniglio che dovranno essere fatti ben rosolare. Aggiungere quindi il vino bianco, le erbe, un poco di peperoncino, sale e pepe a scelta, e lasciare cuocere il tutto per circa mezz’ora. A questo punto aggiungere i pomidorini a pezzetti e l’aglio e lasciare cuocere per altri quindici minuti, aggiungendo se si vuole del brodo caldo per mantenere il condimento più fluido. Fare riposare un poco e servire con un contorno di patate o con una insalata mista.
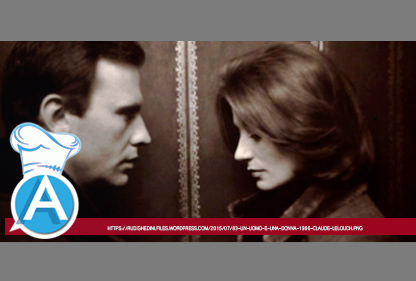
da Antonio Iraci | Gen 3, 2016
Film cult (decisamente mélo) degli anni sessanta, egregiamente interpretato da Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, ottenne importanti riconoscimenti di critica cinematografica e persino l’Oscar come miglior film straniero per il 1966 e, soprattutto, grande successo al botteghino.
Anne Gauthier e Jean-Luc Duroc sono due vedovi che si incontrano per caso nella scuola dove studiano i loro figli. Lui corteggia lei teneramente, ma anche con sincera passione, dimostrando amore e rispetto nei confronti della donna che ancora conserva vivo il ricordo del marito, da poco scomparso.
Merito del regista è quello di aver trattato questo argomento con assoluta freschezza creando, senza volerlo, dei miti e dei simboli che a suo tempo fecero tendenza, come la musica di Francis Lai che divenne presto uno dei dischi più venduti nel mondo, ripresa come sottofondo musicale sino ai giorni nostri.
Anche il film, regolarmente riproposto, continua ad avere successo tra il pubblico anche di ultima generazione, non risultando né datato né superato come stile di ripresa cinematografica, consacrando Claude Lelouch tra i migliori registi del nostro tempo.
Il film, ambientato nel nord della Francia, ci suggerisce questa ricetta dal sapore bretone: filetto di maiale al cartoccio.
INGREDIENTI: 1 filetto di maiale di 1 kg circa – 100 grammi di patè di fegato – 50 grammi di panna liquida – mezzo bicchiere di vino madeira o porto – 3 foglie di alloro – sale e pepe q.b.
PROCEDIMENTO: spalmare il filetto con il patè e cospargere con un poco di sale e pepe bianco. Disporre il tutto sopra un foglio di alluminio, aggiungendo il vino, la panna liquida e le tre foglie di alloro. Quindi, chiudere bene il cartoccio e lasciare cuocere al forno per circa 40 minuti ad una temperatura di 200 gradi. Affettare e servire ancora caldo, accompagnando il tutto con un contorno di purè di patate o con una insalata di stagione.

da Antonella Massaro | Gen 3, 2016
Il nuovo film di Checco Zalone e Gennaro Nunziante arriva in sala dopo l’imponente lancio pubblicitario messo a punto dal produttore Taodue e dal distributore Medusa. Il primo giorno di programmazione fa già registrare il record di incassi per una commedia che, evidentemente, intercetta con impeccabile precisione la domanda di cinema vacanziero degli spettatori italiani.
Checco cresce coltivando il sogno di entrare a far parte della casta del “posto fisso”, invidiata cerchia di impiegati pubblici cui sono concessi i più desiderabili privilegi: telefonate intercontinentali “gratis”, orari di lavori a dir poco flessibili, regalie in grado di rifornire una dispensa degna dello chef più intransigente. Perché rendere omaggio a un pubblico ufficiale non è né corruzione né concussione, ma solo educazione.
L’ennesima riforma governativa, volta a gettare fumo negli occhi con una pretesa semplificazione della macchina burocratica, sconvolge però il solido equilibrio di Checco. Il senatore Nicola Binetto (Lino Banfi), orgoglioso sopravvissuto della Prima Repubblica, guiderà il “nostro eroe” nella strenua ed epica difesa del posto fisso contro gli insidiosi attacchi della Dottoressa Sironi (Sonia Bergamasco), cinica e spietata emissaria del Ministro (Ninni Bruschetta). Checco assume le vesti di un novello e surreale Ulisse: costretto a un’imprevedibile e rocambolesca Odissea e ammaliato dal sorriso ipnotico della ricercatrice Valeria (Eleonora Giovanardi), è disposto a mettere in discussione gli ideali più consolidati della propria identità di gretto italiano medio, intraprendendo un autentico e profondo processo di civiltà e civilizzazione. Il richiamo di Itaca diviene a un certo punto irresistibile, ma il concetto di “casa”, si sa, non è necessariamente imbrigliato dalla staticità delle radici e il desiderio di spingersi oltre le colonne d’Ercole è connaturato all’essenza stessa dell’Uomo, specie nella variante dell’Uomo innamorato.
Quo vado? ruota attorno alla dissacrante ironia degli stereotipi italiani più tristemente noti, restituendo, attraverso i toni della commedia, il tentativo di una satira socio-politica che rievoca i tempi del glorioso ragionier Fantozzi. I riferimenti alla Commedia all’italiana, pure spesso chiamata in causa nei primi commenti al film, appaiono forse fuori luogo: da una parte l’invalsa abitudine di tessere le lodi del cinema italiano tirando fuori dal cassetto in cui erano riposte le preziose trame del Neorealismo e della Commedia all’italiana suona più come l’incapacità di “stare in piedi da soli” che come un effettivo confronto critico; dall’altra parte le citazioni dell’ispirata penna di Age e Scarpelli, del versatile istrionismo di Alberto Sordi e della lungimirante (a tratti profetica) macchina da presa di Dino Risi e Mario Monicelli suonano più dissacranti di qualsiasi battuta che Checco Zalone abbia l’ardire di pronunciare.
I colpi di comico genio non mancano di certo: dalla selezione dei migranti approdati a Lampedusa affidata alle doti calcistiche degli stessi alla citazione de La Grande Bellezza di fronte al “Fontanone del Gianicolo”, passando per la decisiva svolta narrativa affidata alla riunione di Al Bano e Romina sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Nel complesso, però, l’impressione resta quella di una sequela di sketch più adatti alla risata da piccolo schermo che alla sceneggiatura cinematografica, con un finale prevedibilmente romantico-buonista nel quale si dissolve ogni barlume dello scanzonato ma perdente eroe piccolo borghese del “fu Cinema Italiano”.
Il fascino delle ambientazioni offerte dal (milionario) set internazionale, unito alle preziose interpretazioni di Sonia Bergamasco, Maurizio Mattioli, Lino Banfi, Ninni Bruschetta, ma anche alla convincente prova della protagonista femminile Eleonora Giovanardi, rendono Quo vado? un gradevole digestivo natalizio, sia pur non sostenuto da un banchetto davvero in grado di esaltarne la degustazione.
data di pubblicazione 03/01/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 1, 2016
Esce nelle sale italiane il nuovo film del giapponese Hirokazu Kore-eda già presentato in concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes e che trova ispirazione, con un libero adattamento, dal best seller manga Umimachi’s Diary di Yoshida Akimi.
Il regista risulta già noto al pubblico italiano per Like father, like son del 2013, vincitore a Cannes con il Premio della giuria, e prima ancora per Nobody knows, anch’esso premiato a Cannes nel 2004, film che aveva a suo tempo spiazzato tutti raggiungendo un consenso inaudito da parte della critica cinematografica più accreditata.
Il film presenta una storia semplice: tre sorelle (Sachi, Yoshino e Chika) vivono da sole in una casa alquanto fatiscente nella cittadina balneare di Kamakura, ognuna vive la sua indipendenza economica ed affettiva, non corrisposte però dai rispettivi uomini, incapaci di affrontare un rapporto sentimentale stabile e duraturo e quindi poco attenti alla sensibilità delle ragazze, da anni abituate ad arrangiarsi dopo essere state abbandonate dalla madre e dal padre.
In occasione del funerale di quest’ultimo, vengono a conoscenza della sorellastra di tredici anni che conquista subito, con la sua semplicità e la sua grazia, il cuore delle tre sorelle che non esitano a proporle di trasferirsi e andare a vivere insieme a loro.
Da questo momento inizia una nuova vita per la giovane Suzu che si inserirà in punta di piedi nella nuova casa, andando d’accordo con le sorelle, diverse tra di loro per carattere, ma che comunque la amano e la rispettano, manifestando nei suoi confronti una grande dedizione senza trascurare di seguirla in questa sua fase adolescenziale.
Apparentemente il film si snoda in maniera molto lenta e misurata, senza colpi di scena che possano suscitare nello spettatore una attenzione per tematiche sorprendenti, lasciando tutto esitante come pennellate tenui in un contesto rarefatto tipico del paesaggio giapponese, dove i colori sembrano sfumare e confondersi tra di loro senza una definizione chiara dei contorni.
Ma non si tratta di superficialità, di un minimalismo proprio per non affrontare i problemi o per affrontarli in maniera poco decisa, nel film Little sister i temi importanti ci sono tutti, come quello dell’abbandono o della sopravvivenza affettiva, solo che vengono trattati in maniera delicata, quasi sospesi nel tempo in attesa del momento opportuno per trovare la loro soluzione.
I rapporti interpersonali, non esenti da astio o da abnegazione, rimangono avvolti sempre da una certa compostezza e vengono affrontati nel silenzio, con minor sofferenza possibile e senza urtare la sensibilità degli altri.
Tutto un gioco di riverenza e rispetto reciproco che trova rari casi di abbandono come di fronte a tavole imbandite di pietanze fumanti, dove sembra soffermarsi volutamente il regista, quasi a sottolineare un momento di intimità familiare, un momento di grande coesione tra le sorelle così diverse tra di loro e che davanti al cibo si trovano finalmente insieme e in sintonia.
Anche nel finale il tempo rimane incerto nel vuoto, sulla spiaggia disseminata di conchiglie le quattro sorelle si incontrano e si muovono, saltellando tra le onde che si infrangono sull’arenile, suggellando così la tacita promessa di rimanere per sempre unite e rimuovendo l’amaro che rimane in fondo al cuore, per un affetto perduto o che forse non si è mai posseduto.
data di pubblicazione 01/01/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Gen 1, 2016
Franny è un benefattore, conosciuto nella città di Philadelphia come un filantropo, ma anche come un miliardario che sa godersi la vita pur avendo investito molti dei suoi soldi in un ospedale pediatrico, soldi che nessuno sa da dove vengano perché Franny non lavora; Franny non ha una famiglia propria ed elegge a sua una coppia di amici e la loro figlia Olivia, che chiama amorevolmente puzzola e di cui diventa uno zio acquisito. Franny ha capelli bianchissimi, è eccentrico nel vestire ed ha una parola buona per tutti, soprattutto per i pazienti-bambini del suo ospedale. Franny vive da cinque anni nella suite di un lussuoso albergo pur possedendo una splendida casa che non abita, tiene discorsi in pubblico e all’occorrenza canta My girl accompagnato da un’orchestra solo per dare il benvenuto a puzzola, dopo averle appena comperato una villa immersa in un bosco perché quel posto rappresenta la sua storia, ed un passato con cui fare pace. Franny è Richard Gere, ha il suo sorriso, i suoi occhi, che anche dietro un paio di occhiali riparati con lo scotch sanno infiammarsi e spegnersi all’occorrenza, ha la sua sensualità anche se appesantita da qualche chilo accumulato nel tempo: ma per Gere il tempo non è una variabile inesorabile, anzi aggiunge ulteriore fascino alla sua persona, ed anche se questo suo nuovo personaggio si serve di un bastone per deambulare, conserva tra un passo e l’altro quella sua splendida “andatura dinoccolata” di antica memoria.
Film indipendente, diretto dall’esordiente Andrew Renzi, Franny si basa solo ed esclusivamente su una bella interpretazione del grande Richard, che ripone in questo personaggio tutta la sua vitalità, sensibilità e profondità maturate in tanti anni di onorata carriera. Peccato che la sceneggiatura sia praticamente inesistente ed i pochi personaggi che ruotano intorno al “sole Gere” siano trasparenti, non centrati nelle loro parti comprimarie e per nulla incisivi. Probabilmente questa era l’intenzione del regista anche autore dello script, dare al protagonista della storia la parte della sua maturità artistica, ma non basta a far “decollare” un film che rimane sempre al punto di partenza, diventando a tratti soporifero se non fosse scosso sempre e comunque dal ciclone Gere. Peccato: occasione mancata.
data di pubblicazione 01/01/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Dic 30, 2015
Potiche – La bella statuina è un film del 2010, che fu presentato in concorso alla 67^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia e selezionato anche al Toronto International Film Festival; tratto dall’omonima pièce teatrale, segnò dopo moltissimi anni il ritorno sul grande schermo della coppia Deneuve-Depardieu, indimenticati interpreti nel lontano 1980 de L’ultimo metrò di François Truffaut.
Siamo negli anni ’70 e Suzanne Pujol (Deneuve), pur essendo una donna intelligente, è la classica moglie borghese che si accontenta di fare la casalinga, relegata da un marito dispotico ed odioso (interpretato da un formidabile Fabrice Luchini) nel ruolo della “bella statuina”. Questo ruolo, da vero e proprio oggetto ornamentale, non sembra che a Suzanne pesi più di tanto, pur essendo lei la proprietaria della fabbrica di ombrelli che Robert gestisce in maniera molto autoritaria, a tal punto da essere odiato da tutte le maestranze. Ma alcuni accadimenti permetteranno a Suzanne di riprendersi la sua vita: il rapimento del marito ed un suo “provvidenziale” infarto, le permetteranno di mettersi finalmente e con successo alla guida dell’azienda di famiglia, ereditata dai sui genitori, spazzando via in poco tempo l’ingombrante figura di Robert. La successiva negoziazione con i sindacati poi, le farà rincontrare il suo ex spasimante, il sindacalista comunista Maurice Babin (Depardieu), che in tanti anni non l’aveva mai dimenticata. Questa storia di emancipazione femminile molto divertente, ambientata nella provincia francese, ci suggerisce l’abbinamento con dei piccoli bignè rustici, al gusto di prosciutto e formaggio, da gustare come aperitivo magari accompagnati da un calice ghiacciato di … bollicine!
INGREDIENTI (x 6 persone): – 150 gr di farina 00 –3 uova – 50gr di burro – 180 ml di acqua – 30 gr di parmigiano grattugiato – 60 gr di provola – 60gr di prosciutto cotto a cubetti – sale e pepe q.b..
PROCEDIMENTO:
per questa bella ricetta sfiziosa, ideale come aperitivo, mettete in un pentolino preferibilmente antiaderente, l’acqua con il burro; non appena gli ingredienti avranno raggiunto il bollore ed il burro si sarà sciolto completamente, togliere la pentola dal fuoco ed aggiungere la farina in un’unica soluzione, mescolando velocemente. Quindi aggiungete le uova, una alla volta, avendo cura mescolando bene che vengano bene incorporate dal composto.
Quindi aggiungere i cubetti di prosciutto cotto, la provola sempre tagliata a cubetti ed il parmigiano, mescolare energicamente per fare assorbire bene tutti gli ingredienti, quindi aggiustare di sale e pepe. Coprite con carta da forno una leccarda e sistemare il composto a piccole porzioni aiutandosi con un cucchiaino formando dei piccoli bignè.
Infornare a 180° (non termo-ventilato) per 20 minuti, usando l’accortezza di far pre-riscaldare bene il forno. Deliziosi.

da Alessandro Rosi | Dic 30, 2015
(Teatro Vascello – Roma, 28 Dicembre 2015)
Un Vascello pieno all’inverosimile prende il largo sulle onde sonore della musica di Chet Baker. Guidati dalla voce di Massimo Popolizio si procede alla scoperta del musicista maledetto, in un reading letterario in cui parole e note musicali si fondono in un unico suono avvolgente e ondeggiante.
La rotta è quella tracciata dal testo di Roberto Cotroneo con il suo libro E nemmeno un rimpianto – Il segreto di Chet Baker. La storia ha inizio nell’appartamento di uno scrittore, il quale ritrova un foglio con lo spartito della canzone più popolare del trombettista, “My funny valentine”, in una chiave che non aveva mai sentito. Parlando di quanto accaduto con la sua amica Natalie, è avvisato da quest’ultima che Chet Baker è ancora vivo e che il corpo inerme trovato ai piedi Prins Hendrik Hotel ad Amsterdam non è il suo.
Lo scrittore, pertanto, va alla ricerca del musicista, scovandolo fortuitamente in un paesino del Salento.
L’incontro darà modo ai due di ripercorrere la vita del jazzista: la sua dipendenza dall’eroina, che lo costrinse a impegnare i suoi strumenti per acquistare gli stupefacenti e, di conseguenza, l’allontanò per un periodo dalla scena musicale; la rivalità con Miles Davis, “mentre la musica del trombettista di Alton conduce negli abissi, la sua è un modo per risalire dalle tenebre”; i problemi esistenziali, “lui e il mondo erano come vasi comunicanti: più si dannava, più il mondo si purificava”.
Sconvolto dall’incontro, lo scrittore è oppresso dalla consapevolezza della caducità della vita, ma Natalie lo ammonisce “la vita è più lunga di quello che si crede”. Rinfrancato dalla frase, torna a casa del musicista ma la trova vuota; il cantante malinconico è scomparso di nuovo.
Ma Chet Baker è ancora vivo — come scriveva Orazio nelle sue Odi “Non omnis moriar” —, la sua musica ancora risuona nelle nostre orecchie e, senza rimpianti, anneghiamo nel blues del mare di note sgorganti dalla scintillante tromba di Javier Girotto.
data di pubblicazione 30/12/2015
Il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Dic 29, 2015
Interpretato da Tom Hanks, scritto da Matt Charman con i fratelli Coen, diretto da Steven Spielberg. I presupposti per un “film da vedere” sembrerebbero esserci tutti. E Il ponte delle spie non delude le aspettative.
Nel 1957 il mondo è diviso in blocchi. Tra gli Stati Uniti e i Paesi comunisti si combatte una guerra fatta di informazioni, che può condurre a un conflitto termonucleare totale oppure evitarlo. Dopo aver preso parte al Collegio d’accusa durante il processo di Norimberga, l’avvocato James Donovan (Tom Hanks) si dedica con successo al settore delle assicurazioni, fino a quando la sua routine lavorativa è bruscamente interrotta dall’incarico di assistere il Colonello Abel (Mark Rylance), spia russa con la passione per l’arte. La difesa di Donovan, nelle intenzioni delle istituzioni, dovrebbe rappresentare il formale omaggio a quel sistema di garanzie che rende riconoscibile gli USA agli occhi del mondo, ma che di certo non si può pretendere di applicare nella sua interezza a una spia, per di più sovietica. L’avvocato Donovan, “uomo tutto d’un pezzo”, rende però imprevisto anche l’esito giudiziario più scontato: alle cangianti logiche della Ragion di Stato oppone la fissa solidità della Costituzione americana, quel “manuale delle regole” di cui neppure la Guerra fredda può sospendere l’applicazione, quel baluardo del Diritto che non può cedere a fronte delle pretese istanze anomiche della Politica.
L’intransigente avvocato si troverà a fare i conti con l’impopolarità di chi si aspetta che in certi casi la Giustizia si faccia fuori dai (e nonostante i) codici, condurrà nelle aule di tribunale una guerra parallela a quella che gli “operatori” americani combattono nei cieli dei territori sovietici e giungerà infine in Europa, sul teatro della guerra “vera”: la guerra fatta di macerie materiali e morali, quella che corre lungo le pareti di un muro divenuto il simbolo di un’epoca, quella che porta i contendenti a fronteggiarsi sul Ponte di Glienicke, che congiunge, dividendole, Berlino Ovest e Berlino Est. Proprio quel Ponte diventerà il tavolo da gioco sul quale Donovan tenterà di conciliare gli imperativi della Morale con le barriere elevate in difesa della sovranità nazionale: una partita nella quale l’inaspettata “alleanza” tra un avvocato americano e un agente segreto russo, fondata su un rispetto reciproco che diviene reciproca fiducia, si mostrerà in grado di giocare la mossa decisiva.
La stella del cinema giudiziario, ben visibile nella prima parte del film, torna a brillare alta nel firmamento hollywoodiano, con Tom Hanks impeccabilmente convincente nel ruolo di un avvocato permeato di incorruttibile idealismo. Nella seconda parte Spielberg lascia spazio al racconto storico, volgendo nuovamente la macchina da presa, dopo gli indimenticati Schindler’s List e Salvate il soldato Ryan, verso il cuore pulsante del Secolo breve e portando sul grande schermo la vicenda di Francis Gary Powers (nel film Austin Stowell), pilota di un aereo spia Lockheed U-2 abbattuto dai russi, che tante volte il regista ha sentito raccontare da suo padre.
Gli intrecci della storia si dipanano in luoghi molto distanti tra loro, tenuti saldamente insieme dalla sapiente regia di Spielberg, fino a ricongiungersi in unità su quel Ponte da cui il film prende il nome. Pressoché inevitabili le incursioni della retorica made in USA, esaltata dall’epica dell’eroe borghese che riesce addirittura a imporsi sul cinismo senza morale degli uomini della CIA, della DDR e dell’URSS. Il film regge tuttavia con convincente solidità l’onda d’urto dell’enfasi narrativa e anche i 141 minuti scorrono via con estrema disinvoltura.
data di pubblicazione 29/12/2015
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Dic 27, 2015
Sospeso a mezza via tra il dramma noir e tormentato di Match Point e il thriller scanzonato e rocambolesco di Scoop, senza scomodare le atmosfere di Crimini e misfatti, Woody Allen torna sugli schermi natalizi con Irrational Man, presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes.
Il professore di filosofia Abe Lucas (Joaquin Phoenix), non più tanto bello ma ancora sufficientemente dannato, sale sulla cattedra di un nuovo piccolo College, in cui la gente mormora e lo conosce ancor prima del suo arrivo: penna brillante, animo inquieto, fama da conquistatore, amante del buon whisky.
Il Prof. Lucas ammalia i suoi studenti discutendo della morale senza compromessi alla quale conduce l’imperativo categorico kantiano o della disperazione (che però trova consolazione in Dio) nel pensiero di Kierkegaard, ma non riesce a conferire alla sua vita uno spessore più consistente di quello delle pagine che affollano gli scaffali dell’intellettuale modello. Né l’attivismo politico né il volontariato hanno offerto ad Abe l’occasione di compiere la sua “azione significativa”, quella in grado di farlo sentire “inebriato di aria”, come nelle poesie di Emily Dickinson.
L’incontro con la collega Rita (Parker Posey), ma soprattutto quello con Jill (Emma Stone), la più promettente studentessa del suo corso, riusciranno nell’impresa di confezionare il farmaco miracoloso capace di curare il mal di vivere del Professore. Mentre l’intesa con Jill diviene per la giovane donna (un po’ meno per il navigato Professore) un’attrazione tanto inevitabile quanto totalizzante, è il Caso, chiave di lettura più volte esplicitata nella sceneggiatura di Allen, che renderà ben riconoscibile il “fischio del treno” in un’esistenza che Abe non è più disposto a lasciar sfigurare in un teorico e astratto esistenzialismo.
Una conversazione tra sconosciuti, ascoltata per caso di un bar insieme a Jill, svela allo sguardo del Prof. Lucas, per troppo rimasto assopito, la via per passare dalla teoria alla pratica, dalla potenza all’atto, dall’idealismo all’azione. Il processo di liberazione di Abe innesca però una (necessaria, non più casuale) reazione a catena: un delitto non può restare senza castigo e, per quanto il male possa essere a volte banale, la sentenza di condanna trova sempre il suo modo per diventare definitiva. Non è un caso, forse, che sia proprio un Giudice “non giusto” la scintilla in grado di far esplodere il desiderio di vita del protagonista, sia pur secondo schemi e valutazioni rovesciate rispetto a quelli su cui si fonda la morale comune.
Il triangolo Phoenix-Stone-Posey sostiene bene, sul piano recitativo, una trama narrativa complessivamente solida, forse a tratti appesantita dalle citazioni che Allen si sente in dovere di esplicitare e che, pur risultando coerenti con quel professore di filosofia che è l’autentico centro propulsore della storia, rischiano di sconfinare a volte nel gratuito didascalismo. La dosata alternanza tra ironia caustica e introspezione riflessiva rendono ben riconoscibile la penna di Woody Allen: Irrational man non è certo la punta di diamante della sua filmografia, ma offre un punto di vista ulteriore per approfondire alcuni dei temi che caratterizzano quella filmografia in maniera ormai riconoscibile.
data di pubblicazione 27/12/2015
Scopri con un click il nostro voto: 




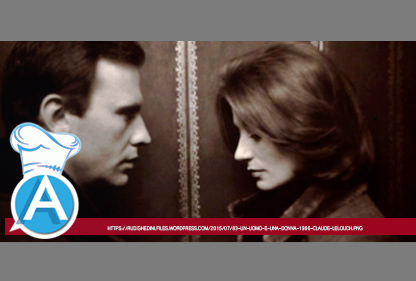














Gli ultimi commenti…