
da Antonio Iraci | Gen 30, 2016
(Teatro dei Conciatori – Roma, 26/31 gennaio 2016)
Al Teatro dei Conciatori, in una atmosfera decisamente da Off-Off Broadway, Nadia Perciabosco ci racconta in maniera più comica che tragica il suo rapporto personale con il Buco che incombe sul fondo della scena, essenziale e fagocitante, minaccioso ma anche ammiccante. Ma il Buco in effetti che rappresenta? Sicuramente, pur percependolo, sfugge a qualsiasi effettiva definizione in quanto è tutto e niente allo stesso tempo, è bianco o nero a seconda del nostro punto di osservazione, è oggettivo e soggettivo in quanto ci può far star bene o male a seconda di come lo interpretiamo.
Ecco che la protagonista, in un serrato monologo, ci porta la propria esperienza personale con il Buco, mediante l’utilizzo di un suo singolare stile espressivo, per abbattere il muro invisibile tra realtà e finzione e portare lo stesso pubblico a confessare in pubblico il proprio buco esistenziale.
Ci si trova così ad affrontare una sorta di terapia psicoanalitica di gruppo, uno psicodramma, dove ci si confronta, ci si confessa, parlando delle proprie debolezze e dei propri punti di forza, e ci si conferma il concetto base di teatro/vita: portare in teatro la vita quotidiana e viceversa in uno spazio che diventa luogo comune d’incontro per rappresentare se stessi.
Un gioco drammaturgico spontaneo dove la protagonista diventa anche psicoterapeuta ed il vissuto personale parte integrante della rappresentazione scenica per indagare sull’essenza del Buco che è insito in ognuno di noi.
Ma alla fine si potrà rielaborare il concetto di base e superare il conflitto che agita il nostro essere sin dalla nascita?
In effetti si può, basta soffermarci sull’assioma che tutte le ciambelle riescono con il buco.
data di pubblicazione: 30 gennaio 2016
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 28, 2016
(Teatro dell’Orologio – Roma, 19 gennaio/14 febbraio 2016)
Quattro fratelli sono riuniti in casa della madre per prepararle una sorpresa in occasione del suo compleanno. Paolo, organizzatore dell’incontro, è ricercatore in un centro sperimentale ed espone in questa occasione una teoria non ancora testata secondo la quale sarà possibile riplasmare il corpo di un defunto, anche dopo diversi anni dalla sua morte, semplicemente utilizzando micro particelle subatomiche rimaste nei luoghi più frequentati in vita: sia pur per un’ora potrebbero riabbracciare il padre, già morto da alcuni anni, per poi salutarlo definitivamente.
Se ci dovessimo di nuovo interrogare sulla morte che ne verrebbe fuori, visto che da millenni generazioni di filosofi hanno elaborato disquisizioni senza mai arrivare ad una definizione certa?
Ma la morte è veramente la fine della vita o la vita è la fine della morte?
Filippo Gili completa così il suo percorso metafisico chiudendo la Trilogia di Mezzanotte, per la regia di Francesco Frangipane: partendo da una realtà concreta, va oltre il conosciuto per indagare un mondo ancora tutto da scoprire non avendo gli strumenti necessari per decifrarlo.
Il redivivo, l’uomo che nella narrazione grazie al buon esito dell’esperimento torna in vita in seno alla famiglia, si sente all’inizio disorientato, non riconosce lo spazio né il tempo, due categorie fittizie che noi utilizziamo, e si ritiene quindi quasi fuori posto tra i suoi affetti perché ingabbiato in un corpo che non gli appartiene più, in un tempo che scorre, sia pur a ritroso, e che scandisce un ritmo a lui ora completamente estraneo. Se è pur vero che riabbracciare dopo anni la sua famiglia lo renda felice, nel contempo però ne percepisce la paura e lo sgomento, perché per una sola ora è tornato in vita per poi rientrare in una dimensione in cui l’attimo dura un’eternità.
Ottime le prove degli attori in scena, essenziale l’allestimento a cura di Francesco Ghisu e soprattutto ben riuscito il gioco delle luci di Giuseppe Filipponio che, in una alternanza di chiari e scuri, fa piombare a volte gli spettatori, per un tempo indeterminato, in una totale assenza di luce quasi a voler significare che al di là del tunnel non ci sarà il chiarore ma il buio assoluto della nostra ignoranza.
data di pubblicazione:28/01/2016
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 28, 2016
Mamma Roma (Anna Magnani) è una prostituta che grazie alla sua determinazione, approfittando di alcune circostanze a lei favorevoli, riesce a liberarsi dal giogo imposto dal suo protettore (Franco Citti) e a ricostruirsi una vita più rispettabile vendendo verdura in un mercatino rionale di Roma.
Il figlio Ettore (Ettore Garofalo) passa il tempo insieme ad altri borgatari ad organizzare piccoli furtarelli e si invaghisce di Bruna (Silvana Corsini), ragazza più grande di lui e anche lei avviata al meretricio.
A questo punto, pur di distogliere il figlio dalla ragazza, Mamma Roma interviene decisa ed organizza tutta una messa in scena nei confronti di un ristoratore di Trastevere al fine, poi, di costringerlo a procurare al ragazzo un lavoro come cameriere ed allontanarlo così dalle amicizie poco raccomandabili di cui si circondava.
Quando tutto sembra aver raggiunto il giusto verso ricompare il vecchio protettore che costringe Mamma Roma di nuovo a prostituirsi di notte, all’insaputa del figlio, facendo ripiombare la donna in una stato di grande prostrazione, proprio mentre sembrava essere uscita dal tunnel della mala vita ed aver raggiunto una posizione sociale più dignitosa.
Venuto a sapere da Bruna del mestiere della madre, Ettore ritornerà alle cattive compagnie e, sorpreso a rubare, verrà arrestato e morirà in preda ad una sorte di febbre violenta legato ad un lettino di contenzione, invocando invano la madre che disperata tenterà poi il suicidio.
Ancora una volta Pasolini rivolge la sua attenzione ai problemi delle borgate romane degradate, all’esigenza di riscatto morale e sociale che spinge quel microcosmo a cercare invano una via d’uscita dalle proprie miserie e debolezze. Qui siamo anche in presenza di un rapporto intenso e inscindibile tra madre e figlio, un affetto che va al di là di qualsiasi ostacolo che il destino frappone, come a voler deliberatamente e sadicamente prendersi gioco delle umane sventure dei due protagonisti.
Mamma Roma vende al mercato carciofi e pertanto non possiamo non omaggiare la figura indimenticabile di questa attrice se non con questa ricetta di carciofi imbottiti.
INGREDIENTI: 8 carciofi romaneschi o cimaroli – 100 grammi di pan grattato – 100 grammi di formaggio pecorino grattugiato – 30 grammi di uvetta di Corinto – 2 spicchi d’aglio – prezzemolo, olio d’oliva sale e pepe q.b..
PROCEDIMENTO: Pulire bene i carciofi e lasciarli in acqua con succo di limone. Preparare un impasto composto dal pan grattato, il formaggio pecorino, l’uvetta, il prezzemolo abbondante tagliato fino e i due spicchi d’aglio anch’essi tagliati a pezzetti molto piccoli. Aggiungere un poco di sale, pepe ed olio d’oliva tanto quanto basta per ottenere una massa molto umida.
Effettuare una fessura con un coltello sulla testa del carciofo, introdurre a pressione con il dito l’impasto e disporre a testa in giù tutti i carciofi in una casseruola con un fondo di abbondante olio d’oliva ed una tazzina di acqua. Lasciare cuocere per circa mezz’ora con il coperchio. Lasciare raffreddare e servire a temperatura ambiente.
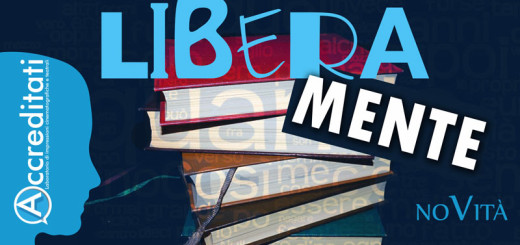
da Antonietta DelMastro | Gen 26, 2016
Perché ogni tanto vanno anche ripresi in mano dei libri “più datati”, non si può leggere solo quello che viene pubblicato nell’immediato e che, spesso, con la stessa velocità scompare senza lasciare traccia.
Ogni tanto vanno ripresi in mano i libri che hanno fatto la storia della letteratura mondiale, e in queste feste appena passate il Canto di Natale di Dickens ci stava proprio bene!
Quante volte l’ho letto ai miei figli bambini, con quante voci diverse ho riportato alla luce da quelle pagine il vecchio Giacobbe Marley, gli spiriti dei tre Natali, il povero Bob Cratchit e il tremendo Ebenezer Scrooge, quanta tristezza si è dipinta sui loro visetti per la sorte del piccolo Tiny Tim e quanta gioia per quell’enorme tacchino che Scrooge fa portare a casa Cratchit dopo il suo ravvedimento. Quante volte durante le feste natalizie abbiamo guardato insieme il cartone della Disney, incantati da Scrooge/Paperone o Marley/Pippo.
E questa volta ho ripreso in mano il “vero” Canto di Natale magistralmente tradotto da Federigo Verdinois.
Ho ritrovato nelle sue pagine tutta la gioia del Natale, quello vero non quello dei centri commerciali, quello della condivisione con i parenti e gli amici cari, quello in cui ci si raduna intorno a una tavola felici della propria vicinanza, dello scambiare una parola, un cenno, un gesto.
Da quelle poche pagine sorgono così tanti sentimenti, così tante riflessioni, così tanta serenità. Le descrizioni di Dickens sono insuperabili, sentiamo i rumori degli oggetti, i profumi delle spezie, la gentilezza della gente: “E le drogherie, oh le drogherie! Chiuse a metà, o solo con uno o due imposte tolte via; ma che bellezza di spettacolo traverso a quelle aperture! […] l i barattoli passassero rumoreggiando di mano in mano come bussolotti, o che i profumi mescolati del tè e del caffè accarezzassero il naso, o che i grappoli di uva passa fossero così pieni e biodi, e le mandorle così candide e la cannella così lunga e dritta […] era una vergona, dicevano, bisticciarsi il giorno di Natale”
Di contro troviamo l’egoismo di Scrooge, avido, burbero, gretto ”Un Natale allegro! Al diavolo il Natale con tutta l’allegria! O che altro è il Natale se non un giorno di scadenze quando non s’hanno danari; un giorno in cui ci si trova più vecchi di un anno e nemmeno di un’ora più ricchi; un giorno di chiusura di bilancio che ci dà, dopo dodici mesi, la bella soddisfazione di non trovare una sola partita all’attivo? Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va attorno con cotesto “allegro Natale” in bocca, avrebbe a esser bollito nella propria pentola e sotterrato […]”
Con un linguaggio colto e quasi sempre colloquiale ci racconta una bella fiaba, che racchiude in sé tante cose: la critica vero la rigida società londinese vittoriana di metà ottocento, una storia di fantasmi, di buoni sentimenti, e della redenzione di Scrooge.
Un libro che dovremmo rileggere ogni anno per ricordarci sempre che Natale non è “fare il regalo” ma è affetto, amicizia, calore.

da Felice Antignani | Gen 26, 2016
“È troppo triste rendersi conto che la vita assomiglia al gioco degli scacchi, in cui basta una mossa falsa a farci perdere la partita, con l’aggravante che, nella vita, non possiamo nemmeno contare su di una possibilità di rivincita”. Con la citazione di Sigmund Freud si chiude La seconda mossa, nuovo cortometraggio di Nicolò Tagliabue, autore anche dello script, la cui trama ruota intorno ad una surreale partita a scacchi, in un contesto che pare immutato dal tempo e con un solo giocatore, il protagonista, o forse no.
Nell’equiparare la vita al gioco, in cui le scelte sono le mosse che producono effetti e conseguenze imponderabili, dalle quali è impossibile tornare indietro, l’autore fa riflettere lo spettatore e, al contempo, rende possibile l’immedesimazione nel protagonista, nelle sue paure, angosce e delusioni. La malinconia è tangibile, al pari del pessimismo (assolutamente razionale e condivisibile), accompagnata da una sinfonia che si rinnova lungo l’intera narrazione, con passo talvolta leggero, talvolta grave.
Da un punto di vista tecnico, la fotografia è pregevole, la regia solida e sicura. La seconda mossa è destinato ad un vasto circuito festivaliero, a livello internazionale, dove, a parare di chi scrive, sarà oggetto di interesse ed apprezzamento.
data di pubblicazione:26/01/2016

da Maria Letizia Panerai | Gen 25, 2016
Lisbona, 1938. Pereira (Marcello Mastroianni), è un anziano giornalista responsabile della pagina letteraria di un piccolo quotidiano, incline alla pinguedine e con problemi cardiaci, dall’aspetto grigio; è un personaggio mediocre, Pereira, senza alcuna ideologia, che apparentemente sembra non accorgersi del regime dittatoriale del paese in cui vive. In realtà evita qualsiasi coinvolgimento, vivendo una vita di solitudine che lo porta tutte le mattine a dialogare con la foto della moglie morta molti anni prima, come se lei fosse ancora lì; sino all’incontro fatale con un giovane di origini italiane (Stefano Dionisi), che inizialmente assolda per scrivere i necrologi su celebri scrittori e intellettuali scomparsi, ma che poi si rivelerà una figura che gli cambierà la vita per sempre.
Il film, interpretato magistralmente dal grande Marcello Mastroianni in una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo due anni prima della sua scomparsa e che gli valse il David di Donatello, verte principalmente sul cambiamento interiore di questo uomo piccolo, scialbo, che grazie all’incontro con un giovane rivoluzionario comincia ad aprire gli occhi, scoprendo le violenze, le intimidazioni e la assoluta mancanza di libertà, non solo di stampa, che esiste nel suo paese; e man mano che affiora dentro di lui la conoscenza, crescono anche la coscienza e quel coraggio che non ha mai avuto: le sue azioni cambiano, sino a giungere ad una radicale trasformazione di sé, emblematicamente rappresentata dalla scena finale di questo bellissimo film da vedere nuovamente.
L’ambientazione ci suggerisce un piatto di baccalà in agrodolce: la ricetta, grazie ad ingredienti inusuali, trasforma la materia di base in qualcosa di…sorprendente, come Pereira!
INGREDIENTI: 700 gr circa di baccalà ammollato, spinato e senza pelle – 50gr di uvetta di Corinto – 1 mela verde aspra grande – 50gr di pinoli – pepe – olio extravergine d’oliva q.b..
PROCEDIMENTO:Tagliare il baccalà in pezzi regolari dopo averlo asciugato bene affinché non tiri fuori toppa acqua in cottura; metterlo a rosolare in una padella con dell’olio, una grattatina di pepe, avendo cura di girarlo in modo che si crei una bella crosticina. Togliere i pezzi di baccalà dalla padella appena finita la rosolatura, e nel fondo di cottura mettere la mela sbucciata e tagliata a fettine sottili, portandola a cottura lentamente con il coperchio. Appena la mela si sarà un po’ disfatta rimetterci sopra i pezzetti di baccalà, l’uvetta ed i pinoli e far finire a fuoco lento la cottura. Si creerà un sughetto denso agrodolce.
E’ un piatto veloce, ma molto gustoso e raffinato. Se ne rimane un po’ lo si può frullare e la crema ottenuta la si può usare su dei crostini di pane caldo irrorati con olio d’oliva a crudo e qualche pinolo tostato sopra. Sorprendente!

da Antonio Iraci | Gen 25, 2016
(Teatro India – Roma, 20/24 gennaio 2016)
A birritta cu’ i ciancianeddi (Il berretto a sonagli) è una commedia che Pirandello scrisse nel 1916, direttamente in dialetto siciliano, per farla rappresentare dalla compagnia teatrale di Angelo Musco il quale volle subito snellirne il testo originario, troppo pieno di riferimenti e riflessioni sulla condizione esistenziale dell’uomo, al fine di renderlo più leggero, sicuramente più comico e quindi più adatto alla sua interpretazione.
I vari personaggi ruotano intorno alla figura di Beatrice, sposata con il Cavaliere, che monopolizza l’azione con la sua incontrollabile gelosia dopo aver scoperto che il marito la tradisce con la bella Nina, moglie del contabile Ciampa. Incitata dalla tenace Saracena, Beatrice deve assolutamente vendicare l’affronto subìto e convoca in casa il delegato Spanò, che rappresenta la legge, per sporgere denuncia ed organizzare l’arresto dei due amanti. Dissuasa invano dalla fedele serva Fana, dal fratello Fifì e dalla madre Donna Assunta, la donna rimane tuttavia decisa a rendere pubblico il tradimento, consegnare alla giustizia la coppia fedifraga e riacquistare la propria libertà. Convocato con un pretesto Ciampa, lo stesso ammette di essere al corrente, come tutti in paese, della tresca amorosa e sostiene che sarebbe capace, in preda all’ira, di uccidere la bella moglie pur di riscattare la propria dignità di uomo tradito.
Ma la ragione sembra aver qui il sopravvento e suggerisce che la soluzione migliore è mettere le cose a tacere, senza sollevare un gran polverone che non conviene proprio a nessuno.
Qui Pirandello introduce un concetto molto significativo, che poi sarà la peculiarità non solo della sua opera drammaturgica ma del proprio modus vivendi privato: ognuno di noi è come se avesse dentro la propria testa tre strumenti, tre corde, che può manipolare a proprio piacimento secondo le circostanze. La corda pazza è quella che ci fa agire d’istinto, senza valutare le conseguenze dell’azione posta in essere; quella seria rimette le cose a posto portandoci verso la ragione ed ha una funzione critica oltre che morale; la corda civile, infine, è quella che svolge un’azione mediatrice, convenzionale, di facciata e che ha spesso il sopravvento in quanto imposta dal buon vivere civile.
In questi termini sembrerebbe quasi che Pirandello voglia riprendere i temi analitici appena elaborati da Freud che sosteneva che la psiche umana è come divisa in tre settori che interagiscono tra di loro (id, super ego, ego), solo che mentre Freud ne ricava uno studio meramente introspettivo, rivolto allo studio del sé, in Pirandello il sistema è invece rivolto verso l’esterno, verso il sociale. Ognuno di noi quindi è come un burattino (pupo), una maschera che si muove in pubblico cercando di non infrangere le convenzioni borghesi, evitando possibilmente di esternare la propria vera natura e mettendo così in perenne conflitto il sé con gli altri, nella continua ricerca dell’equilibrio.
Ecco che Beatrice pur agendo d’istinto per rivendicare giustamente la propria dignità di donna tradita ed umiliata (una femminista “ante litteram”), dopo aver ottenuto l’arresto dei due amanti, si troverà ad essere quasi forzatamente ricondotta alla ragione dagli altri che la convinceranno ad adottare una posizione di compromesso, in cui l’unica strada percorribile per salvare le apparenze ed evitare scandali inutili, che non giovano a nessuno, è quella di fingersi pazza e di confessare di aver agito solo d’impulso. Come? Gridando a tutti quella verità a cui nessuno crederà.
Valter Malosti, regista oltre che interprete di Ciampa, è riuscito a portare in scena con grande accortezza una tra le più complesse opere drammaturgiche di Pirandello adattando il testo originario, per renderlo comprensibile ad un vasto pubblico, pur mantenendo l’incisività del dialetto siciliano nella narrazione stessa. L’allestimento scenico di Carmelo Giammello risulta essenziale e congeniale per esaltare la bravura degli attori della Compagnia Teatro di Dioniso.
Posti esauriti in sala e pubblico entusiasta.
data di pubblicazione:25/01/2016
Il nostro voto: 

da Rossano Giuppa | Gen 24, 2016
(Teatro Argentina – Roma, 19/31 gennaio 2016)
Torna al Teatro Argentina di Roma dal 19 al 31 gennaio la poesia nuda di Pippo Delbono.
Vangelo, spettacolo coprodotto da Emilia Romagna Teatro e Teatro Nazionale Croato di Zagabria, rilegge e rivive i passi di Matteo, Marco, Luca e Giovanni in un presente doloroso e sofferente, fatto di ricerca di libertà ma anche di desiderio di riconciliazione.
In Vangelo Delbono va alla ricerca del Gesù delle origini, scomodo e potente, portatore di messaggi rivoluzionari e non di quello dal volto sofferente e doloroso proposto dalla Chiesa, dal quale anzi era rifuggito da ragazzo attratto piuttosto dai concerti rock, dalle proteste contro il potere e il Vietnam, dalla cultura hippie. E’ un Vangelo che racconta le sue esperienze di vita, i suoi incontri con immigrati dell’Africa e del Medio Oriente incontrati nelle piantagioni di mais in Italia. Un racconto basato sul rifiuto di violenza e di stragi, in cui ritroviamo Schubert, i Led Zeppelin, Alan Sorrenti e Scialpi, le parole di Pasolini e Sant’Agostino e la sua ostinata ricerca di paesaggi, mari, tramonti, cieli che parlassero di miracoli, di luce. E poi la sua malattia agli occhi che lo costringe ad un letto d’ospedale e che lo pone per dieci giorni di fronte ad un crocifisso appeso a un muro bianco. “Vedere doppio e cercare di mettere a fuoco quell’immagine, quelle voci, quei suoni, quegli echi, quei silenzi sentiti in quei campi di zingari e di profughi, in quelle corsie d’ospedale, ma anche quella forza vitale, quella inspiegabile gioia trovata nei luoghi deputati al dolore”.
Emarginazione e malattia, storie di vita tra personale e cronaca, umanità e spiritualità, secondo una capacità rappresentativa unica, in grado di dare credibilità a peccato e redenzione. Un racconto personale, un vangelo laico, un’elegia a deboli ed emarginati, essenziale e barocco, mistico e dissacrante, raccontato con ironia e concretezza.
Nato dalle note delle musiche composte con Enzo Avitabile, dopo l’anteprima di Zagabria in forma di un’opera teatrale e l’attuale spettacolo di prosa, Vangelo evolverà in una produzione cinematografica internazionale che prenderà vita nel corso delle prove dello spettacolo teatrale.
E Pippo Delbono con i suoi partner storici della compagnia, uniti ad attrici croate e ad un profugo afgano, lo urla e lo sdrammatizza con il suo personalissimo linguaggio, fatto di presenze, immagini e suoni, di brani musicali sorprendenti ma sempre coerenti, di movimenti ripetuti e scomposti, di geometrie perfette, con un uso straordinario e maniacale dello spazio fatto di vuoti e di pieni, di pause, di rette e circoli che lasciano il segno.
data di pubblicazione:24/01/2016
Il nostro voto: 
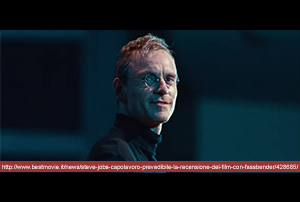
da Antonella Massaro | Gen 24, 2016
La “ vera storia” di Steve Jobs, rivoluzionario dell’informatica e del marketing, sembrerebbe un invito a nozze per ogni sceneggiatore. Steve Jobs e la Apple, con il futuristico disegno di rendere democratico il computer dotandolo di mouse e di icone, ma mantenendolo elitario attraverso la tecnologia end to end. Steve Jobs dell’ormai leggendario Stay hungry, stay foolish. Steve Jobs che arriva persino al sogno del cinema attraverso la Pixar.
Si correva forse il rischio di dire troppo o di dimenticare qualcosa scegliendo di raccontare tutta la “vera storia” dell’eroe della Apple. Aaron Sorkin (The social network) e la sua sceneggiatura si assumono allora la responsabilità di una scelta definita e, in qualche modo, radicale. Steve Jobs, diretto dalla sapiente macchina da presa di Danny Boyle, assume le sembianze di un’opera in tre atti. Tre presentazioni di altrettanti prodotti, che hanno segnato, nel male e nel bene, la parabola professionale e umana del genio ribelle Jobs, portato sul grande schermo dal talentuoso Michael Fassbender (nelle sale anche con Macbeth).
Nel 1984 viene svelato agli addetti ai lavori il Macintosh 128K: una passo in avanti forse troppo precoce per lo stato di avanzamento della tecnologia dei primi anni Ottanta, che si rivela un insuccesso commerciale e che condurrà alla rottura dei rapporti tra Jobs, la Apple e il suo amministratore delegato John Sculley (Jeff Daniels). Il 1988 è l’anno in cui Jobs si presenta da solo sul palcoscenico con NeXT Computer, il “cubo imperfetto”: è una fase di voluta transizione, che prepara il ritorno del figliol prodigo nella casa della “mela con il morso”. Nel 1998 è la volta dell’iMac: è chiaro a tutti che il momento della svolta è arrivato e che da quella svolta sarà molto difficile tornare indietro.
Lo spettatore assiste alle convulse prove dei tre discorsi di presentazione, in cui le strategie di mercato e le aspettative del visionario Jobs sono sempre legate a filo doppio alle sue controverse vicende personali: l’adozione che ha segnato la sua infanzia, il complicato rapporto con la figlia Lisa, l’incapacità di instaurare con gli amici/collaboratori un rapporto fatto di fiducia e rispetto e la riluttanza ad andare oltre il mito del genio solitario e incompreso. Perché forse un genio è strutturalmente incomprensibile. Ma si può essere geniali anche senza essere scorretti, come fa notare Steve Wozniak (Seth Rogen), compagno di avventura di Jobs fin da quel garage della Silicon Valley in cui tutto ha avuto inizio.
La sceneggiatura, caratterizzata da dialoghi intensi, incisivi e mai fuori tempo e fuori luogo, rappresenta indubbiamente il tratto più caratteristico del film. Pienamente convincenti anche le interpretazioni del protagonista Michael Fassbender e di Kate Winslet, nel ruolo di Joanna Hoffman, capo marketing che si carica anche del difficile ruolo di paziente e fedele “moglie da ufficio”.
La scelta di enfatizzare il ruolo dello Jobs padre, compagno e amico era indubbiamente rischiosa e forse non risulta del tutto convincente rispetto alla vicenda di un uomo che ha immaginato, coltivato e realizzato un sogno tecnologico e una sfida commerciale senza precedenti. Anche un uomo straordinario resta in fondo un uomo comune, ma il mondo è pieno di uomini straordinariamente comuni che il cinema può e deve raccontare. Un film che si intitola Steve Jobs crea delle aspettative indubbiamente elevate, proprio come quelle che l’uomo evocato dal titolo era in grado di plasmare. Aspettative che i 122 minuti di fuoco di dialoghi pressoché ininterrotti e la marcata vena “intimista” non sempre sembrano in grado di soddisfare, restituendo un ritratto già chiaramente tratteggiato dalle pagine di Wikipedia.
data di pubblicazione 24/01/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Gen 23, 2016
Saul Ausländer (interpretato dal superbo Géza Röhrig). Il nome di un condottiero biblico e il cognome che in tedesco significa “straniero”.
Saul, ebreo ungherese deportato in un campo di concentramento durante la seconda guerra mondiale, è affidato al Sonderkommando, il gruppo composto dai prigionieri più forti e resistenti, periodicamente “rinnovati”, impiegati dai tedeschi come “manovali della soluzione finale”. Spetta (anche) a loro, infatti, il compito di assicurare l’efficiente funzionamento dell’implacabile catena di montaggio che parte dalle camere a gas, passa per i forni crematori e arriva alla dispersione dei cadaveri polverizzati. Prigionieri che si trasformano in Geheimnisträger, custodi di segreti, ingranaggi di un meccanismo oliato da quel sangue che devono con cura lavare via dal pavimento.
Proprio durante le operazioni di pulizia di una camera della morte, l’attenzione di Saul viene irresistibilmente attratta da un ragazzo: non si tratta di uno dei tanti stücke (pezzi) senza vita e senza forma, ma di quel figlio evocato (invocato?) dal titolo del film. Lo scopo di Saul diviene allora trovare all’interno del campo un rabbino che possa prestargli assistenza per recitare il kaddish e offrire al giovane corpo uno degna sepoltura.
Il figlio di Saul è il racconto di un viaggio attraverso l’Inferno. È il racconto dell’instancabile ricerca di uno scopo. È il racconto della sana follia in grado di traghettare al di là del bene e del male. È il racconto del coraggio, non importa quanto consapevole, di preservare un barlume di umanità anche nella notte in cui tutto sembra diventare disumano e anche quando la maggioranza non riesce a percepire la consistenza di una priorità necessariamente assoluta: proprio come un condottiero straniero, che può sembrare blasfemo agli occhi di chi non ha gli strumenti per comprendere il suo linguaggio.
Se, per restare ai film attualmente in sala, Il labirinto del silenzio racconta l’Olocausto ponendosi dalla “distante” prospettiva della ricostruzione processuale che interviene nel momento della quiete, Il figlio di Saul sprofonda nel ventre del lager e si fa largo tra le viscere dell’orrore proprio quando la tempesta raggiunge l’apice della sua forza distruttiva. L’esordiente László Nemes, tuttavia, non indulge ad alcuna enfasi eccessiva e non sfiora neppure da lontano il rischio di inciampare nella retorica ammiccante. I dialoghi lasciano il posto tanto alla Babele di urla e rumori che da fuori campo invadono la scena quanto alla regia, sempre chiaramente visibile ma mai stucchevolmente esibita. Gli stücke ammassati e vilipesi restano spesso fuori dalla messa a fuoco, mentre la macchina da presa segue con meticolosa precisione il volto di Saul, la sua nuca, le sua mani, i suoi sguardi, incorniciati (ingabbiati?) dal formato 4.3 e impreziositi dalla pellicola 35mm.
Già vincitore del Grand Prix speciale della Giuria al Festival di Cannes e del Golden Globe come miglior film straniero, Il figlio di Saul è in corsa per l’Oscar. Un film da vedere. Un film che si lascia ricordare.
data di pubblicazione 23/01/2016
Scopri con un click il nostro voto: 





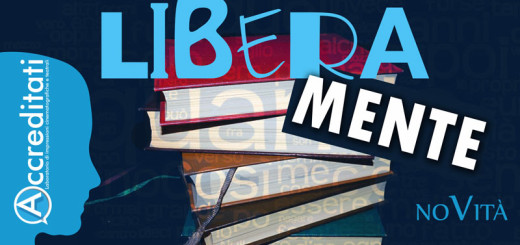





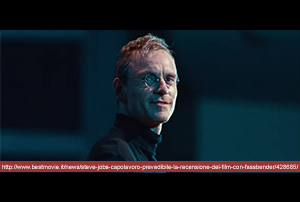







Gli ultimi commenti…