
da Alessandro Rosi | Feb 25, 2016
(Teatro della Cometa – Roma, 16/28 Febbraio 2016)
Urla strazianti provengono da una donna sul letto di un ospedale: una partoriente richiama tutte le sue energie per dare alla luce sua figlia; ma la nascitura non ne vuole sapere di uscire. La madre, con un ultimo sforzo, riesce a liberarsi del corpo estraneo. Alla vista della bambina dai lineamenti sgraziati che ha partorito, si volta e si copre con il lenzuolo bianco.
La scena appena descritta non è solo l’inizio dello spettacolo in commento, ma è anche uno dei quadri (la cui immagine è proiettata sullo sfondo del palcoscenico) più strazianti e violenti della pittrice messicana. Attraverso la rappresentazione teatrale dei capolavori di Frida Kahlo, la piecé si prefigge di ripercorrere la vita unica dell’artista in tutte le sue nuance.
Tra i temi che sono trattati, vi è: il complicato rapporto della pittrice con la madre; il dolore fisico che la affligge durante la sua esistenza, prima a causa della poliomielite e dopo per via dell’incidente in cui rimane coinvolta mentre si trovava su un autobus (e non sulla macchina guidata dal marito, come invece lascia intendere la rappresentazione); l’intimo legame di Frida con la morte — elemento costante nei suoi quadri —, atteso che nella cultura colombiana il trapasso è considerato una rinascita; le passioni travolgenti, per suo marito (il pittore Diego Rivera) e per quella che si dice esser stata la sua amante (la fotografa italiana Tina Modotti).
La mise-en-scène dei diversi quadri è intervallata da video proiettati non solo sullo schermo ma anche verso il pubblico, creando un effetto suggestivo che immerge lo spettatore nella realtà vissuta dall’artista (anche se forti dubbi si nutrono riguardo la visibilità di tale effetto da tutti i posti della sala). Non solo proiezioni, ma anche la performance di una ballerina nerboruta permette il cambio di scena. Danza e video che, sebbene d’indubbia qualità, finiscono per essere un elemento di distrazione rispetto al fulcro della rappresentazione, nonché poco inerenti con la trama dello spettacolo.
Buona la prova attoriale della protagonista (Alessia Navarro), alle prese con un personaggio impegnativo — ancorché risulti spesso malriuscito e goffo il tentativo di emulare la voce mascolina dell’artista messicana.
Per quanto riguarda la sceneggiatura, il testo non è incisivo e i dialoghi sono per lo più sconclusionati e imprecisi: non diradano i dubbi circa la figura dell’artista, ma — anzi — li infittiscono.
“Piedi, perché li voglio se ho ali per volare?” questa la celebre frase della pittrice scelta per concludere lo spettacolo, il quale, tuttavia, ha ali di Icaro che non gli permettono di decollare.
data di pubblicazione 25/02/2016
Scopri con un click il nostro voto: 
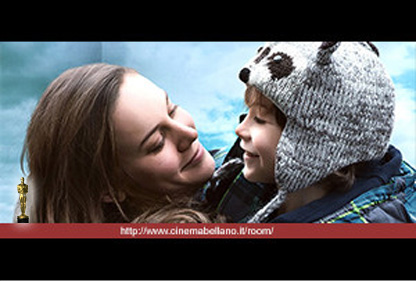
da Antonella Massaro | Feb 24, 2016
Room, tratto dal romanzo di Emma Donoghue (titolo italiano: Stanza, letto armadio, specchio) e già vincitore del premio del pubblico al Festival di Toronto, è arrivato in anteprima nazionale sugli schermi italiani durante l’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.
Joy (Brie Larson), poco più che adolescente, viene rapita da un uomo che la tiene sequestrata in un capanno chiuso da una porta blindata, assicurandole la sopravvivenza e abusando sessualmente di lei. Il frutto della perversa prigionia è il piccolo Jack (lo straordinario Jacob Tremblay), che illumina con uno spiraglio di speranza la vita della donna. Joy protegge il bambino lasciandogli credere che non esista altro mondo al di fuori di Stanza, popolata da immobili ma fedeli creature: Armadio, Letto, Sedia 1 e Sedia 2, Gabinetto. Tutto il resto Jack lo conosce attraverso la magia della televisione, mentre lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni è scandito dal sole, dalla pioggia e dal ghiaccio che si intravedono sui vetri di Lucernario. Quando Jack compie cinque anni, Joy decide di squarciare “il velo di Maya” che aveva caritatevolmente steso sugli occhi del bimbo, convincendolo a collaborare con lei per evadere dalla sbarre di Stanza.
Il ritorno nel mondo per Joy e la sua scoperta da parte di Jack si riveleranno però processi dolorosi e complessi. Gli occhi del bimbo devono abituarsi alla luce accecante del sole e alla messa a fuoco di immagini in vorticoso movimento, il suo corpo deve imparare a difendersi dai germi che affollano l’aria che cambia continuamente di temperatura, la sua mente deve gestire spazi infinitamente più estesi e tempi altrettanto più ridotti rispetto a quelli che regolavano la vita in Stanza.
“Venire al mondo” è tanto difficile quanto affascinante e l’attrazione per quel che si agita al di fuori di Porta è irresistibile per l’Uomo, che è anche e soprattutto un animale sociale.
Il racconto di Abrahamson sa essere potente e delicato al tempo stesso, trasformando la tragedia di un orrendo reato nella delicata poesia sulle meraviglie del mondo scoperte dall’ingenuo stupore degli occhi di un bambino costretto troppo presto a divenire adulto, ma che, sulle prime confuso dalle vertigini di Mondo, ne rimane infine benevolmente “rapito”.
data di pubblicazione 24/02/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Flaminia De Rossi | Feb 24, 2016
Jeeg Robot d’acciaio è un manga giapponese, che venne pubblicato su una rivista nel 1975. La storia tratta del risveglio dal sonno millenario dell’antico popolo Yamatai, governato da Mimika e dai suoi 3 comandanti Ikima, Amaso e Mimashi: a contrastarli interviene Hiroshi con Jeeg.
Nel film di Gabriele Mainetti siamo trascinati per mano in una favola urbana, ambientata in una Roma di superpoteri. La ripresa in volo di questa città ci guida verso una zona periferica, popolare e lasciata a sè stessa, Tor Bella Monaca, attraversando la magia suggestiva della passeggiata lungo il Tevere: la vicenda, pop e pulp, inizia proprio qui, lungo l’argine del fiume.
Il protagonista Enzo (Claudio Santamaria), un delinquente di borgata, si getta nelle acque del Tevere per sfuggire alla polizia. Il biondo Tevere lo contamina di una sostanza radioattiva che gli darà una forza sovrumana. Il dono dei nuovi poteri scatena in lui una svolta nella sua carriera di delinquente: soprannominato l’eroe del Bancomat perché viene ripreso da una telecamera mentre ne scassina uno smurandolo a mani nude, diventa il Re della rete ed un supereroe criminale.
Il video ottiene milioni di visualizzazioni, scatenando la gelosia e l’invidia della banda di criminali capitanata dallo “zingaro” (Luca Marinelli, Non essere cattivo): strabiliante la sua interpretazione, oltre alle sue due esibizioni canore. Il nostro Enzo è dunque destinato a difendere l’umanità dalla perfida banda. Ma il suo vero superpotere lo ottiene quando entra in contatto con Alessia, convinta che sia Hiroshi, l’eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d’acciaio. Alessia è una ragazza disturbata che riesce a trasformare il solitario e scontroso pregiudicato, concentrato sino ad allora su se stesso, in una persona pronta ad aprirsi ai sentimenti.
Il magico giro sulla ruota panoramica a “corrente amorosa” e non elettrica, la dichiarazione d’amore ad Alessia e al mondo intero, sono momenti pieni di poesia caratterizzati da una colonna sonora vintage e da una “stilosa” ironia romana che condiscono e rendono il film irresistibile ed esilarante.
data di pubblicazione:24/02/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Feb 24, 2016
E come dimenticare questa splendida commedia del grande Monicelli tutta al femminile, dove i pochi uomini che ci sono se la devono vedere con questo gruppo di donne energiche e combattive, dalle idee chiare e soprattutto molto solidali tra loro. Il film è ambientato prevalentemente in un grande casale in Toscana e, solo in piccola parte, in uno splendido appartamento al centro di Roma, con una terrazza mozzafiato sui tetti della capitale. Le musiche sono di Nicola Piovani ed il cast di attori è di prim’ordine: Liv Ullmann è Elena, la padrona di casa, sorella di Claudia (Catherine Deneuve) divorziata con una figlia adolescente della stessa età della figlia della domestica di casa Fosca (Athina Cenci), il cui marito andando in Australia per cercare lavoro, si è anche risposato a sua insaputa; Philippe Noiret è il conte Leonardo, sciupafemmine e spendaccione, nonché padre di Franca (Giuliana De Sio) e Malvina (Lucrezia Lante della Rovere) ed attuale amante di Lori (Stefania Sandrelli); Paolo Hendel è Mario Giovanni, stupido fidanzato di Franca e collezionista di antiche ballate contadine che registra in giro per le campagne toscane, mentre Giuliano Gemma è il Nardoni, amante di Elena e segretamente interessato a rilevare l’intera fattoria, che naviga in pessime acque. Ed infine c’è zio Gugo, affetto da demenza senile, interpretato da uno splendido Bernard Blier. Il senso di tutta la commedia è che il cosiddetto sesso forte, è rappresentato da un insieme di uomini deboli, cialtroni o malati di mente, che non possono che soccombere sotto la forza di tutte queste donne ricche di buon senso, di lucidità e logicità, ma anche di tanta leggerezza che le porta a sdrammatizzare ogni cosa. Sul finale del film tutte le protagoniste, in compagnia solo di zio Gugo, si ritrovano intorno ad un bel tavolo imbandito dove viene pronunciata la frase che dà il titolo al film, gustando un tipico piatto invernale toscano: la ribollita.
INGREDIENTI: 1 kg di fagioli – brodo vegetale – cavolo nero – bieta – verza – 2 patate – soffritto di sedano, carota e cipolla – 70/80 gr guanciale o lardo di colonnata tagliato a dadini – 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro – olio, sale e pepe q.b..
PROCEDIMENTO:
Fare bollire i fagioli (precedentemente messi a mollo) dentro dell’acqua dove avremo messo una garza con all’interno gli ingredienti per fare del brodo vegetale (sedano, carota, zucchina, patata, cipolla etc) o in libertà, avendo l’accortezza a fine cottura di toglierli. Senza fare cuocere troppo i fagioli, una metà di essi passatela al setaccio per evitare che ne rimanga la buccia: la purea che otterremo la rimetteremo assieme agli altri fagioli. Nel frattempo mettete a stufare insieme le verdure, nella giusta proporzione: cavolo nero, bieta e verza; regolate di sale e di pepe il tutto e proseguite la cottura. Avviate quindi in un tegame dai bordi altri il soffritto di sedano, carota e cipolla tagliati finemente in abbondante olio di oliva, aggiungete due patate a pezzettini, le verdure appena stufate, i fagioli interi ed in purea; quindi, aggiungete del brodo vegetale e fate cuocere per circa un’ora. A questo punto fate soffriggere i dadini di guanciale ed uniteci il cucchiaio di concentrato di pomodoro. Riversate dunque nello stesso tegame del guanciale tutte le verdure e fate proseguire la cottura ancora per mezz’ora. Se piace, aggiungete al tutto un pezzo di cotenna di prosciutto. Le dosi sono approssimative perché si lascia alla libera interpretazione di ognuno di noi su quale di questi ingredienti si vuole fare più leva. E’ un piatto “tosto” ed i crostini di pane, magari fritti, sono d’obbligo!

da Elena Mascioli | Feb 23, 2016
(Teatro India – Roma, 17/28 Febbraio 2016)
Roberto Latini, alla regia e in scena, è il capo-cordata di una scalata al teatro, quella de I giganti della montagna di Pirandello. Un adattamento e una rappresentazione che, nel suo dispiegarsi, si trasforma in discorso sul teatro stesso. Sovraimpresso, sul velo che separa impercettibilmente la scena dal pubblico, l’unico strumento utile all’ascolto e alla visione, e il solo possibile ponte di comunicazione: Immaginazione. La bellezza dell’opera è tale che nessuno guarda agli attori. In scena, infatti, le parti sono invertite, la luce (curata da Max Mugnai) e la musica elettronica (a cura di Gianluca Misiti) si fanno protagoniste, dialogano, trasformano, danno rilievo e spessore, sia fisico che metaforico, allo spazio, e lo fanno divenire Luogo. Dove m’avete portato? È un teatro questo?(…) Apparenza per apparenza, noi facciamo i fantasmi. L’attore corre, si affanna, alla ricerca della luce, prova a riempire il luogo, e quei fantasmi, con la propria corporeità, li abita con le voci amplificate da quel microfono che, nel teatro di Roberto Latini, ha perso ormai la connotazione di oggetto di scena. Ci vogliono i poeti per dar coerenza ai sogni. E ci vogliono attori, registi e drammaturghi sui trampolini, qualcuno che con coraggio prenda sulle sue spalle i giganti della montagna, si incarichi di mostrarceli nel loro essere fantasmi, e poi sappia, come avviene nella seconda parte dello spettacolo, immaginare, rielaborare e cucire, a partire da quegli orli della vita dove si è fermata l’opera incompiuta di Pirandello, una proposta. Qualcuno, come Latini, che ci aiuti a dare una risposta alla domanda con cui Pirandello, interpella sé stesso, il Teatro e il Pubblico: ”Tu non hai paura?”
data di pubblicazione:23/02/2016
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Feb 21, 2016
(Berlino, 11/21 febbraio 2016)
Quando nel 2013 a Venezia il Presidente di giuria Bernardo Bertolucci premiò il film Sacro GRA di Gianfranco Rosi con il Leone d’Oro, non tutti furono d’accordo con lui e gli altri componenti la giuria sulla scelta effettuata, oltretutto trattandosi non di un film ma di un documentario che mai, nella storia del Lido, aveva ottenuto un premio così importante. Bertolucci si limitò a rispondere che aveva percepito in Rosi la mano di un grande regista ed il premio di oggi a Berlino per Fuocoammare sta confermando questa lungimirante previsione, dandogli ragione. La giuria, presieduta da Meryl Streep, ha voluto premiare l’intensità delle immagini di questa splendida pellicola, che ci hanno fatto piangere di rabbia e nello stesso tempo sorridere con gli occhi del giovane Samuele, facendoci percepire il cuore di un posto a noi così lontano. Lampedusa è una piccola isola di pescatori i quali accettano ed accolgono tutto ciò che viene dal mare, incluso uomini, donne e bambini che non possiedono nulla se non la speranza di una vita degna di chiamarsi tale e che trovano da anni accoglienza dagli isolani. Rosi ha voluto dare la propria reale partecipazione per la soluzione immediata di questa grande tragedia, che ogni giorno ci viene presentata dai media e sulla quale pochi hanno il coraggio di soffermarsi, ignorando la portata del problema. Siamo convinti che il suo contributo non andrà perso e ci auguriamo che dopo questo importante riconoscimento tutto il mondo potrà prendere visione di questo docufilm per imparare che la vita va rispettata e che ognuno, per la sua parte, dovrà far qualcosa.
Gli altri importanti premi assegnati sono stati:
Grande Premio della Giuria al film Morte a Sarajevo del regista bosniaco Danis Tanovic;
Orso d’Argento per il film che apre Nuove Prospettive a A Lullaby to the Sorrowful Mystery del filippino Lav Diaz;
Orso d’Argento per la Miglior Regia a Mia Hansen-Løve per il film L’Avenir;
Orso d’Argento per la Migliore Attrice a Trine Dyrholm nel film Kollektivet del danese Thomas Vinterberg;
Orso d’Argento per il Miglior Attore a Majd Mastoura nel film Hedi del tunisino Mohamed Ben Attia;
Orso d’Argento per la Miglior Sceneggiatura a Tomasz Wasilewski per il film polacco United States of Love.
L’entusiasmo e la passione nel seguire questa edizione della Berlinale si spera siano emersi attraverso la comunicazione delle impressioni, giuste o sbagliate, di chi scrive che crede, come dice Samuele nel film di Rosi fabbricandosi la sua fionda, che ci voglia passione in tutto.
data di pubblicazione:21/02/2016
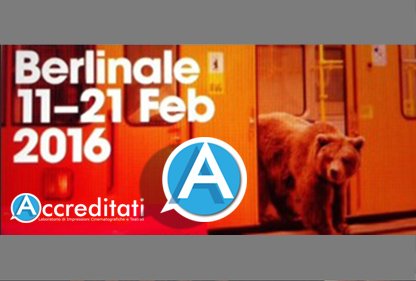
da Antonio Iraci | Feb 20, 2016
(Berlino, 11/21 febbraio 2016)
Segnalato dalla popolare rivista americana di cinema Variety, tra i registi europei degni di maggiore attenzione, Tomasz Wasilewski ha aperto la nona giornata della Berlinale con il suo United States of Love. In una Polonia alla ricerca di una nuova identità politica, all’interno di un contesto europeo ancora in assestamento dopo la recente caduta del muro, quattro donne (Agata, Iza, Renata, Marzena) ognuna con un proprio diverso vissuto, sono alla ricerca del loro equilibrio sentimentale. Il film è una riflessione sulla condizione della donna che, seppur emancipata socialmente, stenta ancora a trovare una propria autonomia affettiva dall’uomo e trovare quello che di più la appaga, lontano da sterili conformismi. Buona la fotografia con colori sempre tenui quasi a voler farsi timidamente spazio nel grigiore totale che domina l’intera scena ed i personaggi stessi, a loro volta spenti per assenza totale di speranza o quanto meno di una qualche minima illusione. Di diversa natura il film francese Saint Amour dei due registi Benoît Delépine e Gustave Kervern al loro settimo film insieme e già presenti alla Berlinale nel 2010 con il film Mammuth. Jean (Gérard Depardieu) e suo figlio Bruno (Benoît Poelvoorde) stanno partecipando a Parigi ad una famosa fiera zootecnica in cui sono fieri di presentare il loro toro Nabucodonosor, in concorso per un premio. In effetti Bruno preferirebbe abbandonare la fattoria del padre e dedicarsi di più al vino, di cui è grande estimatore e soprattutto bevitore. Jean, pur di accontentare il figlio, lo asseconderà in un tour enologico attraverso la Francia insieme a Mike (Vincent Lacoste), che con il suo taxi li accompagnerà in una serie di avventure, anche a sfondo sessuale, nelle quali rimarranno coinvolti insieme. Tipica commedia francese, di cui abbiamo avuto già esempi in questo Festival, dove la bravura degli attori protagonisti ha regalato alla platea quasi due ore di puro divertimento, risollevandola un po’ dalle atmosfere della precedente pellicola. A Dragon Arrives! dell’iraniano Mani Haghighi è l’ultimo tra quelli in Concorso; il regista, in un intervista all’interno del film stesso, ci spiega i motivi che lo hanno indotto a scrivere questa storia che narra di fatti realmente accaduti, a partire da una inchiesta iniziata il 23 gennaio del 1965, il giorno dopo l’uccisione davanti al Parlamento iraniano del Primo Ministro. I fatti si svolgono principalmente in Qeshm, un’isola sperduta nel Golfo Persico, e precisamente in un vecchio cimitero abbandonato, dove forze soprannaturali causano terribili terremoti ogni qualvolta viene seppellito un defunto. Il soggetto, tra l’assurdo ed il grottesco, tiene lo spettatore con il fiato sospeso, meritando la giusta attenzione tra le pellicole che in questi giorni sono state presentate e che pone il regista al livello di altri famosi filmmaker iraniani, sulle tracce già segnate dal grande Abbas Kiarostami.
data di pubblicazione:20/02/2016


da Antonio Iraci | Feb 19, 2016
(Berlino, 11/21 febbraio 2016)
Certamente non tutti tra il folto pubblico presente in sala erano preparati ad affrontare, con enorme spirito di abnegazione, il film in Concorso di oggi che ci ha trattenuto inesorabilmente per otto ore. Il regista filippino Lav Diaz è stato meritatamente il protagonista unico di questa ottava giornata della Berlinale presentandoci il corposo film A Lullaby to the Sorrowful Mystery che a tratti ricordava le fumose rappresentazioni in bianco e nero del russo Andrei Tarkovsky con un utilizzo, forse a tratti eccessivo, del piano sequenza per risaltare la drammaticità del racconto stesso. Ci troviamo nelle Filippine, alla fine dell’ottocento, in piena guerriglia contro i colonizzatori spagnoli che stanno attuando una spietata offensiva per mantenere il potere della corona, in un paese oramai allo sbando e brutalmente decimato dalle truppe d’invasione del Capitano Generale. La vedova di Andrés Bonifacio, oggi considerato eroe nazionale della resistenza filippina, si aggira per la folta giungla in cerca del corpo del marito, incontrando personaggi dal comportamento ambiguo, a volte quasi mitologico. Il regista pone qui in atto la sua ben nota tecnica cinematografica di condurre lo spettatore in medias res, coinvolgendolo in tempo reale quale parte integrante della scena stessa e protagonista esso stesso dell’azione. Lav Diaz, che ama spesso trattare nei suoi soggetti il contesto socio-politico del suo paese, in questo suo ultimo film pone un risalto particolare al pensiero ed alle utopie dei ribelli che non si rassegnano alla violenza subita e cercano a tutti i costi di riscattarsi con altrettanta violenza ed un giusto sentimento di odio. Il regista, più volte premiato in Festival internazionali di prestigio, è molto conosciuto a Venezia per aver vinto il Leone d’Oro (Menzione Speciale della Giuria) nel 2007 nella sezione Orizzonti con il film Death in the Land of Encantos e l’anno successivo, sempre nella stessa Sezione, il Gran Premio con il film Melancholia: entrambe pellicole lunghissime. Sicuramente un film interessante quello di oggi, dove però una sforbiciata qua e là avrebbe di certo alleggerito lo spirito in sala ed evitato allo spettatore, poco avvezzo a tali maratone cinematografiche, questa esagerata prova di sopravvivenza.
data di pubblicazione:19/02/2016


da Accreditati | Feb 18, 2016
Basato su una storia vera il film di Thomas McCarthy, presentato a Venezia 72 nella Sezione fuori concorso, narra di un gruppo di giornalisti investigatori appartenenti alla sezione denominata Spotlight (tutt’oggi esistente) del quotidiano locale The Boston Globe.
È l’estate del 2001 quando il neo direttore (Liev Schreiber) decide che la Spotlight deve accantonare le indagini giornalistiche in corso per riaccendere i riflettori su alcuni casi di abusi su minori susseguitisi una trentina di anni prima nella loro comunità ad opera di alcuni prelati, e segretati dall’omertà di alcuni componenti di spicco della società cattolica bostoniana. Coordinati da Walter Robinson “Robby” (Michael Keaton), nel gennaio del 2002 il gruppo Spotlight riuscirà a rendere di pubblico dominio la storia di un sistema di protezione attuato da un gruppo di avvocati nei confronti di alcuni sacerdoti della diocesidi Boston.
Il film di McCarthy è di estrema attualità e punta il dito non solo sull’inefficacia delle rare misure adottate dalla Chiesa nei confronti delle sue mele marce, ma soprattutto sulle violenze, oltre che fisiche anche di fede, arrecate a bambini affidati alle cure di sacerdoti, veri e propri padri spirituali, che in questo modo hanno doppiamente violentato le proprie vittime.
Ben interpretato, incalzante e realistico, non banale né retorico, in Spotlight spicca l’interpretazione di Mark Ruffalo, che intervenuto a Venezia in conferenza stampa, aveva manifestato uno spirito in linea con le sue battaglie da attivista in campagne di rilevanza politico-sociali. Sicuramente da vedere, sia per lanciare il messaggio di un ritorno al giornalismo libero ed investigativo che oramai in America è di appannaggio solo di pochi professionisti finanziati da privati, sia per invitare ovviamente la Chiesa a fare chiarezza.
data di pubblicazione 18/02/2016
Scopri con un click il nostro voto: 
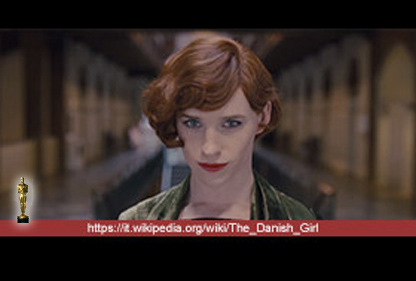
da Antonella Massaro | Feb 18, 2016
Il premio Oscar Eddie Redmayne presta i lineamenti muliebri e l’istrionico talento di attore al personaggio di Lili Elbe, che sottoponendosi nel 1930 a un intervento chirurgico per ricongiungere il corpo maschile all’anima femminile, diviene la prima riconosciuta transessuale della storia.
Tratto dall’omonimo romanzo firmato da David Ebershoff, The Danish Girl di Tom Hooper (Il discorso del Re, I miserabili), presentato durante la 72. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, assume la consistenza di un affresco tanto dirompente quanto delicato di quella che, dall’inizio alla fine, resta un’intensa storia d’amore. Einar Wegener (Eddie Redmayne) e sua moglie Gerda (Alicia Vikander), entrambi pittori: lui ama dipingere paesaggi, esibendo un talento già ampiamente riconosciuto; lei preferisce dedicarsi ai ritratti, senza però trovare la sua reale ispirazione. Il gioco quasi puerile di posare per Gerda in abiti femminili diviene la scintilla in grado di far deflagrare una bomba già innescata da tempo nel cuore e nella mente del giovane artista. Einar adora truccarsi e atteggiarsi “come una donna” perché Einar “è una donna”. In un momento storico in cui la sua condizione si trova etichettata come anomalia biologica dalle mille diagnosi, destinata alla “cura” con trattamenti terapeutici invasivi o al confino nelle tenebre ghettizzanti del manicomio, la presa di consapevolezza di Einar-Lili non è né scontata né agevole. La proiezione socio-culturale della storia cede tuttavia il posto alla dimensione di intima transizione vissuta dai due protagonisti, che si prendono coraggiosamente per mano mettendosi in cammino lungo un sentiero forse doloroso ma indubbiamente doveroso. Il tutto incorniciato da una natura sontuosa e scandito da quell’arte pura e salvifica che, sempre a Venezia 72, era già comparsa in Francofonia e Marguerite.
Il tessuto narrativo si caratterizza per l’apprezzabile rievocazione di un’infanzia priva, per una volta, di traumi pronti a giustificare la “particolarità sessuale”, anche se, tralasciando il cliché dell’inversione dei ruoli all’interno della coppia (è Genda il vero “maschio” tra i due), il passaggio da una fase all’altra della complessa metamoforsi-rinascita del protagonista appare a tratti segnato da transizioni troppo bruscamente repentine per risultare del tutto credibili.
L’interpretazione di Redmayne, semplicemente perfetta nella sua sorprendente capacità di lasciar trasparire la vibrante emozione della progressiva presa di coscienza, è senza dubbio una prova da premio. Ciò che importa, come ha precisato l’attore intervenuto in conferenza stampa a Venezia, è tenere distinto il “genere” dalla “sessualità”, secondo logiche e meccanismi che ha potuto imparare a comprendere attraverso il proficuo e generoso confronto con molti transgender, il cui aiuto si è rivelato prezioso per la preparazione del ruolo. Alicia Vikander si inserisce nel film con convinzione e indispensabile complementarietà. Nel cast anche Matthias Schoenaerts (Un sapore di ruggine e ossa, A bigger splash, Suite francese) e Amber Heard.
data di pubblicazione 18/02/2016
Scopri con un click il nostro voto: 



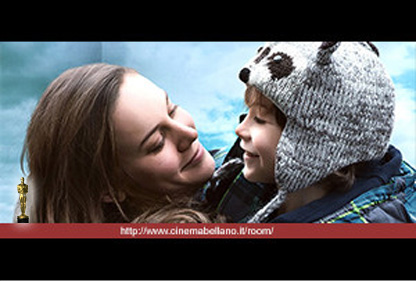




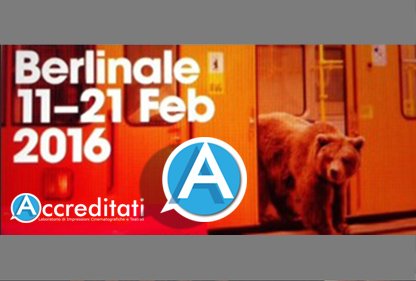




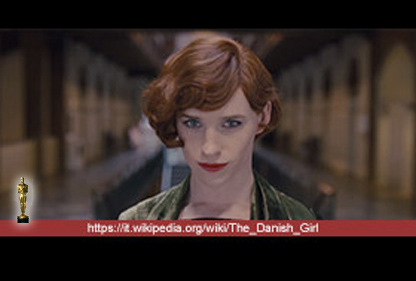





Gli ultimi commenti…