
da Alessandro Rosi | Gen 12, 2017
(Teatro Quirino – Roma, 10/29 Gennaio 2017)
“Il riscatto di una donna che non conosce la legge, ma sa cos’è la giustizia”
Non si dà pace Domenico Soriano – ricco dolciere napoletano –, mercé un’astuta gherminella, Filumena (la cocotte con cui conviveva da venticinque anni) l’ha indotto a sposarla in fin di vita, in modo da evitare che Don (giovanni) Domenico l’abbandonasse per contrarre matrimonio con una donna più giovane.
Il piano architettato da Filumena non è tuttavia volto a estorcere denaro al marito, bensì a garantire un futuro ai suoi tre figli oramai adulti. Appresa la notizia della copiosa prole, Domenico reagirà furiosamente, ma resterà pietrificato dalla sorpresa che lei gli ha riservato: uno dei tre figli è suo. La rivelazione permetterà all’imprenditore di maturare quel senso di paternità che non l’aveva mai lambito, però sarà divorato al contempo dal dubbio di quale dei tre sia il suo discendente naturale. Ed è proprio senza svelare a Domenico la verità che Filumena riuscirà a proteggere ognuno dei suoi figli: ” ‘E figlie so’ figlie e so’ tutt’eguale!”.
La commedia di De Filippo, scritta nel 1946 e forgiata sulla base di una storia vera, pone in risalto i valori cristiani della maternità e della famiglia, in contrasto con il denunciato sfruttamento delle classi borghesi, e si inserisce proprio in quegli anni di scontro tra forze cattoliche (Democrazia Cristiana) e di sinistra. La versione proposta da Liliana Cavani è senza stravolgimenti e fedele all’originale; alleggerita in alcuni punti (togliendo opportunamente la figura della sarta) e rappresentata in dialetto napoletano.
Gli attori si muovono con disinvoltura sul pavimento a scacchiera presente sul palco, sulle linee invisibili tracciate con arte sapienziale dalla regista emiliana – alla sua prima esperienza nella direzione di uno spettacolo teatrale.
La compiutezza dell’opera si nota anche dall’accuratezza della messinscena realizzata da Raimonda Gaetani, e segnatamente: nella selezione dell’arredamento “stile 900”, come descritto da De Filippo nel testo; nell’abbinamento dei colori dei costumi con quelli degli elementi scenici; nella scelta del quadro con due destrieri (bianco e nero) appeso alla parete della sala da pranzo, che simboleggia la passione di Soriano per le corse ma anche l’unione degli opposti (Domenico e Filumena). Scelte non casuali, che sottolineano la cura per il dettaglio, la ricercatezza e l’eleganza dell’allestimento.
Seppur un principio incerto – l’uso iniziale del dialetto napoletano stretto (talvolta di faticosa comprensione) e il taglio di alcuni dialoghi, che non consentono un’immediata contestualizzazione della vicenda – la narrazione procede speditamente, arricchita dalle battute degli attori, con cui si ride di gusto. Se da un lato risulta apprezzata l’evidenziazione dei momenti più divertenti, parimenti appare eccessiva l’esasperazione di alcune scene – in particolare quella finale –, che nonostante permetta a Mariangela D’Abbraccio di esibirsi in tutta la sua bravura, sembra sproporzionata rispetto al resto dell’opera.
Quanto alla straordinaria interpretazione di quest’ultima, la sua figura rievoca l’inimitabile Titina De Filippo (per cui in origine era stata scritta l’opera dal fratello Eduardo), la sua chioma corvina e i suoi occhi morati rifulgono sul suo incarnato madreperlaceo, ogni suo gesto è una scarica di emozioni che percorre tutto il corpo, le sue parole vibrano nell’aria come fendenti di sciabola che si scagliano contro il marito; il quale è reso magistralmente da un affascinante Geppy Gleijeses, che dona al suo personaggio quel tocco in più di spavalderia che non guasta. Alla stessa stregua delle due precedenti, si pongono le prove attoriali di Mimmo Mignemi (Alfredo Amoroso: collaboratore di Domenico Soriano) e Nunzia Schiano (Rosalia Solimene: domestica e confidente di Filumena); e non da meno sono gli altri attori che si avvicendano sul palco, per una compagnia brillante e in perfetta sintonia. Applausi a scena aperta da parte di un pubblico pieno d’autorità, tra cui spicca il presidente della Repubblica: Sergio Mattarella.
Una commedia che, nonostante abbia più di settant’anni, rimane tuttora attuale. Il riconoscimento della tutela per i figli illegittimi, oltre alla possibilità di ricorre alla prova del DNA per conoscere la paternità, non toglie forza alla lotta di una donna di strada per far valere un diritto che la legge non le riconosce: quello di crescere dignitosamente i propri figli. E quale altra donna, se non Filumena (dal greco philos “amico” e menos “forza”: amica della forza) può portare avanti una battaglia del genere; lei che non ha mai pianto in vita sua, perché: “Sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non si può avere. Ma Filumena Marturano il bene non lo conosce; quando si conosce solo il male, non si piange”.
data di pubblicazione 12/01/2017
Il nostro voto: 

da Antonietta DelMastro | Gen 8, 2017
 Decisamente un libro adatto a questo periodo; la storia di un’amicizia profonda e sincera che travalica l’età, il tutto condito con ricette da vero gourmet.
Decisamente un libro adatto a questo periodo; la storia di un’amicizia profonda e sincera che travalica l’età, il tutto condito con ricette da vero gourmet.
Isabel e Valerie, sua cara amica, si sono date appuntamento per passare insieme la Vigilia di Natale; durante la cena Valerie esterna tutta la sua preoccupazione per la salute del proprio padre novantenne, Edward, depresso per la recente morte dell’adorata moglie Paula. Questa confidenza e il racconto del rapporto idilliaco tra i due anziani sposi fa crollare Isabel: il suo matrimonio che vacilla nonostante gli sforzi che sta facendo per tenerlo in piedi, l’angoscia di quello che potrebbe accadere e dell’impatto che potrebbe avere sulla figlia ancora piccola, tutti questi risvolti la rendono particolarmente sensibile al racconto dell’amica e la commozione per la splendida storia d’amore tra Edward e Paula è tale che Isabel cede alle pressioni di Valerie e si fa convincere dall’amica a “tenere d’occhio” il padre, andando di tanto in tanto a cena da lui, il quale per altro è appassionato di cucina e ottimo cuoco.
Il loro primo incontro avviene in una fredda sera di febbraio. Isabel si presenta a casa di Edward, quasi biasimando la propria debolezza nell’aver accettato tale compito, ma viene subito irretita dal profumo che arriva dalla cucina: Edward ha preparato una cena squisita, da gustare insieme e farsi compagnia.
Isabel ed Edward non hanno nulla in comune, il mezzo secolo che li separa, anagraficamente parlando, li ha portati ad avere delle esperienze di vita diverse, a compiere scelte diverse, a vedere e vivere la vita in modo completamente diverso. Eppure questo incontro sarà catartico per Isabel …Qualsiasi fosse stata la molla, mai avrei potuto immaginare che quell’incontro mi avrebbe cambiato la vita.
Tra i due nascerà un legame speciale, sincero, affettuoso; le loro cene diventeranno un appuntamento settimanale durante le quali Edward si esibirà in menù raffinati e la loro amicizia diverrà sempre più forte e intima. Edward potrà tenere fede alla promessa di continuare a vivere al suo meglio fatta sul letto di morte all’adorata moglie, e Isabel guarderà con occhi diversi la sua vita: Edward mi stava insegnando l’arte della pazienza, il lusso di rallentare il ritmo e di concedermi il tempo di riflettere su quello che facevo.
Un libro che parla di un’amicizia intensa, un romanzo pieno di tenerezza che ci insegna ad apprezzare la vita. Un romanzo da cui mi sono staccata con difficoltà: mi ero affezionata a Edward, alla sua saggezza al suo modo di “donarla” agli altri, non potevo non immaginare cosa sarebbe potuto succede alla fine e proprio per questo volevo che non arrivasse mai, avrei voluto che la storia, che il diario di questi incontri, di questi scambi, continuasse ancora e ancora e con gli incontri anche gli insegnamenti del caro Edward.
data di pubblicazione: 08/01/2017

da Alessandro Rosi | Gen 7, 2017
(Teatro dei Conciatori – Roma, 6/15 Gennaio 2016)
Uno stupefacente carteggio tra un’apparentemente inconsapevole donna di corte e il suo arguto maggiordomo
“Il sentimento che nutro nei vostri confronti è duro come la roccia, ma la carne è friabile come l’argilla”
Con queste parole la duchessa Dorothy Wellington verga d’inchiostro una delle lettere spedite al marito George, partito per la Cina quattro anni prima (1856) e non ancora tornato dall’Oriente, dove sta combattendo per il Regno Unito nelle cosiddette guerre dell’oppio.
Il messaggio non verrà tuttavia mai letto dal destinatario, atteso che il consorte è deceduto in battaglia. E neppure la notizia della sua morte giungerà alla moglie, giacché Thomas (il maggiordomo di famiglia), per timore di perdere l’incarico a seguito della dipartita del duca, ha sagacemente distrutto la comunicazione del decesso. Per illudere la duchessa che il marito sia ancora vivo, Thomas inizierà a scrivere di suo pugno lettere alla nobildonna; e nonostante qualche esitazione iniziale – il maestro di palazzo, invero, non sa nemmeno leggere molto bene –, si rivelerà abile nel fascinare la signora con le sue parole, ancorché finirà per rimanere stregato lui stesso dal carteggio intrattenuto con Mrs. Wellington.
Lo spettacolo scritto da Antonio Pisu (che interpreta anche la parte del maggiordomo) è allegro e leggero. La sua figura si completa alla perfezione con quella di Tiziana Foschi: lei con il suo volto espressivo – che riesce ad atteggiare a suo piacimento, quasi fosse una maschera d’argilla –, mentre gli sguardi sono meno penetranti; lei con le linee del viso più nette, dure e decise, al contrario di lui con i lineamenti più dolci, tondi e aggraziati; lei con la sua voce stentorea e decisa, lui invece con un timbro più basso e sommesso. Caratteristiche che uniscono gli attori in un rapporto simbiotico, e che suscitano in particolare la curiosità di vedere Antonio Pisu cimentarsi anche in altri ruoli.
I due si muovono abilmente nello spazio scenico realizzato da Tiziana Massaro, reso efficacemente attraverso l’utilizzo di libri simboleggianti la mobilia dell’abitazione, che vengono spostati, fatti cadere, accatastati modellando l’ambiente a seconda della situazione; per le porte sono invece stati utilizzati dei praticabili e sono gli attori a simulare l’apertura e la chiusura delle porte attraverso la loro voce (“clack e clock”).
La rappresentazione risulta vivace e movimentata, sebbene la sua durata eccessiva rischi di minare l’attenzione degli spettatori: l’arte è sottrazione.
“Clack e clock”.
data di pubblicazione:07/01/2017
Il nostro voto: 

da Alessandro Rosi | Gen 6, 2017
(Teatro Argentina – Roma, 5/8 Gennaio 2017)
“Quartetto d’archi per un esilarante sconcerto di musica classica in tempo allegro spiritoso”
Non appena varcato l’ingresso del teatro, sin da subito notiamo un particolare originale: sul palco, oltre al consueto sipario di scena, ve n’è un altro dietro a coprire le quinte. Mentre ci lambicchiamo la mente per indovinare quale artifizio scenico sarà messo in atto, l’incantevole suono di un violino ci sorprende alle spalle, ci carezza l’orecchio e le gote, per poi proseguire sul palco, dove sarà raggiunto dagli altri tre componenti del quartetto d’archi.
Una volta riunita, l’ensemble inizia lo spettacolo con l’esecuzione della Carmen di Pablo Sarasate, componimento romantico dal ritmo spezzettato, alternato. E proprio la melodia del compositore spagnolo permette ai diversi violinisti di esibirsi in un simpatico dialogo, come se ognuno di loro parlasse attraverso lo strumento impugnato, lanciando note (e occhiate di sfida) nei confronti dell’altro. Il significato di PaGAGnini è quindi presto detto: una serie innumerevole di sketch che prendono spunto dalla musica classica.
Un’esibizione musicale che prevede un coinvolgimento costante del pubblico: invitato, prima, a battere con le mani il tempo per accompagnare i brani e, poi, a salire sul palco attraverso due volontari, per poter suonare il Capriccio di Paganini con strumenti del tutto stravaganti. Ma il programma non è incentrato solo sulla musica classica, bensì presenta deviazioni di musica pop (La Javanaise di Serge Gainsbourg) e rock (With or without you degli U2), realizzate sempre in chiave ironica e coinvolgente.
La collaborazione tra Yllana, collettivo artistico da cui sono stati scelti i musicisti, e Ara Malikian, ideatore dello spettacolo nonché brillante violinista libanese, consente la messinscena di un concerto eccitante e curato nei particolari. L’uso oculato e attento delle luci, il fumo sul palcoscenico (che conferisce un tocco di eleganza alla rappresentazione), i perfetti tempi scenici – scanditi attentamente da David Ottone e Juan Francisco Ramos – plasmano una rappresentazione ibrida, un misto tra teatro e concerto.
Ancorché qualche stonatura, alcune corde rotte e l’uso dell’amplificatore per diffondere il suono, potrebbero far storcere il naso al melomane più pedante, lo spettacolo si apprezza per la sua carica innovativa e divertente. D’altronde, l’euforia portata sul palco da Eduardo Ortega è contagiosa, alla stregua della falsa irriverenza mostrata Thomas Potiron, che strappa diversi sorrisi; simpatica altresì l’interpretazione di Fernando Clemente, un buffo Charlie Chaplin dai modi di Gainsbourg, e dirompente l’energia messa sul palco da Jorge Fournadjiev (violoncello).
Un’ora e un quarto di allegria; un toubrillion di risate che dimostra come si può sorridere anche con la musica classica
data di pubblicazione:06/01/2017
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 6, 2017
Florence Foster Jenkins, ricchissima ereditiera e figura di spicco del “jet set” newyorkese degli anni quaranta, è intimamente convinta di essere dotata di un buon talento vocale per diventare una eccellente cantante lirica. Nella realtà però il suo canto è gracchiante e sgradevole, privo di una qualsiasi coloritura timbrica e di una benché minima tecnica sonora. Incoraggiata dal (poco) fedele marito St. Clair Bayfield e da Cosmé Mc Moon, il pianista personale che l’accompagna nelle disastrose esibizioni musicali, Florence riuscirà ad organizzare un recital personale alla famosa Carnegie Hall con il pretesto di intrattenere le truppe impegnate al fronte, durante il secondo conflitto mondiale. Il prevedibile fiasco porterà con sé la consapevolezza che il fermo e irrinunciabile desiderio canoro di Florence era solo una chimera e che i successi sinora ottenuti erano solo una farsa organizzata dal consorte con la complicità di un pubblico compiacente e di una critica abilmente manipolata.
Il film di Stephen Frears (regista britannico che ha firmato pellicole quali Le relazioni pericolose, The Queen e il meno convincente Philomena) racconta al grande pubblico la vera storia di una donna dell’alta borghesia di New York, melomane ed amica personale di Arturo Toscanini, convinta di possedere una voce e doti di cantante che in realtà non possedeva. Questa sua convinzione, affettuosamente sostenuta dal coniuge che la assecondava in tutto perché convinto che il canto era l’unica arma per arginare una brutta malattia che affliggeva la consorte da anni, è anche il punto di forza di questa donna che divenne una sorta di fenomeno, incidendo dischi e tenendo concerti che divennero dei veri e propri “eventi” mondani. Tuttavia Frears porta sul grande schermo una storia non originale: essa è già stata raccontata nel film Merguerite presentato nel 2015 alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, poco apprezzato nelle sale seppur abbia vinto diversi Cèsar (tra cui quello a Catherine Frot nei panni della protagonista), la cui produzione più modesta ha richiesto tempi di lavorazione meno lunghi della attuale versione inglese. Nel cast di Florence oltre al “mostro” Meryl Streep, sono altrettanto (se non di più) indiscutibilmente bravi il mai troppo lodato Hugh Grant, perfetto nel ruolo del marito, e Simon Helberg in quello del pianista che scende ad incredibili compromessi pur di lavorare: sono loro che fanno raggiungere alla pellicola quel sufficiente grado di piacevolezza e divertimento che coinvolge il pubblico sino agli ultimi (stucchevoli) acuti di Florence. Ma, nonostante le candidature dei tre interpreti ai Golden Globe, la sceneggiatura esile del film evidenzia principalmente l’aspetto alquanto caricaturale dei personaggi che, seppur facciano sorridere lo spettatore, distolgono dal dramma reale di questa donna malata, che riesce a vivere la sua viscerale passione per il bel canto grazie ad un marito che a modo suo l’ha amata e le ha consentito di vivere e raggiungere una, sia pur apparente, felicità stonando e strepitando. Florence dopo la sua morte divenne famosa davvero: inevitabile epilogo di ogni artista che si rispetti.
data di pubblicazione:06/01/2017
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Dic 29, 2016
Un’avventura alla scoperta del mondo e di sé stessi, una riconciliazione con la propria “natura”, uno scenario mozzafiato impreziosito da colori roboanti e dalle meraviglie dell’animazione targata Disney.
All’origine dei tempi, quando non esisteva nient’altro se non la distesa infinita dell’Oceano, emerge dalle acque Te Fiti, l’isola madre che, irradiando la propria linfa vitale, offre alimento a tutte le altre isole. L’ordinato equilibrio cosmico è turbato un giorno da Maui, semidio che, rievocando alla mente dello spettatore le gesta mitologiche di Prometeo, decide di rubare il cuore di Te Fiti per donare agli uomini il potere per eccellenza: quello di creare la vita.
Dopo migliaia di anni la piccola Vaiana Waialiki muove i suoi primi passi curiosi sulle spiagge della dell’isola polinesiana di Motunui. Viviana è la principessa dell’isola. Anzi, è la figlia del capo, destinata a guidare una comunità che, immobile in un equilibrio solo in apparenza rassicurante, ripone nella giovane donna tutta la sua fiducia. Nessun abitante dell’isola può spingersi al di là del Reef, la “frontiera” segnata dall’Oceano che delinea il limite delle acque sicure, ma Vaiana è inconsciamente consapevole del fatto che il suo destino la aspetti ben oltre quella linea ideale.
Quando le noci di cocco non restituiscono più il loro frutto e il pesce inizia a scarseggiare, risulta chiaro che la condizione di statica pace che avvolge l’isola è destinata a infrangersi, a meno che
La nonna paterna di Vaiana, assumendo il ruolo di Virgilio del viaggio che di lì a poco sua nipote sarà chiamata a compiere, le indica la via da seguire: Vaiana, solcando i sentieri dell’Oceano, dovrà mettersi alla ricerca di Maui e restituire a Te Fiti il cuore perduto.
La non-principessa diviene quindi la protagonista di un viaggio di scoperta e di iniziazione, che, seguendo anche il fil rouge della fiaba ecologista, la condurrà ben oltre le Colonne d’Ercole del Reef.
Non sembra che la pretesa rivoluzione femminista portata avanti dalla Disney con le sue moderne (non) principesse sia il tratto più caratterizzante di Oceania. Vaiana è indubbiamente una principessa che, come Mulan o Elsa, non ha bisogno del valoroso principe azzurro per completarsi e realizzare le sue aspirazioni, ma questa circostanza, di per sé sola, non dovrebbe più costituire motivo né di sorpresa né di discussione. Quello che invece colpisce in Oceania è l’assenza di una dimensione autenticamente corale, che, pur senza oscurare il bagliore dell’eroe protagonista, riesce solitamente, nei film Disney, ad andare ben oltre la dimensione di un contorno non indispensabile. I personaggi della nonna e di Maui sono indubbiamente ben tratteggiati, ma Vaiana, con il suo individualismo eroico sempre ben in evidenza, resta la protagonista indiscussa e indiscutibile della storia. Neppure i “cattivi” riescono a rappresentare una reale alternativa (sia pur temporanea) alla stella di Vaiana, che splende incontrastata e senza reali momenti di crisi per l’intera durata del film.
Oceania resta in ogni caso uno dei cartoons Disney più riusciti degli ultimi anni (insieme, forse, a Rapunzel). Le impeccabili scelte di animazione offrono uno spettacolo sfavillante e sontuoso agli occhi dello spettatore, restituendo tutta la magnificenza di una Natura che si fonde armoniosamente con la rispettosa presenza dell’Uomo.
Una curiosità. Il titolo originale del film è Moana, che è anche il nome della protagonista nella versione americana della fiaba. Molti Paesi europei hanno però optato per un titolo e un nome diversi. La metamorfosi di Moana in Vaiana, più esattamente, sarebbe dovuta all’eccessiva fama di Moana Pozzi, eroina protagonista di imprese di ben altro genere, che avrebbe (lei sì!) offuscato in maniera imbarazzante la fama della novella (non) principessa Disney. Nomen omen.
Data di pubblicazione: 29/12/2016
Scopri con un click il nostro voto: 
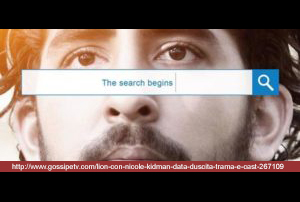
da Maria Letizia Panerai | Dic 26, 2016
Lion racconta la storia tormentata (e vera) di un giovane uomo che si mette in cerca dei suoi familiari di cui ha un ricordo lontano, di quando aveva appena cinque anni, età in cui si perde e non riesce più a ritrovare la strada che lo riporti verso casa.
Saroo, e suo fratello maggiore Ghaddu, sono inseparabili. Vivono in un piccolo paese rurale di una regione dell’India di cui il piccolo Saroo non sa neanche pronunciare il nome; sua madre è analfabeta e si guadagna da vivere trasportando sassi. I due fratelli, per prendersi cura della madre e della sorellina, sono disposti a fare qualsiasi cosa per riportare del cibo a casa: dal furto di carbone sui treni merci che poi rivendono in cambio di un po’ di latte, sino a guadagnarsi la giornata sollevando balle di fieno: “Saroo, sei troppo piccolo per sollevare le balle di fieno”…”io posso sollevare qualsiasi cosa”. E così Ghaddu un giorno si lascia convincere e lo porta con sé ma, non potendo lasciarsi sfuggire l’occasione di guadagnare qualcosa, decide di lasciare il fratellino ancora assonnato sulla panchina di una stazione, con la raccomandazione di non muoversi. Ma la notte è troppo buia per un bambino piccolo come Saroo; rifugiatosi su di un treno vuoto per dormire meglio, si risveglierà dopo un lungo viaggio in una enorme e sconosciuta città: Calcutta.
Lion, lungometraggio d’esordio del regista pubblicitario Garth Davis appena uscito nelle sale italiane, presentato in anteprima mondiale a settembre al Festival di Toronto e come film di chiusura alla 11^ edizione della Festa del cinema di Roma, è tratto dal romanzo autobiografico di Saroo Brierley A Long Way Home da novembre nelle nostre librerie. Anche se in campo cinematografico e letterario non è nuovo venire a conoscenza di storie di bambini alle prese con gli orrori della fame, della violenza e purtroppo della guerra – argomento comunque mai abbastanza trattato per sollevare le coscienze dal torpore in cui spesso vive la nostra società – quella raccontata da Lion-La strada verso casa colpisce perché è una storia diversa dalle altre.
Il film racconta non solo della forza interiore di un giovane venticinquenne che, mantenendo vivi i ricordi di quando aveva appena cinque anni, riesce a ricostruire il lungo percorso fatto nell’allontanarsi da casa, ma affronta anche in modo molto profondo e senza troppi romanticismi il tema delle adozioni, di certe radici che non si possono cancellare né modificare, neanche con un amore incondizionato.
Dev Patel (The Millionaire, L’uomo che vide l’infinito) è molto convincente nella parte di Saroo adulto, Rooney Mara (Carol) è la sua fidanzata, mentre Nicole Kidman, tornata finalmente sugli schermi con un ruolo intenso, veste magnificamente i panni della madre adottiva. Il film è ovviamente molto commovente perché la storia stessa lo è, e quindi rientra tra quelle pellicole che o si amano o si odiano, senza mezze misure. Le scene e la fotografia sono curatissime; tutta la prima parte della storia, girata in alcune zone rurali dell’India e a Calcutta è affascinante ed ha un buon ritmo, a scapito della seconda parte ambientata a Melbourne, che a tratti appare inutilmente lunga e lenta.
Non deve ingannare l’uscita commerciale del film in questi giorni di festa, perché Lion racconta una bella storia di quelle che allargano il cuore, senza tuttavia essere banale, che sicuramente il pubblico premierà anche dopo la pausa natalizia.
Data di pubblicazione: 26/12/2016
Scopri con un click il nostro voto: 

da Accreditati | Dic 23, 2016
Il team di ACCREDITATI augura a tutti un sereno e gioioso periodo di Feste!
Un ringraziamento particolare va a Daniele Panerai, per l’amichevole realizzazione dell’immagine che sintetizza la nostra idea di “Natale accreditato”, ricco di quelle suggestioni che solo lo schermo di un cinema o il palco di un teatro sono in grado di regalare a chi abbia la voglia e la capacità di stupirsi ogni volta quando le luci si abbassano e si apre il sipario.


da Antonio Iraci | Dic 22, 2016
 Il film tratta di un ritiro, poi trasformatosi in una orgia erotico-culinaria, di quattro amici che si chiudono in una villa, nei dintorni di Parigi, con l’intento di mangiare fino alla morte. Il primo dei quattro è Ugo (Ugo Tognazzi) chef di un ristorante, di cui è anche proprietario, che decide di suicidarsi a causa dei continui battibecchi con la moglie. Poi c’è Michel (Michel Piccoli) importante produttore televisivo, divorziato e molto stanco delle vita che conduce. Segue Marcello (Marcello Mastroianni) pilota, con la fissazione per il sesso. Infine Philippe (Philippe Noiret) magistrato che vive ancora con la vecchia balia che lo custodisce gelosamente impedendogli di avere rapporti con le altre donne. I quattro amici quindi si riuniscono in questa villa, facendo grandi scorte di cibo e predisponendosi a grandi abbuffate che li porteranno alla morte. Nella loro ferma determinazione suicida verranno aiutati da Andréa (Andréa Ferréol) che era entrata nel giardino della villa per accompagnare una scolaresca in visita. Avendo subito intuito il motivo di quella strana riunione tra amici decide di rimanere con loro per aiutarli nel loro intento fino alla morte di tutti e quattro. Il film presentato a Cannes fu subito stroncato dalla critica e pesantemente censurato per le esplicite scene di sesso nonché per alcune situazioni ritenute veramente volgari e offensive. Stranamente fu invece accolto molto favorevolmente dal pubblico che ne diede una lettura sociale, una spietata critica alla società dei consumi e del benessere, condannata ad una inevitabile autodistruzione, passando da una degradazione dell’uomo in tutte le sue manifestazioni della vita comune. Non a torto il film sembrò anticipare di un paio d’anni un altro “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pasolini, anch’esso salvato dall’ira dei critici proprio per il coraggio dimostrato dai due registi di saper affrontare, in maniera graffiante, delicati temi della società moderna. Ugo, nel film, tra le tante pietanze prepara un pasticcio di fegato che ci suggerisce questo patè, ottimo per farcire dei crostini molto saporiti da servire come antipasto.
Il film tratta di un ritiro, poi trasformatosi in una orgia erotico-culinaria, di quattro amici che si chiudono in una villa, nei dintorni di Parigi, con l’intento di mangiare fino alla morte. Il primo dei quattro è Ugo (Ugo Tognazzi) chef di un ristorante, di cui è anche proprietario, che decide di suicidarsi a causa dei continui battibecchi con la moglie. Poi c’è Michel (Michel Piccoli) importante produttore televisivo, divorziato e molto stanco delle vita che conduce. Segue Marcello (Marcello Mastroianni) pilota, con la fissazione per il sesso. Infine Philippe (Philippe Noiret) magistrato che vive ancora con la vecchia balia che lo custodisce gelosamente impedendogli di avere rapporti con le altre donne. I quattro amici quindi si riuniscono in questa villa, facendo grandi scorte di cibo e predisponendosi a grandi abbuffate che li porteranno alla morte. Nella loro ferma determinazione suicida verranno aiutati da Andréa (Andréa Ferréol) che era entrata nel giardino della villa per accompagnare una scolaresca in visita. Avendo subito intuito il motivo di quella strana riunione tra amici decide di rimanere con loro per aiutarli nel loro intento fino alla morte di tutti e quattro. Il film presentato a Cannes fu subito stroncato dalla critica e pesantemente censurato per le esplicite scene di sesso nonché per alcune situazioni ritenute veramente volgari e offensive. Stranamente fu invece accolto molto favorevolmente dal pubblico che ne diede una lettura sociale, una spietata critica alla società dei consumi e del benessere, condannata ad una inevitabile autodistruzione, passando da una degradazione dell’uomo in tutte le sue manifestazioni della vita comune. Non a torto il film sembrò anticipare di un paio d’anni un altro “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pasolini, anch’esso salvato dall’ira dei critici proprio per il coraggio dimostrato dai due registi di saper affrontare, in maniera graffiante, delicati temi della società moderna. Ugo, nel film, tra le tante pietanze prepara un pasticcio di fegato che ci suggerisce questo patè, ottimo per farcire dei crostini molto saporiti da servire come antipasto.
INGREDIENTI: 600 grammi di fegatini di pollo – 150 grammi di burro – una cipolla bianca grande – 2 foglie d’alloro – mezzo bicchiere di cognac – sale e pepe qb.
PROCEDIMENTO: Fare sciogliere a fuoco lento in una terrina il burro e aggiungere la cipolla bianca finemente tritata e lasciarla imbiondire. Aggiungere i fegatini ben lavati e fare cuocere a fuoco più sostenuto per circa mezzora insieme alle foglie d’alloro, con un poco di sale e pepe. A fine cottura aggiungere il mezzo bicchiere di cognac e lasciare sfumare. Appena i fegatini si saranno intiepiditi frullare il tutto e sistemare in una forma e conservare in frigo. Il patè, prima di essere usato spalmato sui crostini, va comunque portato a temperatura ambiente.

da Antonio Iraci | Dic 22, 2016
 Alla vigilia dei Giochi Olimpici di Roma del 1960, in un piccolo paesino calabro, un ragazzo appena tredicenne chiamato Mimì (Santo Polimeno) di famiglia molto disagiata, si allena come atleta di nascosto al padre (Diego Abatantuono) che invece gli impone di studiare per raggiungere una posizione sociale e migliorare la condizione economica familiare. La madre (Thérèse Liotard), accordasi della passione del figlio, lo difende energicamente e prende posizione contro il padre despota. In aiuto del ragazzo interverrà Felice (Gian Maria Volontè) che pur lavorando come autista di corriera, troverà il tempo per diventare l’allenatore personale di Mimì. Il ragazzo seguirà attentamente tutte le gare podistiche delle Olimpiadi entusiasmandosi ancora di più e convincendosi che quello sarà l’obiettivo della sua vita. Infatti Mimì riuscirà a realizzare il suo sogno e riuscirà ad ottenere la sua prima vittoria da campione proprio a Roma durante i giochi della Gioventù. Il film colpisce per la delicatezza del tema trattato e per la naturalezza della recitazione del giovane, scelto dal regista in maniera del tutto casuale tra gente non professionista dello schermo. Ottima anche la recitazione di Gian Maria Volontè che ottenne anche un premio secondario al Festival di Venezia di quell’anno, specialmente per l’uso molto appropriato dell’espressione dialettale locale. La Calabria, con i suoi contrasti di sapori, ci propone una ricetta saporita: panzerotti calabri.
Alla vigilia dei Giochi Olimpici di Roma del 1960, in un piccolo paesino calabro, un ragazzo appena tredicenne chiamato Mimì (Santo Polimeno) di famiglia molto disagiata, si allena come atleta di nascosto al padre (Diego Abatantuono) che invece gli impone di studiare per raggiungere una posizione sociale e migliorare la condizione economica familiare. La madre (Thérèse Liotard), accordasi della passione del figlio, lo difende energicamente e prende posizione contro il padre despota. In aiuto del ragazzo interverrà Felice (Gian Maria Volontè) che pur lavorando come autista di corriera, troverà il tempo per diventare l’allenatore personale di Mimì. Il ragazzo seguirà attentamente tutte le gare podistiche delle Olimpiadi entusiasmandosi ancora di più e convincendosi che quello sarà l’obiettivo della sua vita. Infatti Mimì riuscirà a realizzare il suo sogno e riuscirà ad ottenere la sua prima vittoria da campione proprio a Roma durante i giochi della Gioventù. Il film colpisce per la delicatezza del tema trattato e per la naturalezza della recitazione del giovane, scelto dal regista in maniera del tutto casuale tra gente non professionista dello schermo. Ottima anche la recitazione di Gian Maria Volontè che ottenne anche un premio secondario al Festival di Venezia di quell’anno, specialmente per l’uso molto appropriato dell’espressione dialettale locale. La Calabria, con i suoi contrasti di sapori, ci propone una ricetta saporita: panzerotti calabri.
INGREDIENTI: 400 grammi di farina bianca “00” – un dado di lievito di birra – latte qb – 200 grammi prosciutto cotto – 200 grammi mortadella – 200 grammi mozzarella per pizza – olio per frittura – sale e pepe qb.
PROCEDIMENTO: Aggiungere alla farina piano piano il latte tiepido dove è stato fatto sciogliere il lievito di birra. Aggiungere un pizzico di sale e lavorare bene il tutto sino ad ottenere un impasto morbido. Lasciare riposare. Intanto preparare il condimento tagliando a listarelle sottili il prosciutto, la mortadella e la mozzarella, aggiungere un poco di pepe. Dividere l’impasto in piccole porzioni, spianare con il mattarello in modo da ottenere dei ravioli del diametro di circa 12 centimetri. A questo punto riempire i panzerotti con il ripieno già preparato e richiudere a mezza luna stando bene attenti che i bordi, precedentemente inumiditi, siano ben sigillati. Una volta preparati si può procedere alla frittura. Sistemare i panzerotti su carta da cucina assorbente e servire poi ben caldi.












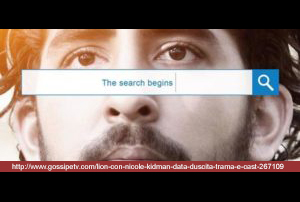










Gli ultimi commenti…