
da Antonella Massaro | Gen 17, 2017
La storia di un marchio e di un’impresa che contribuiscono a definire il volto della ristorazione postmoderna e globalizzata, ma anche l’anima nera di un sogno americano disposto a cedere al compromesso dell’ascesa (sociale prima ancora che economica) senza scrupoli pur di appropriarsi di un’idea e di “fondarne” il successo. La storia del marchio McDonald’s e degli archi dorati che hanno unito il mondo portata sul grande schermo da un impeccabile Michael Keaton.
I fratelli Dick e Mac McDonald (Nick Offerman e John Carroll Lynch) riescono a risollevarsi dall’abisso della crisi economica del 1929 con un’idea tanto semplice quanto geniale: superare l’ormai vetusto e inappagante modello del Drive in attraverso un ristorante senza stoviglie, senza tavoli, senza camerieri. Un’efficiente catena di montaggio garantisce che un gustoso hamburger e delle patine fritte sempre dorate al punto giusto arrivino in pochi secondi in un sacchetto di carta e quindi tra le mani affamate dei clienti. Niente attesa, niente ordini confusi da cameriere troppo intente a evitare le insidie degli avventori, niente facce poco raccomandabili dentro e fuori il locale. Il know how si chiama “metodo espresso”. Il risultato risponde al nome di McDonald’s: un paradiso per famiglie destinato a rivoluzionare il modo di fare e concepire la ristorazione.
Per i fratelli McDonald, però, la rivoluzione passa necessariamente attraverso un controllo minuzioso della qualità: non sono disposti a cedere sul numero di cetrioli o sulla quantità di senape che compone ogni hamburger, anche se questo significa rinunciare alla possibilità di estendere il marchio attraverso un sistema di affiliazioni che, muovendo da San Bernardino, porti gli “archi dorati” in giro per l’America. L’incontro con Ray Kroc (Michael Keaton) sconvolgerà le vite e i principii di Dick e Mac e farà di McDonald’s il nuovo simbolo dell’America postmoderna, accanto alle croci delle Chiese e alle bandiere dei Tribunali.
Con The Founder Jon Lee Hancock raccoglie la difficile sfida di raccontare l’anima nera del sogno americano, l’ambizione senza scrupoli di chi, non avendo idee in grado di imporsi sul mercato, non esita ad appropriarsi delle idee altrui, la guerra “ratto contro ratto” che regola il mondo degli affari. Il tutto senza però sconfinare in tinte noir o drammatiche e senza cedere alla tentazione di scavare nelle viscere esistenziali degli uomini che hanno contributo a “fondare” il mondo globalizzato (vedi, tra i tanti, Steve Jobs). Ray Kroc è banalmente spregiudicato, desideroso di un’ascesa sociale (prima ancora che economica) che non ha nulla di incomprensibile e che in certi momenti riesce addirittura a generare una sinistra empatia nello spettatore.
La prova di Michael Keaton, dopo la ribalta mondiale di Birdman e Il caso Spotlight, è impeccabile. La pochezza e la straordinarietà di un uomo che ha “fondato” un impero si amalgamano impeccabilmente nel personaggio di Ray Kroc e i quasi 120 minuti di proiezione scorrono senza difficoltà tra le pieghe di una storia ben costruita e ben raccontata.
data di pubblicazione: 17/01/2017
Scopri con un click il nostro voto: 
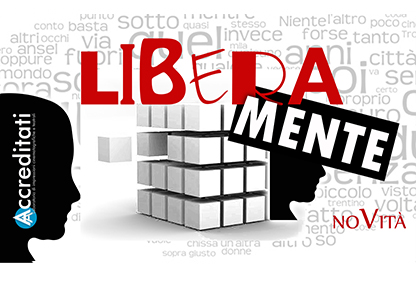
da Alessandro Rosi | Gen 16, 2017
(Ara Pacis – Roma, 14/10/2016 – 30/10/2017)
Realtà aumentata, ma vista appannata.
Un pennello virtuale dipinge l’altare dedicato alla Dea Pace per celebrare il ritorno dell’imperatore Augusto dalle spedizioni pacificatrici in Spagna e Gallia. Dal 14 ottobre 2016 è possibile visitarla anche di sera (dalle 19.30 alle 24) nella sua affascinante veste notturna, con l’innovativa esperienza di Augmented Reality (Realtà Aumentata), tramite occhiali multisensoriali.
Sebbene attraverso i visori AR (Samsung Gear VR) il monumento augusteo si colori, l’effetto non è soddisfacente. La definizione è scarsa – si deve stare attenti a mettere a fuoco l’occhiale, muovendo una rotella ubicata sopra gli stessi; occorre tenere il visore posizionato sopra gli occhi con la propria mano – e, dopo quaranta minuti di guida, si accusa la fatica; la sensazione che si avverte a fine visita è di fastidio agli occhi – simile a quella provata dopo aver visto un film in 3D.
Durante la proiezione del filmato, non si può inoltre staccare l’occhiale per confrontare l’immagine resa dal visore (seppur sfocata) con quella reale, perché al suo interno vi è un sensore che rileva la presenza (o meno) di un soggetto; perciò, una volta staccato, si è costretti a guardare il filmato daccapo. Oltre ai video che si sovrappongono al monumento, si è accompagnati dalla voce stentorea di Luca Ward (il doppiatore di Russell Crowe ne Il gladiatore), le cui spiegazioni appaiono tuttavia alquanto approssimative.
Non si vede pertanto l’opportunità di investire dodici euro per un’esperienza ancora da perfezionare, tutt’al più conviene acquistare la più esaustiva (ed economica) guida audio, al costo di soli sei euro.
data di pubblicazione: 15/01/2017

da Alessandro Rosi | Gen 15, 2017
(Teatro Belli – Roma, 10/22 gennaio 2017)
“Un bando europeo da assegnare. Una regista teatrale da aiutare. Un’improvvida soluzione tutta da gustare.”
Silenzioso tramestio. Rumoroso vociare. Un gesto invita a far presto. Lo spettacolo deve iniziare.
Arriva trafelato, facendosi largo tra il pubblico, il terzo componente della Banda dell’Uku. Ma non sono loro a dover andare in scena; sono lì perché il barista del Teatro gli ha concesso uno stretto angolo di tempo per poter provare.
Accade però un imprevisto: il protagonista dello spettacolo non può recitare, a causa di un volo cancellato. E allora il verace barista prende in mano la situazione e si propone alla regista come sostituto, unendo alla sua prestazione quella della banda.
Ne nasce uno spettacolo spiritoso e leggero, dove si è intrattenuti dalle battute dell’energico Fabio Avaro e dalle canzoni pizzicanti del trio, che si cimentano, tra l’altro, in una riuscita rivisitazione del celeberrimo sketch di Monty Python: la partita di filosofia.
Il testo di Vanina Marini ha diversi punti deboli, suturati faticosamente dalle scene comiche. La prima parte, in cui il barista tenta di convincere la regista, non procede con speditezza; meglio invece la seconda, dove si entra nel cuore dello spettacolo.
L’interpretazione di Fabio Avaro è interamente in dialetto romano: per chi ama il genere, senza ombra di dubbio apprezzerà il suo vigoroso personaggio. Opaca, al contrario, la prova di Vanina Marini, impegnata in un ruolo non agevole.
Cala il purpureo sipario. Le luci si spengono. Lo spettacolo si è concluso. “Ma si riparte sempre”.
data di pubblicazione:15/01/2017
Il nostro voto: 

da Rossano Giuppa | Gen 15, 2017
(Teatro Argentina – Roma, 10/22 gennaio 2017)
Ancora a Roma il Macbeth di Shakespeare, questa volta al Teatro Argentina, in scena dal 10 al 22 gennaio con Franco Branciaroli nella doppia veste di regista ed attore. Macbeth è un’opera complessa, aspra, gotica, sovrapposta, nella quale il linguaggio, già di per sé metaforico, acquista più che mai valore di simbolo, visionario e trascendente.
Scritto tra il 1605 e il 1608, Macbeth racconta la vicenda del vassallo del re Duncan di Scozia che, divorato dall’ambizione e dalla brama di potere, rivelatagli dalla profezia di tre streghe, insieme alla moglie progetta ed esegue l’omicidio del re per salire al trono. Le conseguenze saranno funeste perché la loro coscienza sarà incapace di sopportare l’atroce gesto compiuto. E’ il trionfo dei demoni dell’io, che sovvertono l’ordine morale interno ed esterno dei personaggi fino alle estreme conseguenze, attraendoli e condannandoli al tempo stesso, per il misterioso richiamo che l’uomo da sempre avverte nei confronti del male.
Prodotto dal Centro Teatrale Bresciano e dal Teatro degli Incamminati, il Macbeth rappresentato si snoda attraverso sentieri di sangue e tenebre che affondano le radici in un malessere psichico interiore. Infatti la regia di Franco Branciaroli colloca la vicenda in uno spazio scenico essenziale che è la proiezione dei sentieri più tetri e nascosti della mente umana.
Macbeth è un debole manipolato dalle donne, un crudele per caso. A sovrastare la sua volontà c’è la Magia Nera, impersonata dal fascino cupo delle Streghe e di Lady Macbeth (una efficace Valentina Violo), che condurranno l’uomo verso ciò che di terribile è già dentro di sé, ma fatica ad esternarsi per inadeguatezza. Un personaggio ambiguo, razionale e irrazionale, complesso. Un debole che si racconta nelle sue molteplici sfumature attraverso un continuo e doloroso alternarsi di parole non supportate da altro in scena, una forza verbale utilizzata come strumento musicale accompagnato dalla capacità interpretativa degli altri otto (bravi) attori.
I sottotitoli e le didascalie proiettati sul fondale identificano come un deus-ex-machina i luoghi in cui si svolgerà la vicenda, mentre le creature demoniache confondono la scena con strane ed efficaci incursioni nel testo originale in lingua inglese.
Le luci oniriche e spettrali di Gigi Saccomandi rappresentano forse l’elemento tecnico di maggiore impatto, in grado di dare un contributo determinante nella creazione dell’atmosfera scenica. Interessanti i costumi di Gianluca Sbicca, barocchi ed evocativi, così come la scenografia di Margherita Palli, una scatola nera e quasi trascendente con un gioco di dislivelli e di varchi che si aprono e si chiudono.
Penalizza certamente la forza dello spettacolo la scelta di eliminare qualsiasi accompagnamento musicale ed anche l’indirizzo di una recitazione un po’ troppo intima e chiusa, asciutta, che finisce per rallentare il ritmo e depotenziare la drammaticità e la coralità della vicenda. Implode la forza del male e del dolore in un dramma della solitudine e della sconfitta assoluta.
data di pubblicazione:14/01/2017
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 13, 2017
Emad e Rana sono felicemente sposati ed il loro è un rapporto molto stabile sia nell’ambito domestico, che in quello teatrale dove entrambi sono impegnati come protagonisti sulla messa in scena del celebre dramma Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. A causa di un cedimento strutturale dell’edificio dove abitano, sono costretti a trasferirsi temporaneamente in un appartamento messo generosamente a disposizione da un altro attore della compagnia. La casa in precedenza era abitata da una donna con un vissuto che i vicini ritengono poco raccomandabile, dato il frequente via vai di uomini che andavano a trovarla. Per una circostanza meramente fortuita Rana viene aggredita in casa da un uomo mentre è in bagno a fare una doccia: da quel momento la coppia comincia avere dei “cedimenti strutturali” come simbolicamente evidenziano le crepe sui muri della loro camera da letto.
Asghar Farhadi, regista, sceneggiatore e produttore iraniano noto in campo internazionale, nel 2011 è stato insignito dell’Orso d’oro a Berlino per il film Una separazione, successivamente premiato anche ai Golden Globe e con l’Oscar come miglior film straniero. Con Il Cliente Farhadi propone una attenta riflessione su un dramma nato all’interno del nucleo familiare, ma che si relaziona con un contesto sociale più generale, quello del suo paese, dove ancora risultano molto evidenti le contraddizioni che caratterizzano l’atteggiamento comune dei confronti delle donne. Rana, la protagonista femminile, apre incautamente la porta di casa ad uno sconosciuto convinta che sia il marito, ma l’aggressione da parte dell’intruso, che immediatamente fugge, la umilia profondamente per essere stata vista nuda dai vicini accorsi in suo aiuto sentendo le sue grida. Ciò che pensa la gente è la sua vera violenza. Emad, il marito, dal canto suo rimane sconvolto per quanto accaduto, ma di fronte all’ostinazione della moglie di non voler sporgere denunzia alla polizia, inizia da solo una caccia spietata verso l’aggressore con il reale intento di lavare l’oltraggio subito. E’ dunque la vendetta l’unica cosa che lo interessa. Lentamente l’intesa tra marito e moglie sembra sgretolarsi, alimentata solo da senso di paura, sfiducia ed onore ferito.
L’abilità cinematografica del regista, oltre ad evidenziare uno studio profondo sulla personalità dei due protagonisti, si basa sulla capacità di saper porre lo spettatore di fronte a due drammi distinti, ma per alcuni tratti convergenti, che riguardano rispettivamente l’accaduto e ciò che invece viene rappresentato nell’azione teatrale, in cui i due si trovano a recitare in coppia.
In entrambi ci si focalizza sulla figura maschile, ancora troppo egocentrica nel tessuto sociale: l’uomo, al centro della scena, vede mettere in seria discussione i propri principi etici e non si riconosce in una società in rapida evoluzione, non riuscendo o non volendo essere al passo con i tempi. Bravissimi gli interpreti.
data di pubblicazione:13/01/2017
Scopri con un click il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Gen 13, 2017
Nel paese dei giganti San-guinario, Inghiotti-ciccia viva, Scrocchia-ossa, Ciuccia-budella, Vomitoso, Spella-fanciulle, Strizza-teste, Trita-bimbo, Scotta-dito, ce n’è uno meno gigante di loro. Ha grandi orecchie come due parabole pronte a captare ogni desiderio degli urbani, si ciba solo di vegetali e non di bambini come gli altri, e per la sua “piccola” statura è deriso e sbeffeggiato. Il suo lavoro consiste nel catturare i sogni immergendosi nelle acque del mondo dei sogni, chiuderli dentro dei barattoli per poi insufflarli con la sua particolare tromba nella mente degli urbani durante la notte, senza essere visto, allo scopo di renderli felici. Una notte, con la sua borsa piena di sogni mentre scavalca con pochi grandi passi i palazzi londinesi viene visto dalla piccola Sophie che, ancora sveglia, aspetta l’ora delle streghe affacciata al balcone dell’orfanotrofio dove vive insieme ad altri bambini. Il gigante la afferra e la porta via con sé.
Sophie è sola al mondo, ma tanto curiosa del mondo: nella mano del gigante in pochi minuti sorvolerà Londra e si ritroverà nella sua caverna, come in un altro emisfero dove vivono esseri molto diversi dagli umani come lei. Lo spavento iniziale lascerà immediatamente il posto alla curiosità: quel gigante dolce e gentile, che lei chiamerà GGG, non potrà che farle scoprire cose fantastiche. La loro complicità troverà però filo da torcere nella forza distruttrice degli altri giganti, grandi come montagne, sanguinari e cattivi, sempre in cerca di urbani da mangiare. Come sbarazzarsi di loro, per evitare che con goffi e violenti movimenti possano distruggere tutti quei sogni che GGG custodisce tanto gelosamente nella sua caverna?
E così il settantenne Steven Spielberg ci insegna a sognare! Il suo gigante, ghiotto di cetrionzoli e sciroppio, ci svela il segreto dell’ascolto, attraverso il quale si può sconfiggere i cattivi e guarire tutti i mali del mondo. Ha gli occhi buoni come l’indimenticato E.T. e parla una lingua strana che diventa subito familiare.
Adattamento dell’omonimo romanzo per l’infanzia scritto dal britannico Roald Dahl, autore de La fabbrica di cioccolato portato con successo sul grande schermo da Tim Burton grazie al suo attore feticcio Johnny Depp nella parte di Willy Wonka, Il Grande Gigante Gentile è una favola adatta ai bambini che diverte tanto anche i grandi. Si parla di sofferenza, di difficoltà, addirittura di bullismo quando GGG viene deriso dagli altri giganti, ma Spielberg fedele al testo indica anche la strada per il riscatto e la speranza. Saper ascoltare, sforzarsi di capire lingue ed usanze diverse è il messaggio del film; ma soprattutto la gentilezza, quella con la G maiuscola, sentimento che accomuna Sophie e GGG, due esseri diametralmente opposti: essa fa scattare tra loro un’immediata empatica complicità atta a superare ogni tipo di barriera, anche le più impensabili. Il finale poi, che vede i due protagonisti al cospetto della Regina nelle stanze di Buckingham Palace, è quanto di più ironico si possa immaginare. Film molto divertente da vedere con gioia, possibilmente su un maxi schermo e con un bel bidone di popcorn!
data di pubblicazione:13/01/2017
Scopri con un click il nostro voto: 

da Gabriella Ricciardi | Gen 12, 2017
(Complesso del Vittoriano – Roma, 11 Novembre 2016 / 29 gennaio 2017)
L’ondata di gelo che si è riversata su Roma non ha risparmiato nemmeno le sale del Complesso del Vittoriano che ospita la mostra di Ligabue. Anche lì il freddo era purtroppo così penetrante da distogliere l’attenzione che la bella mostra richiede e vorrebbe.
Freddo a parte, la mostra raccoglie circa cento lavori di Antonio Ligabue, dagli esordi intorno agli anni ’20 fino al ’65, anno della sua morte, ed è curata da Sandro Parmiggiani, che oltre ad essere un amico personale di Ligabue è il Direttore della stessa Fondazione, e da Sergio Negri, Presidente del comitato scientifico.
Prima di entrare in sala, un bel filmato, andato in onda e realizzato da Rai 3 sul finire degli anni ’70, ci proietta immediatamente nel suo mondo. Lo vediamo correre tra le colline della sua Gualtieri, il paese sulle rive del Po dove viveva la madre prima di emigrare incinta, nella Svizzera tedesca dove Antonio nacque e visse fino ai 19 anni e da cui fu poi espulso. Una Gualtieri che lo vide entrare e uscire dall’ospedale psichiatrico e lavorare, senza comunque riuscire a scalfire la miseria ( almeno fino agli anni 50 quando cominciò a vivere della sua pittura) come “scariolante”.
Corre e imita la voce degli uccelli, e la sua mimesi è così totale e perfetta da stimolare le risposte delle cornacchie posate sui rami vicini. È sempre solo Ligabue. Solo nei campi, solo nella poverissima casa-studio dove si prepara a dipingere non senza aver compiuto, prima di farlo, una lunga e straziante serie di gesti scaramantici e apotropaici che dovevano zittire le voci e le presenze nella sua mente, voci nemiche che gli impedivano di dipingere e lo inchiodavano al dolore. Il momento più struggente del filmato è quando appare vestito da donna, con delle sottovesti bianche, per la purezza specifica lui; una lunga gonna che avvolge con attenzione attorno alle gambe magre e si siede sul letto, compunto, davanti a un piccolo fuoco. È la compagna immaginaria, la moglie che avrebbe voluto avere e che invece non avrà mai. Allora trasforma se stesso fino a diventare lui quella moglie tanto desiderata.
Confesso di aver sospeso qui la visione del filmato, perché quella solitudine faceva così male da rischiare di “inquinare” la visione della sua opera che invece ha l’importanza e la dignità di un pittore maturo e compiuto, senza essere quindi schiacciata e trascinata emotivamente dal “caso” Ligabue.
Il mondo animale è quello che sente più vicino, un universo ferino e spietato che dice quanto Ligabue percepisse l’aggressività del mondo. Giaguari, pantere, tigri del bengala, galline, tacchini, aquile che artigliano con ferocia la preda, spesso un cigno dal lungo collo. Sono immersi in una natura dai toni smeraldo e fitta quanto una giungla, mischiando piante e felci di una foresta tropicale con animali dell’aia di casa nostra. La verdissima e brillante foresta ha echi di Gauguin, ma gli animali che Ligabue proietta in primo piano, che siano oranghi o giaguari, hanno la bocca spalancata ed enorme di un boa e nascondono tra denti e lingua i tratti del volto del pittore. I quadri dell’inizio sono più incerti, l’olio più diluito sulla tavola, poi via via Ligabue diventa se stesso, crede nelle proprie capacità pittoriche, è attento alla composizione e non solo all’espressione. I colori si fanno più spessi, sono contornati da pesanti linee nere che ne mettono in risalto l’aspetto materico. Si pensa a Ligabue come a un pittore spontaneo e naif privo di cultura pittorica. Questa mostra invece dimostra come Ligabue guardasse con attenzione le opere degli artisti che lo interessavano, Gauguin e Van Gogh soprattutto, e di come poi li abbia trasformati in materia sua, facendo della Polinesia il cortile di Gualtieri. Colpisce una boule con i pesci rossi che non può non ricordare il famosissimo quadro di Matisse con lo stesso soggetto e titolo. Là erano macchie guizzanti di colore proiettati su un cielo azzurrissimo e felice, qui sono due prigionieri antropomorfi del cristallo. Ti guardano infelici e non c’è nessun cielo dietro, né nessun drappo rosso rubino sul tavolo, dove la boule è posata, a dire di quanta luce è fatto il mondo. Ci sono solo loro, prigionieri della ripetizione in uno spazio angusto.
In ogni quadro c’è lui. Lui che appare in un angolo con il cappello bianco e la sahariana della caccia grossa dal sapore inglese, quadro che apre la mostra. Se ne sta dietro una donna africana come se ne fosse un’emanazione guardinga; anche lì come nel filmato, come se da se stesso potessero venire e conciliarsi due creature.
Con felice intuizione gli autoritratti sono sistemati in sequenza su un’unica parete: Antonio Ligabue col naso dell’aquila che sempre cercava di attenuare, mostrandosi in quello che doveva ritenere il suo profilo migliore, è sempre accompagnato da insetti. Mosche soprattutto, e qualche rara farfalla che ha smarrito ogni bellezza; insetti che ronzano fuori come dentro la mente del pittore, creando un’interferenza fastidiosa tra se stessi e il mondo, che lontano s’indovina più placido di chi lo abita. Qualche casetta allineata sulla collina, una staccionata, un cielo che si avvoltola in nubi violacee che esplodono in tempesta o che sono travolte da un vento turbinoso. In primo piano gli occhi disperati e indagatori di chi portava in giro la sua solitudine come un grido. Questa serie di autoritratti sono davvero bellissimi, belli quanto quelli che siamo abituati ad amare del pittore olandese, con le orecchie lavorate come fossero scavate nel legno, le giacche e i maglioni dai colori forti e quella voglia di bucare il tempo e lo spazio per vincere la solitudine e trovarsi finalmente in mezzo agli uomini.
data di pubblicazione:12/01/2017

da Antonio Iraci | Gen 12, 2017
Clara, critica musicale oramai in pensione, vive accudita da una fedele domestica nell’ Aquarius, un vecchio stabile di pochi piani attorniato dai grattacieli che danno sul lungomare di Recife. Clara è l’unica inquilina rimasta all’intero dello stabile in quanto tutti gli altri proprietari hanno già da tempo venduto i propri appartamenti ad una società immobiliare, dai traffici poco chiari, che intende rilevare in blocco l’intero edificio per costruire abitazioni di lusso. La donna vedova e con i figli oramai sistemati, si troverà a lottare con caparbia ostinazione contro Diego, giovane ambizioso e responsabile del progetto, allo scopo di difendere la casa dove ha sempre vissuto, circondata dai propri affetti e dai ricordi legati ad una giovinezza oramai lontana.
Era il 1985 quando apprezzammo Sonia Braga ne Il bacio della donna ragno di Hèctor Babenco, a distanza di nove anni da quando nel 1976 la vedemmo per la prima volta nel film di Bruno Barreto Donna Flor e i suoi due mariti, basato sull’omonimo romanzo di Jorge Amado: lo sguardo intenso di allora, appena ventiseienne, non è cambiato ed oggi l’attrice brasiliana ritorna sul grande schermo, dopo anni di assenza, quanto mai in forma, e non solo fisicamente. Nel film Aquarius di Kleber Mendonça Filho interpreta una donna caparbia e battagliera, pronta a tutto pur di difendere il proprio appartamento e, soprattutto, quanto di ricordi in esso custoditi, contro una bieca speculazione edilizia decisa a raggiungere il proprio tornaconto a qualsiasi costo. Clara, ammalatasi da giovane di cancro al seno, ne porta ancora orgogliosamente i segni devastanti come “a non voler dimenticare” tutto del passato, le cose belle e quelle brutte, che l’hanno trasformata in quella che è orgogliosamente oggi. Una donna a cui gli anni non hanno affatto cancellato quel suo fare spigliato carico di una esuberante dose di sensualità, in ogni movimento dei fianchi, della folta chioma corvina, mantenendo intatto il ritratto tipico di donna brasiliana ancora piena di vita e che della vita si nutre.
Il film si regge prevalentemente sulla forte personalità del personaggio di Clara e sul carisma della sua splendida interprete, mentre la sceneggiatura appare agli occhi dello spettatore alquanto sfruttata nei suoi tratti essenziali: la speculazione che divora tutto come un cancro, tentando di spazzare via assieme alle vecchie mura dell’Aquarius ricordi e affetti, e la divisione del film (troppo lungo) in tre capitoli come le fasi della vita di Clara, proiettando ricordi del passato, integri e ben custoditi, nello sfacelo del presente corrotto e devastante, sono tutti elementi che nel loro insieme non brillano certo per originalità.
Sicuramente vincente è la splendida colonna sonora che accompagna le scene: famosi brani brasiliani degli anni ottanta che ci rimandano ai tempi d’oro della bossa nova quando anche in Italia imperversavano Carlos Jobim, Joao Gilberto, Toquinho e tanti altri ancora, brani che fanno da supporto ad una ambientazione ricca di saudade e sensualità.
data di pubblicazione:12/01/2017
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Gen 12, 2017
(Teatro della Cometa – Roma, 11/29 gennaio 2017)
Un palcoscenico trasformato in un ring, una serie di coppie che si affrontano in luoghi e tempi diversi, l’impressione dell’eterno ritorno che regola il mistero del rapporto tra Uomo e Donna.
Massimiliano Vado e Michela Andreozzi salgono sul palcoscenico del Teatro della Cometa, allesito per l’occasione con le sembianze di un ring, per riflettere insieme al pubblico sulle dinamiche che regolano il rapporto tra i sessi nell’ambito della coppia.
L’uomo e la donna si attraggono e si respingono, si amano e si tradiscono, si limitano ma in fondo si completano. Da Adamo ed Eva fino alle feste a base di Gin tonic, l’impressione è quella per cui tutto cambi per restare in fondo immutato: il sesso, la routine giornaliera, l’amore travestito da amicizia, l’irresistibile attrazione del colpo di fulmine. Le coppie che in rapida successione si affrontano sul Ring diretto dalla regia di Massimilano Vado sono al tempo stesso ordinarie e speciali, come la quotidianità che raccontano e che, pur nell’esasperazione della mise en scène, strizza l’occhio all’immedesimazione del pubblico.
Il testo, scritto da Léonore Confino, dopo il significativo successo ottenuto in Francia, è attualmente rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo. La versione italiana può contare anzitutto sulla strepitosa interpretazione di Michela Andreozzi, che cambia vesti, accenti e registro di recitazione, conducendo il pubblico, con disinvoltura e talento sia comico sia drammatico, lungo i tumultuosi sentieri dell’eterno ritorno dei rapporti di coppia. Il “ring”, in fondo, è anche l’anello, simbolo per eccellenza del moto perennemente circolare e del legame indissolubile. Massimiliano Vado non sempre si rivela all’altezza della sua compagna di scena (e di vita) e gli inserti video-musicali non si rivelano del tutto adeguati, almeno in certi casi, nella dinamica del ritmo narrativo.
Ring, atto unico di circa novanta minuti, resta comunque uno spettacolo piacevole, che riesce a far sorridere, che lascia aperti degli interrogativi da risolvere e che fa venire la voglia di indossare i guantoni da box per arrivare, in ogni caso, alla fine della sfida.
data di pubblicazione: 12/01/2017
Il nostro voto: 

da Gabriella Ricciardi | Gen 12, 2017
Presentato in concorso a Cannes 69, Paterson di Jim Jarmusch è finalmente nelle sale italiane. Paterson (Adam Driver, lo vedremo tra poco in Silence) fa il conducente di autobus di linea a Paterson nel New Jersey, vive con Laura (la bellissima Golshifteh Farahani) che dipinge tutto quello che trova in bianco e nero, perfino i suoi cupkaes sono in bianco e nero e anche la chitarra che sta iniziando a suonare lo è. Lei è convinta che diventerà una grande cantante country e che i dolci che sforna per il mercato del sabato li arricchiranno, e lui non la smentisce mai, e non perché non capisca che a volte lei esagera con i sogni, ma perché crede nella poesia e non vuole schiacciare la realtà soltanto sulla sua dimensione più evidente, ma non per questo più reale.
La loro è una unione amorosa di piena e dolce complicità, solo il cane Marvin ringhia un po’ quando si scambiano affettuosità, perché anche lui è innamorato della bella Laura. Ma tutta questa ripetitiva vita potrebbe essere noiosa e basta se ad accenderla di una luce incorruttibile non ci fosse la poesia. Sì, perché Paterson è un poeta anche se le sue poesie non le ha mai lette nessuno, solo Laura e non tutte, che adora William Carlos Williams (anche lui nato a Paterson) e che racconta a se stesso – versificandola senza rima – la sua vita e in quel racconto e nello sguardo che posa su tutte le cose che gli accadono, anche se sono sempre le stesse, quelle cose si illuminano di senso, di eleganza e spessore.
Jarmusch con Paterson compie un miracolo, quello di far accadere la poesia sullo schermo e non di raccontarla; vediamo il processo e lo vediamo poeticamente, non è una “registrazione” documentaristica. Vediamo nascere un componimento o guardare le cose come un poeta le guarderebbe per poi riscriverne senza che il processo creativo venga sminuito dal racconto, perché sta accadendo sotto i nostri occhi.
Paterson e Laura sono attenti l’uno all’altra ma non sono mai stucchevoli; il quartiere dove vivono non ha niente di speciale; lei vorrebbe vedere pubblicate le poesie di lui e lo spinge a promesse che poi lui non mantiene, ma questo non le scalfisce l’amore e la stima per il suo compagno. Jarmusch sta bene attento a farci entrare nella loro intimità in punta di piedi. Entriamo sì, nella loro camera da letto, ma mai per assistere a una scena di sesso; li vediamo svegliarsi insieme, cercare la posizione nel letto coniugale, vita che si salda in gesti semplici e quotidiani. La loro è una poesia senza sottotesto perché è evidente e la differenza la fa Paterson. È lui che guarda al mondo senza giudizio, cercando piuttosto di svelarne a se stesso e a noi, le trame segrete da cui è attraversato. Quando, per un odioso incidente di cui è colpevole Marvin, il suo taccuino segreto andrà distrutto, all’improvviso la sua consueta passeggiata, il quartiere, le persone, tutto perde lucentezza e smalto. La realtà si offusca e si spegne, rivelando nient’altro che se stessa. Solo quando Paterson con la complicità di un misterioso poeta di Osaka seduto anche lui davanti alle belle cascate della città, gli dona un nuovo e intonso taccuino, la vita e le cose riprenderanno a brillare di quella luce che solo la poesia è in grado di dare.
Il miracolo di questo film è che è poesia esso stesso, senza manifesti, senza ricorrere ad alcun luogo comune sulla poeticità della vita, rischi che invece si sono manifestati in film come ad esempio Le ricette della signora Toku. Bello senz’altro, ma l’agguato del “film manifesto” su quanto cioè la nostra vita sia piena di per sé di miracoli quotidiani, ne mette in realtà in pericolo l’essenza più segreta e inspiegabile.
Paterson no, resta un haiku perfetto.
data di pubblicazione:12/01/2017
Scopri con un click il nostro voto: 



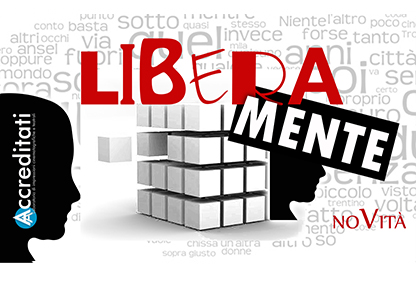















Gli ultimi commenti…