
da Antonella Massaro | Set 3, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Nel Sud più profondo dell’Italia, dove ogni speranza di riscatto sembrerebbe perdersi annientata dall’egoistica logica del più forte, si accende una luce grazie alla Poesia e alla Fede. Una fiaba visionaria, un’ironia capace di raccontare i drammi di un Paese sempre sul punto di rialzarsi in piedi, ma mai capace di farlo fino in fondo.
Nella piccola comunità di Disperata, al centro di un Salento in cui la presenza di Dio si rivela nella bellezza di un paesaggio di struggente perfezione che la mano degli uomini non è però in grado di preservare come meriterebbe, la vita scorre tranquilla e monotona: il bar del paese e il suo stanco immobilismo ne rappresentano forse la sintesi più eloquente.
Il sindaco Filippo Pisanelli (Gustavo Caputo) è un uomo di lettere e di cultura: non ha il carattere adeguato per presiedere le riunioni del Consiglio Comunale, lascia decorrere i termini per ottenere i finanziamenti europei e neppure il piglio di Eufemia (Celeste Casciaro, moglie di Winspeare) riesce a scuoterlo dal suo torpore. La sola attività dalla quale sembra trovare appagante soddisfazione è rappresentata dalle lezioni impartite ai detenuti in carcere. Riesce persino nell’impresa di fare appassionare alla poesia Pati (Claudio Giangreco), malvivente dal cuore tenero che non riesce a perdonarsi l’uccisione di un cane durante una rapina finita male, tentata insieme al fratello Angiolino (Antonio Carluccio). Anche Angiolino, all’apparenza un cinico burbero che gioca a fare il bandito con pistole finte e che si vanta di imprese in realtà mai compiute, conoscerà la sua folgorazione sulla via di Damasco, grazie al provvidenziale intervento di Papa Francesco.
L’arte e la religione, in fondo, sono due vie per avvinarsi a ciò che trascende l’umana miseria, per azzerare le differenze sociali, per sperare che, in fondo, a tutti sia concessa una possibilità di rinascita e di redenzione. Se poi tanti uomini di buona volontà uniscono le forze, si può persino costruire una nuova arca di Noè, capace di salvare l’umanità da un naufragio irreversibile.
La vita in comune, inserito nella sezione Orizzonti di Venezia 74, presenta i tratti tipici della cinematografia di Edoardo Winspeare, cresciuto, non a caso, nella frazione di Depressa, in provincia di Lecce. Il legame con il territorio è evidente e viscerale, i personaggi sono ben caratterizzati e i non-attori cari al regista se la cavano a meraviglia. Inutile negare che, forse, il lavoro di Winspeare non abbia tutte le carte in regole per emergere in una competizione internazionale. La fiaba disincanta e disillusa, la disperazione di Disperata raccontata con i toni da commedia, i bagliori visionari che qualche volta illuminano il film, lo rendono tuttavia un lavoro gradevole.
La scelta del finale, poi, sembra condensare alcune delle più evidenti chiavi di lettura del film: è poetica, è mistica, è dolcemente amara.
data di pubblicazione: 03/08/2017


da Antonella Massaro | Set 3, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
“Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell’occhio tuo?” In un’America che non è disposta a fare i conti con il proprio passato e le proprie colpe, fiorisce la cittadina di Suburbicon, popolata da oneste e benpensanti famiglie tradizionali che si oppongono tenacemente all’arrivo di tre afroamericani. Proprio nella villetta accanto a quella abitata dai “negri” si consuma una tragedia familiare, ma il frastuono delle proteste e dei martelli che costruiscono muri per isolare gli invasori è così assordante da offuscare tutto il resto.
Suburbicon è la città ideale, all’interno della cui perfezione da giornale patinato ciascun americano può realizzare la propria vita da sogno. L’arrivo dei Meyers, una famiglia di afroamericani, turba l’apparente tranquillità della cittadina popolata da oneste famiglie tradizionali, suscitando la strenua opposizione dei comitati di quartiere: i “negri” saranno ben accetti, ma solo quando si mostreranno ben educati e pronti a una convivenza civile.
Nella villetta accanto a quella degli “stranieri” vive la famiglia Lodge: Gardner (Matt Damon), Rose (Julianne Moore) e il piccolo Nicky (l’impeccabile Noah Jupe). Anche zia Margaret (sempre Julianne Moore), gemella di Rose, è solita frequentare casa Lodge. Durante una rapina in casa, Rose resta uccisa. Neppure Suburbicon (il nome, del resto, è tutto un programma) può considerarsi dunque immune dagli episodi di criminalità che scandiscono la vita del “mondo reale”.
Il fuoco del film si sposta a questo punto sui panni sporchi che si lavano nella casa dei bianchi, entra nella casa di Lodge, rendendo evidente che il vero dramma è ben lontano dalle proteste sempre più violente di fronte alla casa dei Meyers. Tutto si svolge sotto lo sguardo di Nicky, di uno di quei bambini che ci guardano dai tempi di De Sica.
Il sesto film che vede George Clooney dietro alla macchina da presa ha una scrittura che risente chiaramente dell’impronta dei fratelli Cohen: un umorismo dissacrante, che ridicolizza i cattivi senza però creare con loro empatia alcuna. Suburbicon è il frutto di un’idea che risale agli anni Ottanta, ma che, in maniera per certi aspetti sorprendente, racconta una storia più che mai attuale. Nell’America di Donald Trump, che si interroga sull’opportunità di rimuovere le statue dei generali sudisti, che ancora non ha fatto i conti con la memoria e che, forse anche per questo, non riesce a intravedere un futuro sufficientemente solido, si continua ad additare l’altro, lo straniero, il diverso, come la causa di ogni male della società, trincerandosi dietro una cortina di ipocrisia tanto spessa quanto fragile. La riflessione sulla questione razziale, che apre e chiude il film, rappresenta indubbiamente il tema centrale di Suburbicon, anche se la storia si concentra poi sulla rocambolesca caduta della “tradizionale famiglia bianca”. Le due storie parallele si congiungono grazie ai due bambini, il bianco e il nero, capaci di giocare insieme e, forse, di infondere al film un anelito di speranza.
La scrittura e la regia si rivelano ottimamente sincronizzate. Quanto al cast, non brilla particolarmente la prova di Matt Damon; più interessante è il doppio ruolo cui è chiamata Julianne Moore e prezioso, come al solito, l’apporto di Oscar Isaac, protagonista di alcune delle sequenze in cui la penna di Cohen mostra il suo tratto più cristallino.
Fino a quando un uomo bianco potrà attraversare in bicicletta, di notte, un quartiere “per bene”, perché tanto ci sarà sempre un “negro” cui dare la colpa, osserva Matt Damon in conferenza stampa, l’America avrà ben poche possibilità di costruire il proprio futuro. George Clooney, senza sottrarsi alle (inevitabili) domande sulla politica di Trump, risponde ai giornalisti che potrebbe essere divertente candidarsi come nuovo Presidente americano. In attesa delle presidenziali, Suburbicon può considerarsi un valido programma elettorale, politicamente interessante e cinematograficamente ben confezionato.
data di pubblicazione: 03/09/2017


da Maria Letizia Panerai | Set 3, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Parigi. Simon è un famoso violinista in attesa di essere convocato per lunga serie di concerti. Nel frattempo accetta un incarico presso una scuola di periferia: si tratta di affiancare un professore di musica nell’istruire un gruppo di alunni per trasformarli in una vera e propria classe-orchestra, secondo un programma scolastico che prevede a fine anno una loro esibizione alla Filarmonica. Tra questi ragazzi, alcuni dei quali vivaci e maleducati, c’è il timido Arnold di origini senegalesi, che mostra subito una spiccata attitudine per il violino, tale da far pensare che possa arrivare ad esibirsi in un assolo.
Per Simon (Kad Merad), secondo il quale la musica è un’arte universale che può aprire le porte a tutti coloro che la approcciano nel modo giusto, non sono sufficienti passione e tecnica: per riuscire a suonare bisogna innanzitutto divertirsi. Purtroppo, di fronte ad un pubblico di allievi così indisciplinati e sfrontati che devono essere in primo luogo educati a maneggiare con cura lo strumento che è stato loro assegnato, per Simon sarà davvero difficile mantenere il controllo, tranne che nei confronti di Arnold. Il ragazzo, figlio di madre single con una sorella più grande, mostra subito rigore comportamentale, impegno, disciplina ed un grande rispetto per la musica: sarà proprio lui a stimolare gli altri ragazzi a non scoraggiarsi e a continuare; anche il rigido Simon, superate le difficoltà iniziali, capirà che dare anche solo ad uno di loro la possibilità di appassionarsi a qualcosa sino ad allora irraggiungibile, ampliando così i propri orizzonti, rappresenterà oltre che una sfida anche quell’autentico divertimento che da qualche tempo non provava più nei suoi concerti.
La musica può realmente cambiare la vita delle persone? Dopo aver visto il primo lungometraggio del regista algerino Rachid Hami, presentato fuori Concorso a Venezia, non possiamo che dare a questo interrogativo una risposta positiva. La mèlodie è un commovente e tenero film sulla musica in ambiente scolastico ed i giovani attori, tutti bravissimi e scelti in base al loro talento per la commedia, hanno dovuto realmente imparare a suonare il violino, come ha dichiarato uno di loro in conferenza stampa “mi ha fatto molto piacere imparare a suonare il violino perché mentre suonavamo eravamo tutti uguali, non c’erano più diversità di razza, è stata una grande opportunità: non sarei qui oggi”.
Ed è proprio in queste parole che risiede il messaggio del film, oltre che nel brano musicale che il regista ha scelto di far suonare ai ragazzi: Shéhérazade, una suite sinfonica composta da quattro brani separati poi uniti tra loro da una parte solistica affidata al violino. Film corale di cui se ne consiglia la visione.
data di pubblicazione:03/09/2017


da Accreditati | Set 3, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Un rapimento misterioso a Casal di Principe. La difficoltà di allontanarsi da una terra contaminata. Una storia di forti legami familiari in una terra in cui una “vita normale” non sembra possibile.
Nato a Casal di Principe, fuori concorso a Venezia 74, è un film che non ti aspetti. Tratto da una storia vera, racconta del rapimento avvenuto nel 1989 di un ragazzo, Paolo Letizia, appartenente ad una famiglia per bene di Casal di Principe ad opera della camorra, che getta nello sconforto tutta la famiglia. Amedeo, il fratello maggiore di Paolo e aspirante attore, inizia insieme al cugino Marco e al fratello più piccolo una ricerca forsennata e disperata anche negli ambienti malavitosi (non sapendo se cercare un cadavere o il nascondiglio dove il fratello è rinchiuso) fino a mettere a repentaglio anche la sua stessa vita e quella dei suoi familiari.
Nel corso del film si delinea la figura di Paolo, che risulta essere la pecora nera della famiglia, uno che si metter facilmente nei guai, ma che per questo è considerato dai suoi debole e bisognoso di essere protetto, tanto da istillare in Amedeo, dopo la sua scomparsa, forti sensi di colpa per non essergli stato più vicino.
Un film che non lascia indifferenti; le emozioni, la tensione e l’angoscia di Amedeo si trasferiscono nello spettatore che percepisce il sentimento di impotenza e di rabbia del protagonista e si scontra con l’omertà e la collusione anche dei paesani non affiliati alla camorra. Amedeo ha cercato di allontanarsi dal suo paese tentando di far carriera nel cinema, affidandosi quindi al mondo della finzione, dell’evasione, ed invece il rapimento di Paolo che lo richiama a Casal di Principe, lo riporta alle sue origini che vuole dimenticare, ma che drammaticamente sono radicate in lui come l’amore viscerale per la sua famiglia. Imbraccia il fucile per le campagne come se stesse girando un film ed invece è tutto tristemente reale: la corruzione, la violenza, così come la casualità di vivere o morire in quel tessuto sociale.
Intensa l’interpretazione del protagonista Alessio Lapice e toccanti quelle dei genitori di Paolo, Donatella Finocchiaro e Massimiliano Gallo. La regia di Oliviero entra nelle pieghe delle vicende, dei sentimenti dei protagonisti e della drammaticità del contesto sociale e del territorio come solo un napoletano sa e può fare.
data di pubblicazione:03/09/2017


da Accreditati | Set 2, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Charlie Thomson ha solo quindici anni, ma ne dimostra molti di più. Sulle sue spalle c’è il peso di un’adolescenza finita troppo in fretta e nei suoi occhi il desiderio di raggiungere una buona dose di stabilità. Sarà l’affetto per un cavallo a fargli ritrovare la voglia di rialzarsi. Da solo, alla ricerca della propria identità e di un passato che gli appartiene.
Durezza e dolcezza insieme. Drammaticità positiva, a tratti inevitabile, in grado di condurre il protagonista verso una crescita costruttiva. Solitudine e, al contempo, ricerca smodata di legami concreti. Paura e coraggio. Lean on Pete, tra i film in concorso alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, gioca molto sugli ossimori e le contraddizioni dell’animo. A firmarlo il regista britannico Andrew Haigh, che ha riadattato per il grande schermo il romanzo di Willy Vlautin, La ballata di Charlie Thomson.
Protagonista della storia è proprio quest’ultimo, un quindicenne carico di responsabilità che si troverà presto ad affrontare un viaggio metaforico, oltre che reale. Interpretato da un intenso Charlie Plummer, il ragazzo non ha figure di riferimento al suo fianco. Non ha mai conosciuto sua madre, mentre il padre dedica la vita più alle donne che al ruolo di genitore. Quando perderà anche lui, Charlie investirà tutte le sue forze in un nuovo lavoro, ottenuto per caso dopo un breve colloquio con un allevatore di cavalli da corsa (Steve Buscemi). A spingerlo l’affetto per uno dei componenti più deboli del suo team, Lean on Pete, non più capace di gareggiare come una volta. Quasi fosse una sorta di alter ego, il cavallo diventa da subito il suo unico confidente. È a lui che rivela i pensieri più cupi e i ricordi più belli. Ed è a lui che voterà tutte le sue attenzioni, proprio come avrebbe voluto che qualcuno avesse fatto con lui. Forse suo padre o la zia Margy, sempre presente nella sua memoria.
Lean on Peteè un classico racconto di formazione. Eppure, nonostante il recupero consapevole di certi spunti narrativi, è più complesso. Ogni uomo che il giovane protagonista incontrerà sul suo cammino non riuscirà a forgiarlo a proprio piacimento, impartendogli insegnamenti e massime di vita. Non ci saranno consigli o dritte che Charlie deciderà di seguire: in lui le basi di una buona educazione già ci sono. Lo dimostra ogni suo gesto, ogni sua parola. Consapevole che solo il ritorno a quel passato fiorente – quando era ancora un bambino ed era circondato da una vera famiglia – sarà capace di restituirgli l’agognata stabilità, sceglie allora di affidarsi a sé con tutte le proprie forze. Crescerà e maturerà, ma poi si trasformerà di nuovo nel piccolino di una volta, bisognoso di cure e rassicurazioni. Un film da vedere, dunque, che ha commosso tutta la platea della Sala Grande del Lido. È bastato guardare negli occhi ciascuno dei presenti e ascoltare la lunga serie di applausi al termine della proiezione per capire che sì, anche stavolta, il cinema è riuscito a compiere la sua missione catartica.
data di pubblicazione:02/09/2017


da Maria Letizia Panerai | Set 2, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Un giorno Addie, una donna di quasi ottant’anni rimasta vedova, si reca dal suo vicino di casa Louis, anch’esso rimasto solo da tempo, per fargli una insolita richiesta: dormire insieme, allo scopo di farsi compagnia e parlare un po’, condizione che oramai da troppo tempo non esiste più per entrambi. Unire le loro anime di notte sarà un modo per affrontare il passato e vivere a piene mani il presente.
Nella penombra di quelle notti rubate agli sguardi indiscreti dei vicini di una tranquilla cittadina del Colorado, dopo aver vinto un inevitabile imbarazzo iniziale, prendono corpo e voce per Addie e Louis i ricordi della vita passata non sempre piacevoli, rimasti ben celati nell’animo di entrambi. Entrambi confessano sensi di colpa ed inadeguatezza di fronte a certe situazioni della loro gioventù quanto si è troppo presi dalla vita e non si dedica sufficiente tempo a tutto, ma tali confessioni non disturbano la loro singolare e notturna consuetudine che prosegue tra le chiacchiere indiscrete dei vicini. E così prende corpo la speranza di poter diventare ciò che avresti voluto essere da giovane ma non hai avuto il coraggio di diventare, non curandosi troppo delle chiacchiere della gente, e quello che inizialmente sembrava un bizzarro gioco diviene per entrambi l’inizio di una affettuosa amicizia.
Dopo quasi 50’anni da A piedi nudi nel parco, la coppia Fonda-Redford ci ammalia ancora con Our Souls at night, tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, di cui Redford ha acquistato i diritti per poi produrre il film che non potremo vedere nelle sale perché finirà su Netflix. Ci parlano di amore adulto come cura alla solitudine ed alle ferite giovanili, da quelle spine che ci si porta dentro il cuore perché non si è stati capaci di toglierle.
Inutile dire che il film è molto gradevole grazie soprattutto alla presenza di questa coppia di assi, che anche attraverso le rughe ci affascinano ancora con la loro tecnica recitativa rimasta intatta: due autentiche leggende che hanno incantato la sala stampa con la loro classe, con risposte sempre molto misurate e con una buona dose di senso d’humor. Due leoni alla carriera meritatissimi.
data di pubblicazione:02/09/2017


da Antonella Massaro | Set 1, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Il terremoto di Amatrice. Le macerie materiali e spirituali. La disperazione. La speranza. La memoria che da sola non basta.
Casa d’altri era indubbiamente tra gli eventi speciali più attesi di Venezia 74. Gianni Amelio lascia che la sua macchina da presa scivoli, quasi ritraendosi, tra le macerie materiali e spirituali che il terremoto di Amatrice ha lasciato dietro di sé.
Le case sventrate, come durante una guerra. Il silenzio.
I ricordi che devono e vogliono lasciare spazio al futuro. Il silenzio.
I turisti che chiedono informazioni sulla via più breve per raggiungere le macerie e per scattare l’immancabile selfie-ricordo. Il silenzio.
La rabbia e l’orgoglio. Il silenzio.
Le mani nude che scavano nel vano tentativo di raggiungere le viscere della terra. Il silenzio.
La memoria non basta. Il silenzio neppure.
data di pubblicazione: 01/08/2017

da Antonella Massaro | Set 1, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Un banale alterco diviene un caso mediatico di rilevanza nazionale. Un libanese cristiano e un palestinese si trovano contrapposti in un’aula di Tribunale, che si trasforma anche nel palcoscenico di uno dei capitoli più complessi della storia contemporanea.
The Insult di Ziad Doueniri, in concorso a Venezia 74, sorprende in positivo il Lido con un legal drama made in Libano che, pur prendendo a prestito alcuni stilemi di un registro narrativo tradizionalmente appannaggio del made in USA, risulta un’opera nel complesso originale, tanto per la questione politico-culturale che fa da sfondo all’intera vicenda quanto per l’esito della battaglia legale che costituisce il cuore del film.
Toni (Adel Karam), libanese militante del Partito Cristiano, discute con il palestinese Yasser (Kamle El Basha) per una grondaia “fuori norma”. Yasser, di fronte alla tracotanza mostrata da Toni e malgrado si trovi in un quartiere di Beirut socialmente e politicamente ostile ai palestinesi, insulta il suo interlocutore. Toni decide di procedere per vie legali, intentando una causa di risarcimento nei confronti di Yasser. Le leggi degli uomini, tuttavia, non sembrano in grado di risolvere una situazione così complessa che, come avviata lungo il crinale di un pendio scivoloso, degenera ulteriormente. Quello che sembrerebbe un banale alterco quotidiano si trasforma rapidamente in un caso mediatico di rilevanza nazionale, in un Paese divenuto negli ultimi decenni un crogiolo di religioni, culture, ideologie: in un Paese multirazziale che fatica a trasformarsi in un Paese multiculturale.
Allo scontro tra culture si aggiunge anche quello tra generazioni, visto che gli avvocati difensori sono un vecchio fedele alla causa cristiana (Camille Salameh) e una giovane (Diamand Bou Abboud), convinta sostenitrice dei diritti dei palestinesi. Si scoprirà poi che i due sono molto più che semplici colleghi.
I temi con i quali il processo è chiamato a confrontarsi sono quelli con cui il diritto (specie penale) è chiamato frequentemente a fare i conti, soprattutto nei momenti di più complessa e violenta transizione storica. Fanno più male le aggressioni fisiche o quelle verbali? Si può essere condannati per un reato di opinione oppure ognuno ha la libertà di pensare e dire tutto quello che desidera? La dignità del singolo, anche se l’offesa non sia arrecata pubblicamente, è suscettibile di una tutela penale? Si può reagire, secondo il codice penale libanese, anche oltre i limiti della legittima difesa, se il soggetto si trovi in uno “stato emotivo compromesso” che ha compromesso la sua lucidità. Ma la battaglia legale senza esclusione di colpi, portata a conseguenze che né Toni né Yasser avrebbero immaginato e sperato, dimostrerà che non sempre i ruoli di “vittima” e di “aggressore” sono così chiaramente delineati. Se la Presidente del collegio giudicante non leggesse a voce alta il “verdetto” della Corte d’appello, le sole immagini non lascerebbero agevolmente intuire quale dei due contendenti sia riuscito ad avere la meglio.
Ziad Doueiri, come lo stesso regista spiega in conferenza stampa, proviene da una famiglia di avvocati e di giudici: è quindi abituato non solo al linguaggio legale, ma anche all’idea che l’unico strumento di affermazione dei diritti (umani) siano le leggi di uno Stato. Ammette di aver avuto tra i suoi modelli Il verdetto di Sidney Lumet, ma, come anticipato, il risultato di The Insult, più concentrato sulla storia che sui movimenti di macchina ad effetto, è per molti aspetti sorprendente, andando ben oltre le pastoie imposte dal recinto del film di genere.
data di pubblicazione: 01/09/2017


da Maria Letizia Panerai | Set 1, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
É il 1962. In una piccola località non meglio identificata della costa americana vive Elisa, una ragazza muta che lavora di notte come donna delle pulizie in un laboratorio governativo di massima sicurezza dove una sera, in assoluta segretezza, viene portata una sorta di cisterna cilindrica in vetro piena di un’acqua dal colore verdognolo. Elisa ode da quello strano cilindro, blindato come una sorta di piccolo sottomarino, l’eco di strani versi che sembrano appartenere ad una creatura marina che tanto innervosiscono le persone addette alla sicurezza ma che, al contrario, attraggono irrefrenabilmente la ragazza “senza voce”, tanto da volerne sapere di più…
Elisa (Sally Hawkins) è già di per sé una strana creatura, che vive in un mondo quasi ultraterreno: sembra essere grata alla vita affrontando ogni giorno come fosse una danza, allegra, spensierata e sempre con un rassicurante sorriso. Eppure Elisa è vera, in carne ed ossa, ma la sua vita assomiglia ad una fiaba come il suo piccolo appartamento dai colori che ricordano il fondo marino, situato sopra un teatro di quartiere dalle poltroncine di velluto color porpora; ogni sera, prima di recarsi a lavoro, si prende cura di sé con un bel bagno ed una cena leggera, che prepara sempre anche per il suo vicino Giles (Richard Jenkins), un talentuoso illustratore di cartellonistica per prodotti alimentari un po’ sfortunato, ma irrimediabilmente romantico, ancora alla ricerca dell’anima gemella e legato ad Elisa da una profonda amicizia. E poi c’è Zelda (Octavia Spencer), una collega di lavoro prepotente ma tanto buona, che Elisa ogni notte durante il turno di lavoro ascolta amorevolmente parlare senza tregua e, soprattutto, senza mai poter…replicare. Ma un giorno, incurante delle disposizioni del funzionario (Michael Shannon), cattivo e dai modi violenti, responsabile della custodia di questo misterioso uomo-anfibio contenuto nella cisterna che i sovietici vorrebbero sottrarre per farne esperimenti, Elisa decide di socializzare con “il mostro” e lo farà nel modo più naturale possibile: sedendosi sul bordo della vasca ed offrendo ad esso parte del suo pranzo….
É approdato a Venezia un grande film, in cui fantasia, thriller, romanticismo, sesso ed amore si mescolano e ci inondano come l’acqua presente nella vita dei due protagonisti: un uomo pesce di cui si innamora perdutamente una donna senza voce in un momento di strana sincronia che accade raramente. E così è la favola ad entrare nella vita vera, nel mondo reale, e non si può che assistere esterrefatti a tutto questo, attraverso le immagini di questa storia d’amore che vince su paura e violenza. Le scene del film sono curatissime, non solo nelle inquadrature e nella fotografia, ma anche nei colori che anticipano la trama: come il rosso del sangue o delle scarpe di Elisa, o il colore della sua casa che sembra un relitto inabissato in contrapposizione alla luce che inonda la stanza dove Giles disegna i suoi cartelloni pubblicitari. Sublime è la colonna sonora del compositore francese Alexandre Desplat (Oscar per Grand Budapest Hotel), studiata a tavolino con il regista che ha curato personalmente tutto del film, dalla sceneggiatura in poi.
Se volessimo dare una forma a qualcosa che si avvicina ad un piccolo capolavoro, potrebbe avere quella dell’acqua.
data di pubblicazione:01/09/2017

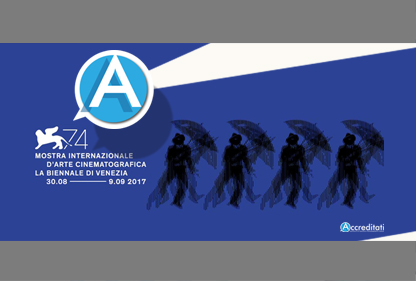
da Maria Letizia Panerai | Ago 31, 2017
(74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)
Un uomo solo di fronte ai suoi demoni, tormentato per qualcosa che non riesce a perdonarsi. Losche società multinazionali che sorreggono con le loro offerte comunità religiose. Un ambientalista radicale che non vuole far nascere il proprio figlio in un mondo che sta inevitabilmente andando verso un disastro senza ritorno e la moglie di lui che cerca delle risposte per salvare la sua famiglia e quel figlio che deve ancora nascere. Ed in mezzo a tutto questo c’è la vita, in un continuo equilibrio tra disperazione e speranza.
Toller (Ethan Hawke), ex cappellano militare ed attuale reverendo di una piccola comunità, è tormentato dai ricordi di una vita passata che lo spingono a scrivere un testamento morale su un quaderno, destinato ad essere distrutto dopo un anno senza che nessuno al fuori di lui possa leggerlo. Il dissidio spirituale che lo attanaglia si acuisce quando una sua giovane parrocchiana Mary (Amanda Seyfried), in attesa del suo primo figlio, gli chiede di accordare un incontro a suo marito Michael (Philip Ettinger), ambientalista ossessionato dall’idea di non voler far nascere un figlio in un mondo che non si accorge del disastro ambientale senza speranze che gli lasciamo in eredità. Da questo incontro Toller ne uscirà devastato non solo perché non riesce a convincere il giovane uomo a rivedere le sue convinzioni, ma soprattutto comincerà a porsi la domanda del perché comunità religiose come la sua sono così silenti sul tema del disastro ambientale.
Si respira spiritualità in First Reformed, film definito trascendentale, dal finale ambiguo perché nessuna forma d’arte deve precludere le interpretazioni del pubblico, come ha asserito lo stesso regista in conferenza stampa,anche se poi ha aggiunto che se nutriamo speranza nell’umanità non prestiamo attenzione a ciò che ci sta accadendo, perché non credo che l’umanità potrà sopravvivere a questo secolo.
Il film, attraverso la vita tormentata del pastore Toller, fa percepire allo spettatore di camminare sempre sull’orlo dell’abisso a cui si contrappone l’amore, in ogni sua forma, che riequilibra le cose; a supportare questa tesi ci sono anche le inquadrature in cui le immagini appaiono sempre nette, nitide, divisibili, simmetriche, ad indicare un equilibrio destinato a venire meno, tranne che sul finale in cui l’inquadratura avvolge gli interpreti, conferendo allo spettatore la sensazione che qualcosa è cambiato.
Ethan Hawke è semplicemente bravissimo nel portare sulle spalle del suo personaggio il peso di un’intera umanità; di Paul Schrader basti dire che nella sua carriera è stato pluripremiato sia come sceneggiatore (Taxi Driver, Toro Scatenato, American Gigolò, Il bacio della Pantera, L’ultima tentazione di Cristo etc.) che come regista (American Gigolò, Il bacio della Pantera, Cane mangia cane etc.); quanto al film chi vi scrive ha avuto la netta sensazione di assistere a qualcosa di grande, di palpabile ma di non spiegabile, ma soprattutto a qualcosa che realmente ognuno può interpretare in base a ciò che interiormente percepisce.
data di pubblicazione:31/08/2017






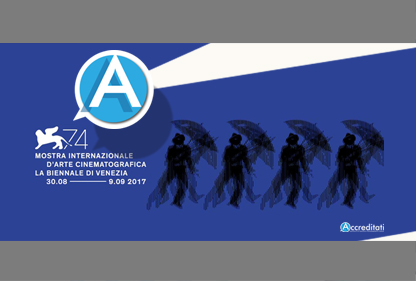





Gli ultimi commenti…