
da Antonio Iraci | Apr 2, 2018
Helene Kröller-Müller (1869-1939), figlia di ricchi industriali tedeschi, si era trasferita con il marito in Olanda. Seguendo le lezioni culturali del pittore Henk Bremmer, era venuta casualmente a conoscenza dell’arte e della personalità di Vincent Van Gogh, di cui ne rimase profondamente affascinata. Nel 1909 Helene acquista il primo quadro di Vincent e pian piano riesce a costituire una importante collezione di quadri e disegni del pittore arrivando persino a concepire un luogo dove riunire le opere e poterle così esporre. Un anno prima della sua morte lo Stato olandese riuscirà a portare a termine la costruzione del museo, a condizione che quelle opere sino ad allora di proprietà privata divenissero di proprietà pubblica. Il Kröller-Müller Museum si trova ad Otterlo, immerso nel verde di un parco, a circa un’ora d’auto da Amsterdam.
La 3D Produzioni e Nexo Digital presentano in anteprima mondiale nelle sale cinematografiche italiane e solo nei giorni 9, 10, 11 aprile un documentario di grande interesse culturale non soltanto perché si parla della vita e delle opere del celebre Van Gogh, ma anche perché in esso ci viene descritta la passione di Helene Kröller-Müller verso la sua pittura, ed ancor più della sua unione intellettuale con il pittore olandese. Anche se i due fisicamente non si incontrarono mai, dal momento che la donna era appena una ragazzina quando Vincent morì, tuttavia Helene si rese presto conto che la sua personalità era molto simile a quella dell’artista. Entrambi andavano alla ricerca di un qualcosa di trascendentale che andava ricercato nella natura dei semplici, operai e contadini, lasciando all’arte il compito di operare questa estrapolazione che assunse carattere religioso e filosofico allo stesso tempo. Pur partendo da condizioni sociali e soprattutto finanziarie completamente diverse, dal momento che Van Gogh era estremamente povero mentre Helene era considerata una delle donne più ricche del suo tempo, i due riuscirono a seguire un percorso spirituale parallelo spesso tormentato da un travaglio interiore dal quale difficilmente ne uscirono indenni. Altro elemento che unì i due singolari personaggi fu un’enorme mole di lettere, dalla quale emerge il complesso temperamento di entrambi e quanto fossero affascinati dalla bellezza della natura e dall’immensità dell’universo. Per Helene, Vincent fu inoltre un esempio morale da seguire soprattutto per quanto riguarda la sua attitudine ad immergersi nel quotidiano, tra i campi, dove i contadini erano impegnati nel duro lavoro. Il documentario ci racconta pertanto di queste due vite che ebbero molti punti in comune e ci porta per mano tra le sale del museo di Otterlo dove sono sistemate circa trecento opere di Van Gogh raccolte pazientemente negli anni da Helene Kröller-Müller, portando a conoscenza di tutti le opere del pittore che raggiunsero nel tempo quotazioni stratosferiche.
Il film si avvale della consulenza scientifica di Marco Goldin che ha anche curato l’allestimento della mostra omonima Van Gogh, tra il grano e il cielo presso la Basilica Palladiana di Vicenza. Al viaggio dentro le sale della mostra si aggiungono anche i luoghi dove è nata e si è evoluta l’arte dello sfortunato pittore olandese, il tutto accompagnato dalla voce narrante di Valeria Bruni Tedeschi e dalle musiche originali di Remo Anzovino, compositore considerato oggi tra i massimi esponenti della musica strumentale italiana.
data di pubblicazione:02/04/2018

da Accreditati | Mar 30, 2018
Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)
Buona Pasqua!
Happy Easter!
Joyeuses Pâques!
Frohe Ostern!
Feliz Pascua

da Giovanni M. Ripoli | Mar 28, 2018
Tonya è il ritratto di una giovane pattinatrice della provincia americana, protagonista di uno degli scandali sportivi più controversi degli anni ‘90, tratteggiato attraverso il controverso rapporto con un marito violento ed una madre opprimente e crudele che, sin dall’infanzia, le inculca l’ossessione per pattinaggio. La deriva di una brillantissima carriera drammaticamente annunciata.
Di indubbia presa Tonya, film del talentuoso regista australiano Craig Gillespie, classe1967, già apprezzato nel 2007 per Lars e una Ragazza tutta Sua, che qui è alle prese con un tema assai caro alle produzioni USA: il successo nello sport ad ogni costo. Per l’esattezza la disciplina è lo skating, da noi pattinaggio sul ghiaccio, e la storia racconta la drammatica vicenda di Tonya Harding, ottima pattinatrice statunitense sbattuta sui media prima per le sue grandi qualità per essere stata la prima ad eseguire il triplo salto Axel, uno dei più acrobatici del pattinaggio di figura sul ghiaccio, ed in seguito perché ritenuta corresponsabile dell’aggressione alla sua rivale Nancy Kerrigan, alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Lillehammer.
La pellicola, un biopic ma sulla falsariga di un docu-film grazie ad interviste e flashback abilmente montati, ripercorre la vicenda di Tonya ancora piccolissima nelle mani di una madre ossessiva e sboccata che la vuole numero uno al mondo e, appena talentuosa quindicenne, in un tormentato rapporto col fidanzato e poi marito Jeff Gillooly. Punteggiata da momenti memorabili come alcune scene sulle prestazioni sportive, e da lampi di recitazione di altissimo livello della bravissima protagonista, l’australiana Margot Robbie, ma anche di Allison Janney miglior attrice non protagonista agli Oscar 2018 nel ruolo della terribile madre Lavona, la pellicola è una appassionante denuncia contro lo sport vissuto in modo totalizzante, una magnifica prova d’autore dove tutto funziona al meglio, dagli attori alla regia, dall’ambientazione alla colonna sonora, con memorabili brani che spaziano dai Dire Straits ai Bee Gees.
data di pubblicazione:28/03/2018
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonietta DelMastro | Mar 26, 2018
 Ultimo romanzo della trilogia con il commissario Yeruldelgger. Questa volta Ulan Bator è solo un’eco lontana, Yeruldelgger ha piantato la sua “yurta nel cuore del Gobi a ore di distanza da ogni aiuto…”, è stato mandato in ritiro dal Nerguii: “si era ritirato lontano da tutto, lontano dalla sua città, lontano dal suo ex mestiere, lontano dai suoi amici, e dal corpo e dall’animo adorati della donna che amava….”. L’obiettivo di questa solitudine è dare modo a Yeruldelgger di trovare la pace dopo che, alla fine di Tempi selvaggi, si è trovato al centro di una spirale di terribile violenza.
Ultimo romanzo della trilogia con il commissario Yeruldelgger. Questa volta Ulan Bator è solo un’eco lontana, Yeruldelgger ha piantato la sua “yurta nel cuore del Gobi a ore di distanza da ogni aiuto…”, è stato mandato in ritiro dal Nerguii: “si era ritirato lontano da tutto, lontano dalla sua città, lontano dal suo ex mestiere, lontano dai suoi amici, e dal corpo e dall’animo adorati della donna che amava….”. L’obiettivo di questa solitudine è dare modo a Yeruldelgger di trovare la pace dopo che, alla fine di Tempi selvaggi, si è trovato al centro di una spirale di terribile violenza.
Il romanzo, come i precedenti, comincia con due scene in opposizione, la scoperta di un corpo da parte di quattro artisti nomadi e l’apparizione di Yeruldelgger, fiero, sul suo cavallo; inizia così, suo malgrado, il coinvolgimento in una nuova indagine che metterà fine alla sua solitudine.
Al fianco dell’ex commissario alcune nuove figure femminili, forti e determinate: Tsetseg, che vuole essere aiutata a ritrovare la figlia rapita, Odval, che vuole vendicare la morte del suo “amore nomade” e Guerlei, la poliziotta sanguigna e iraconda che dovrà occuparsi ufficialmente, quale rappresentante della legge, della serie di omicidi in cui si imbatterà questa strana comitiva, tutti perpetrati secondo antichi rituali e legati allo sfruttamento del territorio mongolo da parte di multinazionali senza alcuno scrupolo.
In quest’ultimo romanzo, a differenza dei precedenti episodi di questa trilogia, l’intreccio narrativo è sicuramente meno inverosimile; in ogni pagina è sempre presente il tema della morte ma, come contraltare, per la prima volta scopriamo un Yeruldelgger più “leggero”: Manook inserisce una vena umoristica che non guasta affatto al suo personaggio e lo rende a noi più vicino e più umano.
Come per i precedenti romanzi della trilogia, la capacità descrittiva di Manook è emozionante: “Allora restò il tepore di una steppa di smeraldo ai piedi della collina. La freschezza bianca di un fiume scintillante che snodava i suoi nastri attorno a folti ciuffi di canne argentate. Un orizzonte frastagliato a est da crinali blu dentellati, lisciato a ovest dal mareggio iridato di una prateria arruffata. Qualche cavallo dalla criniera bionda, con il mondo intero per pascolare. E a nord un cielo che si caricava delle onde color lilla di un temporale elettrico.” Poche parole e uno scenario maestoso esplode nella nostra testa e nel nostro immaginario, come si può non leggere un romanzo che offre queste descrizioni…?
data di pubblicazione: 26/03/2018

da Rossano Giuppa | Mar 26, 2018
(Teatro Vascello – Roma, 21/25 marzo 2018)
È tornato in scena al Teatro Vascello di Roma, dal 21 al 25 marzo 2018, il Teatro Valdoca con lo spettacolo Giuramenti. Il Teatro Valdoca, nato nel 1983 a Cesena, dal sodalizio fra il regista Cesare Ronconi e la poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri, ha da sempre perseguito con rigore e raffinatezza una propria ricerca sul lavoro d’attore, creando spettacoli corali, in una scrittura scenica che fonde danza, arti visive e musica dal vivo.
Con Giuramenti il regista Cesare Ronconi riparte da una piccola comunità di giovani attori e danzatori per attivare le dinamiche pedagogiche e spettacolari proprie del Teatro Valdoca.
Lo spettacolo si sviluppa su una liturgia lirica che alterna brani cantati, brani recitati, brani danzati in cui il movimento produce una partitura di suoni prodotti da percussioni, bastoni di legno, anelli di metallo mentre sul fondo, un grande specchio concavo restituisce ribaltata la visione frontale dello spettatore. Al centro di questa struttura un movimento continuo, una comunità temporanea e solidale, che non usa la narrazione ma la poesia.
Un viaggio a ritroso nel tempo per poter poi interrogare il presente, indagare i corpi e i sentimenti di chi oggi ha vent’anni e guarda il mondo esterno e i suoi conflitti, la sua bellezza, le sue incoerenze.
Dodici giovani interpreti che raccontano un coro in movimento, fluido e vitale e che gridano in faccia al mondo la propria inquietudine, l’amore, l’ardore, o sussurrano un sapere antico ed enigmatico. E dal coro si distaccano poi singolarmente coi loro racconti intensi e delicati che richiamano il rapporto primordiale tra l’uomo e la natura, oggi quasi dimenticato e sopraffatto dalla tecnologia. L’invito che fa la compagnia cesenate al pubblico, alla fine, è questo: va riscoperto il movimento del corpo e della mente, l’incanto della parola detta e non scritta.
Uno spettacolo empatico e in controtempo, arcaico per certi versi. I giovanissimi interpreti danno allo spettacolo un sapore acerbo e tribale, non carico di colpi ma d’effetto a motivo di un’impalcatura narrativa non chiara, ma che poi si traduce in un mantra inquieto e crescente che alla fine tocca le corde più intime di chi lo ascolta.
data di pubblicazione: 26/3/2018
Il nostro voto: 

da Giovanni M. Ripoli | Mar 25, 2018
Presentato in anteprima al Telluride Film Festival, apprezzato come film di apertura della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, Hostiles rappresenta il malinconico ultimo viaggio del capo Cheyenne Falco Giallo, ormai malato di cancro, scortato dal capitano Joe Blocker su incarico dello stesso Presidente degli Stati Uniti. Durante il trasferimento accadrà di tutto, fra ostacoli naturali, nemici bianchi & pellerossa ostili, fantasmi del passato. Il racconto si apre con un pensiero di D.H.Lawrence: nella sua essenza, l’anima americana è dura, solitaria, stoica e assassina. Finora non si è mai ammorbidita.” Anche di questo parla il film!
Diciamolo subito: non dovete aspettarvi un western adrenalitico, ricco di indiani e sparatorie (che pure non mancano, alternate a lunghe pause). Con Hostiles, siamo sul versante del “crepuscolo del West “ in salsa “revisionista”. È una importante e non banale pellicola su quella pagina della storia americana che esplora il difficile rapporto fra i bianchi, vincitori (esercito, coloni, affaristi) e i nativi (le diverse tribù della grande nazione indiana), sconfitti dalla guerra, dalle malattie, dal … progresso. La struttura del film non è però quella di un documentario, bensì la tragica rappresentazione di un lungo straziante ma avvincente viaggio durante il quale tutti i personaggi coinvolti sono splendidamente disegnati e approfonditi. Un film, principalmente, di paesaggi, di attori, di atmosfere. Rosalie Quaid (un’intensa Rosamund Pike) è la giovane madre che vede, nella drammatica scena di apertura, trucidata la sua famiglia nell’attacco alla sua fattoria da un manipolo di Comanche, ladri di cavalli. I suoi silenzi, il suo odio represso, il desiderio di vendetta, la dolcezza e il perdono sono tutte facce della stessa medaglia e la Pike, candidata all’Oscar le ha rese in modo impeccabile. Altro personaggio imprescindibile è il capitano Joseph Blocker (Chrisian Bale, baffuto e imperscrutabile) un ufficiale che ha partecipato al massacro di Wounded Knee, certamente non incline a rapporti idilliaci con i pellerossa, ma che da soldato accetta comunque un incarico che va contro tutto quello in cui aveva precedentemente creduto. L’attore inglese, taciturno e indurito dal passato rende convincente la lotta interiore e il passaggio dall’odio alla pacificazione con gli indiani che scorta. Con poche parole, ma con il suo innegabile carisma, Falco Giallo (Wes Studi) affronta con dignità e umiltà il suo ultimo viaggio e, nelle occasioni “ ostili” ha coraggio e persino empatia verso i suoi oppressori, mostrando loro che a volte le diversità fra le genti sono solo apparenti. Il gruppo tutto, infatti, unito nelle avversità farà scudo: i soldati impareranno a fidarsi dei “prigionieri” indiani (la famiglia di Falco Giallo), Rosalie adotterà la piccola indiana, unica sopravvissuta dopo l’estenuante odissea e, lo stesso Blocker renderà onore al capo morente e, nella scena finale, ormai in borghese, prenderà lo stesso treno di Rosalie, diretta a Chicago, per un sottile e non esplicito happy end.
Hostiles, per montaggio e inquadratura, da apprezzare in pieno su grande schermo è, oltre un drammatico e avvincente spettacolo di oltre due ore, anche una risposta che il regista vuole offrire a un Paese che oggi come allora erge frontiere e muri invece che cercare dialogo con le diversità e sceglie la frontiera americana, magnificamente fotografata da Masanobu Takayanagi, per attualizzare temi quali tolleranza e perdono. L’operazione può dirsi riuscita a pieno.
data di pubblicazione:25/03/2018
Scopri con un click il nostro voto: 

da Daniele Poto | Mar 24, 2018
(Teatro Piccolo Eliseo-Roma, 14/29 marzo 2018)
Drammaturgia triangolare. Virata sulla scenografia che muta prospettive, rapporti, interazioni tra i tre protagonisti.
La pacifica cena di una coppia viene turbata dall’arrivo in casa del fratello della donna con la maglietta intrisa di sangue. Da lì si sviluppa un racconto concentrico, ricco di omissioni e bugie che traballano sotto il fuoco di fila di domande dei due coniugi. Sempre un piccolo passo in avanti alla ricerca della terribile verità, che finisce col rompere anche la solidarietà della coppia. Perché la moglie innesta un ricatto legato alla propria gravidanza. Il testo evoca la violenza e il sangue senza farlo vedere. E allude anche alla tragica trappola della solidarietà parentale, del bieco familismo, a tutto disposto pur di coprire un efferato crimine. Il testo di Dennis Kelly contiene una propria perfetta chirurgia della dissacrazione, svelandosi ad anelli concentrici. Tempo unico con improvvisi oscuramenti che decretano il gong dei cambiamenti d’atmosfera e di situazioni. Quadri dove crudeltà, cinismo, sorpresa si alternano in un cocktail teatrale riuscito che non può prescindere dall’efficace recitazione del trio. Monica Nappo, la moglie, tiene le fila della vicenda ma con un senso di sconfitta finale. E non sono meno vinti gli altri personaggi ben resi da Paolo Mazzarelli e Lino Musella. È una drammaturgia secca, e a densa stratificazione oltre che a lento rilascio per lo spettatore. Con una conclusione secca e piuttosto inaspettata che non riveleremo. Se il teatro è conflitto e rappresentazione di contraddizioni Orphans ne è la perfetta condensata epitome. Marche Teatro, non a caso istituzione di rilevante interesse culturale, ha sostenuto un progetto intenso, sostenuto proprio dalla principale interprete Monica Nappo, avvalendosi della traduzione di Gianmaria Cervo e Francesco Salerno.
data di pubblicazione:24/03/2018
Il nostro voto: 

da Antonio Jacolina | Mar 22, 2018
Dopo aver scoperto che il marito, appena nominato Sir, ha da tempo una relazione, la sessantenne e snob Lady Sandra (Imelda Staunton) lascia la sua villa nel Surrey e si rifugia a Londra nell’appartamentino della sorella Biff (Celia Imrie) che conduce ancora una vita libera da condizionamenti, con amici altrettanto vitali ed alternativi. In questo contrasto di realtà, Sandra riscoprirà più autentici valori con l’aiuto anche di uno dei nuovi amici: Charlie (Timoty Spall).
“La Vita Comincia Oltre i 60 Anni” potrebbe tranquillamente essere la sintesi del film. Sappiamo che da tempo il Cinema ha scoperto che le aree di maggior profitto cui dedicare attenzione sono le due punte estreme dell’arco dei suoi spettatori. Da una parte i giovani, dall’altra il cosiddetto “Grey Pound” (dal colore grigio dei capelli) il sempre più crescente numero di potenziali spettatori della “Terza e Quarta Età”. E’ proprio questo il target di parecchi dei film che vediamo passare sui nostri schermi: Appuntamento al Parco, Ruth e Alex, Mai così vicini, tanto per citarne alcuni.
Il nostro film è diretto dall’eclettico R. Loncraine. Il settantaduenne regista inglese, con ampia esperienza sia televisiva che cinematografica, ha attraversato, nella sua lunga carriera, una molteplicità di generi: dal pluripremiato shakepeariano Riccardo III fino ai recenti film per la Terza Età, suo è difatti anche il sopraccitato Ruth e Alex. Il film di cui parliamo oggi: Ricomincio da Noi appartiene proprio al classico sottogenere dei film “sul passaggio di età”. Non tanto il passaggio dall’adolescenza all’età adulta come in Lady Bird, quanto piuttosto quello altrettanto inevitabile e difficile verso l’”Età Matura”. Una fase di cambiamento altrettanto cruciale, quasi una seconda o terza chance per riuscire a dare un diverso valore alla propria vita recuperando progetti, oppure creandosene di totalmente nuovi e vitali avendo il coraggio di saltare verso il “Nuovo”. Pensiamo, fra i tanti, a Marigold Hotel. Il film di Locraine è dunque un film su come si può riscoprire la bellezza della vita. Una favola, un racconto delicato su come riprendere con entusiasmo il cammino. Con un tale tema c’era il grosso rischio di scivolare in una storia strappalacrime oppure in una scadente rassegna degli stereotipi sulla terza età. Pur non sostenuto da un grande sceneggiatura e pur non potendo evitare qualche clichè e sviluppi narrativi prevedibili, Loncraine dirige con sufficiente mestiere e riesce a mantenere la storia ai livelli di una commedia gentile e dolce-amara, divertente ed a tratti commovente, senza essere mai banale o superficiale. Un notevole supporto gli viene dato da un eccellente cast di attori, un trio di ottimi “veterani” del Teatro e del Cinema Inglese che unitamente a validi caratteristi, consentono di attraversare con successo l’alternanza di situazioni di nostalgia e commozione con quelle allegre e ricche di humour britannico. C’è una qualche lontana eco di Una canzone per Marion. Se in quest’ultimo ottimo film l’elemento catartico per il cambiamento di vita era il coro musicale, in Ricomincio da Noi l’elemento è invece la scuola di ballo ed il ballo corale che danno al film un vero tocco di originalità con gradevoli scene ed ottimi brani musicali entrambi estremamente coinvolgenti e contagiosi. In conclusione il film è una delicata ed a tratti frizzante commedia in grado di far accettare i lutti, far sorridere sull’età e sul coraggio di uscire dagli schemi della ragione per seguire le emozioni e trasmettere, soprattutto, l’accattivante messaggio che “Non si deve mai aver paura di vivere” .
data di pubblicazione:22/03/2018
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Mar 22, 2018
La cerimonia dei David di Donatello torna su RAI 1, affidata alla “istituzionale” conduzione di Carlo Conti. In prima serata, come si conviene agli spettacoli che contano.
La cerimonia è impreziosita dai David alla carriera a Stefania Sandrelli, Steven Spielberg e Diane Keaton e, soprattutto, dall’omaggio che le stelle del cinema americano hanno voluto tributare al talento dei cineasti italiani e alla grande bellezza di Roma. Roma che Spielberg vede per la prima volta con la guida illustre di Federico Fellini, Roma che risuona nelle note intonate a cappella da Diane Keaton, Roma che ferita dalla politica non smette di brillare attraverso il cinema.
Trionfo per Ammore e malavita dei Manetti Bros, che, forse a sorpresa, diviene il film mattatore della serata, aggiudicandosi anzitutto il David più prestigioso, quello per il miglior film. Tra gli altri premi conquistati dall’incantevole musical partenopeo, non potevano mancare i David musicali: Pivio e Aldo De Scalzi sono i migliori musicisti e Bang bang (musica di Pivio e Aldo De Scalzi, testo di Nelson, interpretata da Serena Rossi) è la migliore canzone originale.
Il miglior regista è invece Jonas Carpignano per A Ciambra, film premiato anche per il miglior montatore Affonso Gonçalves. Jonas Carpignano, ricevendo il premio da Pierfrancesco Favino, ricorda che ha iniziato a lavorare nel cinema italiano portando sul set il caffè proprio a quello che, oggi, gli porge la preziosa statuetta.
I migliori attori protagonisti della scorsa stagione cinematografica sono Jasmine Trinca (Fortunata) e Renato Carpentieri (La tenerezza). Al discorso orgogliosamente femminile e femminista di Jasmine Trinca, ideale portavoce del movimento “Dissenso comune”, fa da contraltare la (più?) sincera commozione di Renato Carpentieri, che consegna alla cerimonia dei David uno dei messaggi che meglio fotografano la scommessa su cui si gioca il futuro del cinema, non solo italiano: bisogna prendersi qualche rischio, ogni tanto, perché possa venire fuori un bel film.
I premi per i migliori attori non protagonisti vanno a Claudia Gerini per Ammore e Malavita e al Maestro Giuliano Montaldo per Tutto quello che vuoi.
Il David per il miglior regista esordiente è invece assegnato a Donato Carrisi per La ragazza della nebbia.
Susanna Nicchiarelli, dopo il trionfo all’ultima Mostra di Venezia, si aggiudica il premio per la miglior sceneggiatura originale per Nico, 1988, che condivide idealmente con la sua produttrice Marta Donzelli.
Nella giornata dedicata alla vittime innocenti di mafia, assume un significato simbolico il premio per la migliore sceneggiatura originale a Sicilian ghost story, che racconta la storia del piccolo Giuseppe di Matteo.
Gatta Cenerentola conquista il David per il miglior produttore (Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment e Rai Cinema) e quello per i migliori effetti speciali (Mad Entertainment): la scommessa di un film di animazione italiano, dunque, può dirsi vinta.
Piera Dettassis, neo Presidente dell’Accademia dei David di Donatello, sottolinea la varietà del cinema italiano premiato durante la serata: tanti generi (dall’animazione al cinema del reale), ma anche tante lingue (dai dialetti all’accento “straniero” di Jonas Carpignano). E tante donne, seguendo la scia dei movimenti “Metoo” e “Dissenso comune”. Del resto “La regia è femmina!”, ricorda Anselma dell’Olio ritirando il premio per La lucida follia di Marco Ferreri, miglior documentario. Il cinema deve solo accorgersene.
Riportiamo qui di seguito l’elenco completo dei premi assegnati:
Miglior film: Ammore e malavita, regia di Manetti Bros.
Miglior regista: Jonas Carpignano con A Ciambra
Miglior regista esordiente: Donato Carrisi per La ragazza nella nebbia
Migliore sceneggiatura originale: Susanna Nicchiarelli per Nico, 1988
Migliore sceneggiatura adattata: Fabio Grassadonia e Antonio Piazza per Sicilian Ghost Story
Miglior produttore: Luciano Stella e Maria Carolina Terzi per Mad Entertainment e Rai Cinema per Gatta Cenerentola
Migliore attrice protagonista: Jasmine Trinca per Fortunata
Miglior attore protagonista: Renato Carpentieri per La tenerezza
Migliore attrice non protagonista: Claudia Gerini per Ammore e Malavita
Miglior attore non protagonista: Giuliano Montaldo per Tutto quello che vuoi
Migliore autore della fotografia: Gian Filippo Corticelli per Napoli velata
Miglior musicista: Pivio e Aldo De Scalzi con Ammore e malavita
Migliore canzone originale: Bang bang (musica di Pivio e Aldo De Scalzi, testo di Nelson, interpretata da Serena Rossi) con Ammore e malavita
Miglior scenografo: Deniz Gokturk Kobanbay, Ivana Gargiulo per Napoli Velata
Miglior costumista: Daniela Salernitano per Ammore e malavita ex-aequo Massimo Cantini Parrini per Riccardo va all’inferno
Miglior truccatore: Marco Altieri per Nico, 1988
Miglior acconciatore: Daniela Altieri per Nico, 1988
Miglior montatore: Affonso Gonçalves per A Ciambra
Miglior suono: Adriano Di Lorenzo, Alberto Padoan, Marc Bastien, Éric Grattepain, Franco Piscopo per Nico, 1988
Migliori effetti digitali: Mad Entertainment per Gatta Cenerentola
Miglior documentario di lungometraggio: La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio
Miglior cortometraggio: Bismillah di Alessandro Grande.
Miglior film dell’Unione Europea: The Square
Miglior film straniero: Dunkirk
David speciale Life Achievement Award 2018:: Steven Spielberg
David speciale: Stefania Sandrelli
David speciale: Diane Keaton
data di pubblicazione: 22/03/2018
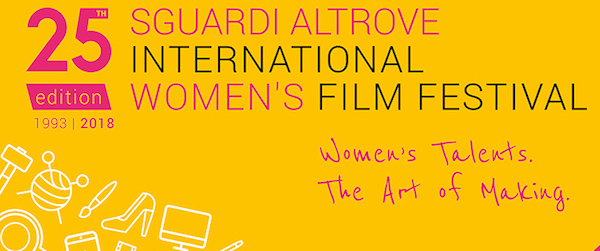
da Antonio Iraci | Mar 20, 2018
(Milano, 11/18 Marzo 2018 – Roma, 19/20 Marzo 2018)
Giunto quest’anno alla sua 25esima edizione, Sguardi Altrove è un Film Festival Internazionale principalmente al femminile, in cui vengono presentati i lavori di cineaste che attraverso il cinema portano a conoscenza del pubblico il loro impegno sociale su problematiche delle donne e sui loro diritti spesso negati. Evidenti sono ancora oggi le discriminazioni di genere, che denunziano in maniera palese quanto ci sia ancora da fare affinché le donne non subiscano più maltrattamenti e violenze, sia in ambito domestico che lavorativo. Con la direzione artistica di Patrizia Rappazzo, che oramai da anni cura sapientemente la kermesse cinematografica, l’edizione 2018 ha come tema I Talenti delle Donne. L’Arte del fare, proprio per evidenziare come le donne siano capaci di andare, con il proprio sguardo, oltre i confini che la società vorrebbe a tutti i costi imporre loro, e sconfinare in luoghi proibiti o comunque di non facile accesso. Il Festival, con i suoi 70 film selezionati di cui 30 in anteprima italiana, è entrato di diritto tra i più attesi eventi culturali milanesi e, appena conclusosi, approda a Roma alla Casa del Cinema con una tappa di due giorni per presentare i lavori premiati nelle diverse Sezioni. Occasione quindi unica che è stata offerta al pubblico romano anche per saggiare i nuovi mezzi espressivi di registe che con i loro film spesso rimangono fuori dai normali circuiti distributivi. I film presentati sono i seguenti:
Punishment Island di Laura Cini, Uganda 2017 della Sezione FrameItalia, Concorso Italiano e premiato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Il documentario tratta dell’isola di Akampene in Uganda dove venivano abbandonate a morire, per fame o annegamento, tutte le donne che erano rimaste incinte prima del matrimonio: un racconto molto toccante di tre sopravvissute perché salvate da uomini che le hanno scelte come mogli, pur essendo marchiate a vita come persone prive del diritto ad una vita sociale normale. Della stessa Sezione Il Club dei Centenari di Pietro Mereu, Italia 2016 premiato dalla Giuria Popolare, altro documentario su una provincia sarda dove esiste un’alta concentrazione di ultracentenari che raccontano episodi della loro vita e delle loro abitudini alimentari. La Giuria Giovani ha premiato invece il film Prova Contraria di Chiara Agnello, Italia 2016, che racconta l’impegno di riscattarsi socialmente da parte di alcuni giovani criminali del carcere minorile di Palermo. Altro premiato Thank you for the Rain di Julia Dahr, Norvegia/Regno Unito 2017 per la Sezione Nuovi Sguardi, Concorso Internazionale Lungometraggi – Premio Cinema Donna tra i dodici film in competizione: il documentario ha come protagonista un agricoltore che vive con la sua numerosa famiglia nel cuore del Kenya e che riesce a mobilitare la comunità locale per fronteggiare l’impatto che il cambiamento climatico ha sul territorio e sulla sopravvivenza delle stesse persone che lo abitano. La sua voce arriverà sino all’ONU e alla Conferenza sull’ambiente di Parigi dove la sua protesta avrà risonanza tra gli attivisti dei gruppi ambientalisti di tutto il mondo. Altra Sezione è Sguardi (S)confinati–Concorso Internazionale Cortometraggi–Premio Under 35 che ha premiato tra i 15 in selezione il film Large Soldier di Noa Gusakov, Israele 2017. Sherry è una quindicenne che desidera un fidanzato e lo cerca mettendo un bigliettino nelle uniformi dei soldati che insieme ad altre coetanee si è offerta di sistemare. Ai messaggi, inseriti solo in pantaloni con taglia large, risponderà solo il soldato Shaul che andrà subito a disattendere le aspettative della ragazza. Infine, più che meritato, il premio alla carriera a Francesca Archibugi con la seguente motivazione: “ Per aver saputo attraversare mestieri, generi e linguaggi diversi, passando dal cinema alla televisione, dalla recitazione, alla sceneggiatura e alla regia, dove ha dimostrato, anno dopo anno, di aver raggiunto la maturità artistica, restituendo, con maestria e sensibilità, la complessità e le sfaccettature di diverse età della vita: l’infanzia, l’adolescenza e il mondo degli adulti”. Dopo la consegna del premio è stato proiettato il suo film Il nome del figlio del 2015 in cui gli attori Alessandro Gassmann e Micaela Ramazzotti vinsero rispettivamente il nastro d’argento come miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista. Tra le Sezioni collaterali: Diritti umani, oggi film che indagano sulla violazione dei diritti umani nel mondo; Voci di donne per raccontare di personaggi femminili rimasti indimenticabili nell’immaginario di molti; Focus Bulgaria dedicato alla cinematografia bulgara al femminile. Sguardi Altrove è sicuramente un Festival in cui le donne entrano parlando non solo di sé stesse, ma anche del mondo che le circonda in cui appaiono talvolta vittime incomprese, ma anche eroine che sanno lottare per i loro diritti.
data di pubblicazione:20/02/2018














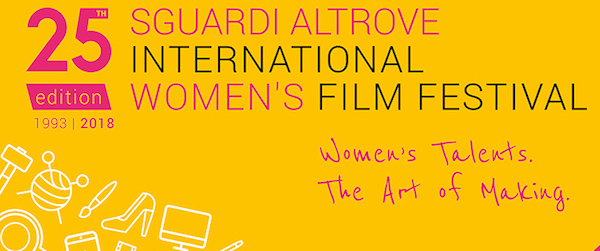





Gli ultimi commenti…