
da Antonio Iraci | Ott 5, 2018
Sin da bambino Kurt Barnert aveva deciso che nella sua vita si sarebbe occupato solo di arte, ed in particolare della pittura, anche se il suo primo impatto con essa fu visitando una mostra a Dresda di pittori contemporanei. I lavori esposti saranno poi definiti dal nascente nazionalsocialismo come “Arte Degenerata” in quanto considerata frutto di menti malate che distorcevano i principi stessi dell’opera classica a vantaggio di idee riprovevoli e fuorvianti. Il film è il percorso artistico di Kurt Barnert, che lo vede attraversare diverse fasi: dapprima al servizio dell’ideologia comunista dopo la caduta del nazismo, successivamente a contatto con le avanguardie postmoderne, fino ad approdare alla maniera espressiva a lui più consona che consistette nel rappresentare ciò che in quel momento della sua vita considerava di più autentico.
Il film presentato in concorso a Venezia nell’ultima edizione della Biennale del Cinema, vuole esplorare su cosa spinge l’uomo a ricercare la propria identità artistica, e lo fa essenzialmente attraverso la storia d’amore dei suoi protagonisti Kurt (Tom Schilling) e Ellie (Paula Beer) e il percorso di formazione che li legherà indissolubilmente per tutta la vita. Sullo sfondo inizialmente le crudeltà del nazismo, con le sue aberrazioni che non sembrano aver fine anche molti anni dopo, quando tutto sembra oramai sepolto dai nuovi slanci di democrazia. A tutto questo sopravvive l’arte che di per sé racchiude uno dei più grandi enigmi dell’umanità dal momento che sfugge a qualsiasi formula precostituita e nello stesso tempo però riesce sempre a suscitare in chi ne fruisce emozioni uniche ed indescrivibili.
Il film ripercorre una parte della storia tedesca, dalla guerra alla distruzione post nazista, alla ricostruzione, fino ad arrivare alla Repubblica Democratica Tedesca e alle sue fanatiche ideologie di stampo sovietico. In questo contesto si innesta la storia d’amore di due giovani che sembrano non aver paura di quello che si sviluppa intorno a loro, soprattutto delle esecrabili azioni del padre della ragazza privo di qualsiasi scrupolo verso tutti, persino verso la sua stessa figlia pur di difendere l’idea perversa della purezza della razza.
I 188 minuti di proiezione, questa è la durata del film, scorrono in un attimo tanto appassionante è la storia e tanta è la bravura degli attori. Tra questi Sebastian Koch, nella parte del cinico Professor Carl Seeband, già presente tra l’altro nel film Le Vite degli Altri, opera prima del regista Florian Henckel von Donnersmarck del 2006 premiato agli Oscar come miglior film straniero e che ottenne anche tre European Film Awards, sette German Film Awards, il BAFTA e il David di Donatello. La fotografia è curata da Caleb Deschanel, più volte nominato agli Oscar, che ha recentemente diretto alcune puntate della serie TV Twin Peaks.
Nella stesura della sceneggiatura il regista ha trovato ispirazione nell’opera di Gerhard Richter, dal quale ha appreso quanto basta per portare sullo schermo l’idea del potere universale dell’arte, dal momento che ogni opera che si rispetti non ha bisogno del suo autore ma appartiene a tutti senza identificarsi con il soggetto specifico che l’ha creata.
A Venezia durante la proiezione il pubblico ha manifestato entusiasmo mentre la critica ha accolto il film con un leggero ingiustificato distacco. Attendiamo i risultati in sala.
data di pubblicazione:05/10/2018
Scopri con un click il nostro voto: 

da Daniele Poto | Ott 5, 2018
 Il flash back più eloquente sulla società contemporanea è quello di una coppia muta che non si parla, ognuno dei due suoi componenti intenti a scrutare uno smartphone la cui diffusione esponenziale negli ultimi anni ha creato varie forme di dipendenze. L’autrice, riferendosi al particolare contesto della società nordamericana, dove quest’aspetto è ancora più sviluppato, una vera e propria pandemia, si rivolge soprattutto all’universo degli adolescenti per smontare il teorema che l’uso delle tecnologie sia rivolto in direzione del progresso. In realtà dall’esame sociologico sul campo emerge che questa dipendenza dall’oggetto meccanico non crea maggiore indipendenza negli adolescenti. Se ne ricava la fotografia su un compartimento chiuso e immobilizzato, in scarso contatto con la realtà, lontano da pratiche sportive e da una precoce reale autonomia dalle famiglie. Come se questo uso prolungato nel tempo dilatasse i tempi dell’adolescenza e ritardasse il consapevole ingresso nella società adulta, con annessi e connessi: il titolo di studio, la guida di un’autovettura con la conquista della patente, un fidanzamento, un lavoro stabile, il matrimonio, un domicilio proprio. L’infantilismo degli adolescenti è l’interfaccia dell’infantilismo degli adulti che non aiutano la consapevolezza dei propri figli e non ne assecondano l’affrancamento dalla famiglia. Del resto se uno studio canadese conferma come computer, smartphone e televisioni frenino lo sviluppo cognitivo, non c’è da stupirsi di fronte a una tragica constatazione: due ore quotidiane davanti a uno schermo, qualunque esso sia, danneggiano il cervello dei bambini. Un altro studioso- Kinnock- ha messo in statistica i contatti quotidiani di un americano medio con lo smartphone. Gli impulsi ricevuti nel corso della giornata sono quasi 3.000 e i controlli del mezzo 76, risucchiando, attenzione, tempo, incentivando la compulsività e il multi-tasking, pericolosissimo se si sta guidando la macchina. In altre parole questa è la dipendenza più spaventosa del mainstream contemporaneo. Più dell’azzardo, del sesso, dell’alcool, dell’uso (e abuso) di droghe). E questo libro ci aiuta a rendercene conto.
Il flash back più eloquente sulla società contemporanea è quello di una coppia muta che non si parla, ognuno dei due suoi componenti intenti a scrutare uno smartphone la cui diffusione esponenziale negli ultimi anni ha creato varie forme di dipendenze. L’autrice, riferendosi al particolare contesto della società nordamericana, dove quest’aspetto è ancora più sviluppato, una vera e propria pandemia, si rivolge soprattutto all’universo degli adolescenti per smontare il teorema che l’uso delle tecnologie sia rivolto in direzione del progresso. In realtà dall’esame sociologico sul campo emerge che questa dipendenza dall’oggetto meccanico non crea maggiore indipendenza negli adolescenti. Se ne ricava la fotografia su un compartimento chiuso e immobilizzato, in scarso contatto con la realtà, lontano da pratiche sportive e da una precoce reale autonomia dalle famiglie. Come se questo uso prolungato nel tempo dilatasse i tempi dell’adolescenza e ritardasse il consapevole ingresso nella società adulta, con annessi e connessi: il titolo di studio, la guida di un’autovettura con la conquista della patente, un fidanzamento, un lavoro stabile, il matrimonio, un domicilio proprio. L’infantilismo degli adolescenti è l’interfaccia dell’infantilismo degli adulti che non aiutano la consapevolezza dei propri figli e non ne assecondano l’affrancamento dalla famiglia. Del resto se uno studio canadese conferma come computer, smartphone e televisioni frenino lo sviluppo cognitivo, non c’è da stupirsi di fronte a una tragica constatazione: due ore quotidiane davanti a uno schermo, qualunque esso sia, danneggiano il cervello dei bambini. Un altro studioso- Kinnock- ha messo in statistica i contatti quotidiani di un americano medio con lo smartphone. Gli impulsi ricevuti nel corso della giornata sono quasi 3.000 e i controlli del mezzo 76, risucchiando, attenzione, tempo, incentivando la compulsività e il multi-tasking, pericolosissimo se si sta guidando la macchina. In altre parole questa è la dipendenza più spaventosa del mainstream contemporaneo. Più dell’azzardo, del sesso, dell’alcool, dell’uso (e abuso) di droghe). E questo libro ci aiuta a rendercene conto.
data di pubblicazione:05/10/2018

da Paolo Talone | Ott 4, 2018
(Piccolo Eliseo – Roma, 2/4 ottobre 2018)
In programma ormai già da settembre alcuni spettacoli che animano i diversi spazi di cui il teatro Eliseo dispone, dai foyer di platea e balconata fino al palcoscenico del Piccolo Eliseo, prologo a una grande stagione che festeggia i 100 anni del teatro. Inaugurato infatti nel 1918 e destinato inizialmente al divertimento della classe agiata romana con il genere dell’operetta, il teatro ben presto ospiterà sulle sue tavole la grande prosa, portata in scena da artisti del calibro di Totò, Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Mariangela Melato, la Compagnia dei giovani e da registi come Patroni Griffi, Luchino Visconti o Gabriele Lavia solo per citare alcuni nomi. Nel corso del tempo ha sempre mantenuto l’attenzione rivolta verso il teatro tradizionale, non mancando mai di aggiungere in cartellone i grandi classici, ma dando spazio alla novità, alla sperimentazione e ai giovani, soprattutto questi ultimi sul palco del Piccolo Eliseo. Tradizione non interrotta neanche con Luca Barbareschi, sotto la cui direzione il teatro venne riaperto nel 2015 dopo un anno di chiusura. Una Passione rientra nel cartellone del Prologo di Stagione.
Arriva un attore con il suo bagaglio di parrucche e costumi pronto per andare in scena, ma il palco è vuoto, la replica è sospesa. Lui decide lo stesso di mettere in scena quello che ricorda dello spettacolo e allora viene fuori il racconto di una passione tutto personale, forse caotico, ma in fondo tutto vero per quanto è vera la vita.
Un sodalizio già sperimentato in altri lavori teatrali quello tra Marco Vergani e Vinicio Marchioni, che dimostra di essere efficace e funzionante anche nella rappresentazione di questo breve testo di Valentina Diana (presente in sala), che ha la durata e l’intensità di una carezza, ma tutta la forza e il sapore dell’autenticità.
Una verità raccontata da un uomo qualunque, una semplice comparsa che lavora in un grande spettacolo, il quale contrariamente alla ragione dei grandi personaggi, perché i grandi personaggi hanno sempre una ragione importante da far valere, mostra la sua verità innocente e piccola di guitto artista relegato all’interpretazione di ruoli minori, inconsapevolmente buffo, che di ragione ne ha solo una, la sua, giusta o sbagliata che sia, ma vera e palpitante come è l’attore che abbiamo davanti.
Attraverso il racconto completamente reinventato in chiave grottesca (ma mai blasfema) della passione di Cristo, la vita di questo unico attore rimasto in scena si mischia con quella dei personaggi che via via va interpretando, in un gioco perfetto di metateatro, forse già visto, ma comunque ben rappresentato; il suo racconto diventa metafora dell’esistenza di ognuno di noi, che siamo sì gente comune, ma che possediamo anche noi una ragione da far valere come tutti, perché anche la più piccola esistenza serve a far mandare avanti la storia.
Colonna sonora dello spettacolo “Vivere” di Enzo Jannacci, che chiarisce il senso di tutto e ci fa apparire più chiaro che non bisogna essere dei grandi eroi per godere di un dono immenso come la vita, poiché come recita la canzone bisogna “vivere senza malinconia … e ridere sempre così, giocando, ridere delle follie del mondo”.
Uno spettacolo che fa sorridere e a brevi tratti riflettere, ancora per questa sera in scena al Piccolo Eliseo.
data di pubblicazione:04/10/2018
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Ott 3, 2018
(Pan Opera Festival 2018 – Panicale, 28/30 settembre 2018)
Potrà sembrare una bizzarra stravaganza l’affermare che ancora oggi, per alcuni, Rossini equivale ad individuare quel bonario gourmand che ideò una speciale ricetta per il filetto o quel particolare omonimo aperitivo a base di prosecco e pesca. Per i più informati il nome Rossini rimanda invece al celebre compositore pesarese nato nel 1792 che, con le sua musica, seppe rinnovare il teatro musicale italiano di quell’epoca, oramai lontano dalla raffinata sensibilità settecentesca ma non ancora del tutto maturo per essere identificato come romantico. Tra la sua vasta produzione musicale, sulla quale non è il caso di soffermarsi, vanno comunque annoverate quelle composizioni di breve durata che, con un accompagnamento orchestrale ridotto all’essenziale, possono definirsi piccole farse comiche a carattere giocoso. Tra queste La scala di seta, risalente al periodo veneziano del compositore e datata 1812, il cui soggetto era stato tratto dall’opéra-comique L’échelle de soie che a sua volta derivava dal libretto di Sophie ou le mariage caché, in poche parole un remake di un remake, come potremmo intenderlo oggi con linguaggio cinematografico. Proprio quest’opera, in un atto, della durata di appena novanta minuti, è stata rappresentata a chiusura del Pan Opera Festival 2018 presso il Teatro Cesare Caporali di Panicale, deliziosa cittadina umbra nota agli appassionati d’arte per aver dato i natali a Masolino, da molti ritenuto il maestro del celeberrimo Masaccio, uno dei fondatori della pittura rinascimentale. Il festival è stato ideato dall’Associazione TéathronMusikè sotto la Direzione Artistica del basso baritono e regista Virgilio Bianconi, che anche in questa quarta edizione ha voluto presentare una proposta lirica di tutto rispetto.
Da rilevare che il teatro, per le sue ridottissime dimensioni, non viene per nulla preso in considerazione dagli Enti Pubblici, ma sopravvive per i moltissimi sostenitori privati e grazie agli stessi artisti che offrono la loro professionalità accontentandosi di cachet limitatissimi. La peculiarità di questa edizione è la celebrazione del 150° anno dalla morte di Rossini e quindi un’occasione da non perdere per far conoscere la personalità del celebre compositore e per la messa in scena de La scala di seta con la regia di Primo Antonio Petris, che ne ha curato in maniera del tutto originale anche le scene e i costumi. Molto buona la performance dei cantanti accompagnati dalla Pan Opera Festival Orchestra sotto la direzione di Patrick David Murray.
Una ragione in più per visitare la splendida Panicale e conoscere il suo teatro in miniatura di appena 150 posti, incluso la platea e i due ordini di palchi, una chicca per i melomani e per i curiosi in cerca di luoghi particolari da iscrivere nel proprio cahier de voyages.
data di pubblicazione:03/10/2018

da Rossano Giuppa | Ott 1, 2018
(Teatro Argentina – Roma, 25/26 settembre 2018)
Già due anni avevano esultato tutti con lo spettacolo OCD Love, una ventata di amore e sensualità grazie allo splendido lavoro realizzato da Sharon Eyal, coreografa associata alla Batsheva Dance Company. Oggi gli stessi autori tornano con un naturale sequel: Love Chapter II.
La famosa artista, nativa di Gerusalemme, è uno dei tre elementi portanti della L-E-V Company (letteralmente cuore, in ebraico), insieme a Gai Behar animatore della vita notturna di Tel Aviv e il musicista, padre dei techno rave israeliani, Ori Lichtik.
In Love Chapter II, presentato il 25 e 26 settembre al Teatro Argentina,una scarica adrenalina ed emotiva avvolge i performer e coinvolge gli spettatori catturati dalla tech trance e dalla danza senza respiro, contratta ed elastica al tempo stesso, avvolgente e coinvolgente, che non conosce tregua,personale ed uguale, attraverso una interpretazione fisica devastante. Questa è l’arte portata in scena da Sharon Eyal, una danza forte, fatta di pura emotività e sentimento, che permette di esternare l’io più interiore e trasportarlo, attraverso suoni, luci e danze sul palcoscenico,capace di trasmettere un’energia dirompente e di fondere con eleganza musica elettronica, rigore coreografico e atmosferaglamour. Una pièce un po’ criptica sul rapporto amoroso che, tra dolcezza e violenza, pulsa vigore e dolore, regalando però bellezza e luminosità.
data di pubblicazione:01/10/2018
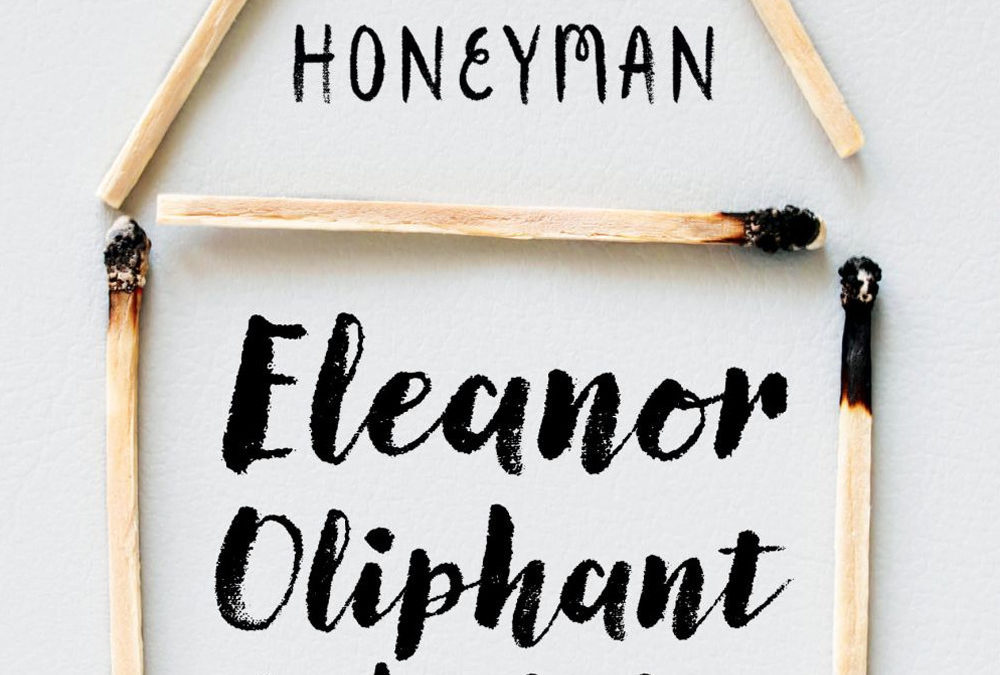
da Antonietta DelMastro | Ott 1, 2018
 Ho preso in mano il libro incuriosita dal titolo, ma non sono riuscita ad andare molto avanti e l’ho lasciato sul comodino fino all’estate quando, dopo l’insistenza di una collega che lo aveva trovato imperdibile, l’ho ripreso e hoterminato di leggerlo.
Ho preso in mano il libro incuriosita dal titolo, ma non sono riuscita ad andare molto avanti e l’ho lasciato sul comodino fino all’estate quando, dopo l’insistenza di una collega che lo aveva trovato imperdibile, l’ho ripreso e hoterminato di leggerlo.
La storia credo che sia ormai di dominio pubblico, visto il battage che ha avuto nei mesi estivi, e la notizia che ne verrà presto fatto un film. Eleanor Oliphant è una donna di poco meno di trent’anni che lavora come contabile in un’agenzia di graphic design; la sua vita ha una ripetitività maniacale, sempre gli stessi vestiti, gli stessi cibi, arriva sempre alla stessa ora in ufficio, la pausa pranzo da sola con un sandwich e il cruciverba del DailyTelegraph, il mercoledì sera riceve la telefonata della madre e tutti i venerdì sera compra due bottiglie di vodka. Gli ultimi nove compleanni, Natali e Capodanni li ha passati da sola in casa con la sua amica più intima,la piantina grassa di nome Polly, il massimo della trasgressione è la cotta adolescenziale che ha per un cantante di una rock band.
Anche il suo aspetto è ordinario, “Eccomi qui: Eleanor Oliphant. Capelli lunghi, lisci, castano chiaro, che mi scendono giù fino alla vita, pelle chiara, il volto un palinsesto di fuoco. Un naso troppo piccolo e occhi troppo grandi. Orecchie: niente di eccezionale. Altezza più o meno nella media, peso approssimativamente nella media. Aspiro alla medietà…. Sono stata al centro di fin troppa attenzione in vita mia. Ignoratemi, passate oltre, non c’è nulla da vedere qui”.
Qualcosa nella vita di Eleanor inizia a cambiare quando stringe amicizia con Raymond, un collega di lavoro che riesce afare breccia nella sua solitudine e a scardinare alcune delle sue idiosincrasie grazie alla sua estrema gentilezza e al suo di starle vicino, senza giudicarla e cercando di addolcire i modi fin troppo diretti con cui Eleanor sipone verso gli altri. Con lui Eleanor inizierà a scardinare le sue abitudini, inizierà ad aprirsi agli altri e riuscirà ad affrontare la realtà della sua vita che, fino ad allora, aveva negato anche a se stessa.
Per buona parte del romanzo siamo attori e testimoni inermi dei pensieri e comportamenti vagamente borderline di Eleanor senza riuscire a capire le motivazioni che li scaturiscano e senza riuscire a sentirci a lei “vicini”; quando finalmente, nelle ultime pagine, ci viene svelato il drammatico passato di Eleanorpossiamostabilire un rapporto empatico con la protagonista, capiamo cosa abbia passato e il perché della sua vita solitaria e maniacale ma forse è ormai troppo tardi per farcela amare.
Un libro da leggere macerto non il libro dell’anno che alcuni hanno voluto far credere fosse.
data di pubblicazione:01/10/2018

da Daniele Poto | Set 28, 2018
 Non vi stupisca una recensione a una guida gastronomica. Se l’uomo è ciò che mangia secondo Feuerbach nello spirito del tempo la passione per il mangiare e il bere è diventata arte e mainstream. E dalla lettura morfologica di una guida gastronomica si può arguire lo spirito del tempo e le sue declinazioni positive e negative. Dunque la bussola da orientare ci avvisa che siamo in un quartiere bene di Roma che, presumibilmente, ha avvalorato una maggioranza di suffragi per il Pd nell’ultima tornata elettorale. Cittadini benestanti che possono spendere in una forbice circoscrizionale che va dai margini di Montesacro a Porta Pia attraverso le due grandi direttrici di Corso Trieste e via Nomentana. Dalla descrizione dei piatti più riusciti e dall’indicazione dei prezzi si ricava la constatazione di quanto sia cara una città come Roma se in genere sia primi che secondi vanno in doppia cifra (dai 10 euro in su) e i dolci iniziano ad avvicinarsi a questo confine. Per non parlare del ricarico dei vini sempre esagerato in Italia. Si rivela la tendenza per la deriva etnica. Passata di moda la Cina è il Giappone a recitare la parte del leone, lasciando un piccolo spazio alla Thailandia, all’Arabia, persino alla lontana Corea. I piatti della cucina povera, spesso esaltati, ora sono diventati oggetti di culto rispetto soprattutto ai valori crescenti del colesterolo. Ma c’è ancora sacro rispetto e valorizzazione per trippa, coda alla vaccinara, gricia. Certo oggi, per chi è vissuto nei tempi della lira, può far sinceramente impressione che pur nel totale ridimensionamento nel consumo di carne, una costata arrivi a costare 25 euro, cioè quasi le 50.000 lire di una volta. Ma per chi non può spendere c’è sempre l’escamotage non banale della pizza. Cucinata in tanti (troppi?) modi, anche nell’orribile variazione con la nutella o con le patate fritte. Con ovvia costante lievitazione di prezzo. Da quanto sono affollati i locali in questo emisfero di Roma nord si è quasi portati ad avvalorare l’affermazione di un politico navigato quanto vintage. L’Italia è il paese dell’intatto benessere perché i ristoranti sono quasi sempre tutti pieni. In particolare a Roma dove l’edonismo e il piacere per queste pratiche è consolidato.
Non vi stupisca una recensione a una guida gastronomica. Se l’uomo è ciò che mangia secondo Feuerbach nello spirito del tempo la passione per il mangiare e il bere è diventata arte e mainstream. E dalla lettura morfologica di una guida gastronomica si può arguire lo spirito del tempo e le sue declinazioni positive e negative. Dunque la bussola da orientare ci avvisa che siamo in un quartiere bene di Roma che, presumibilmente, ha avvalorato una maggioranza di suffragi per il Pd nell’ultima tornata elettorale. Cittadini benestanti che possono spendere in una forbice circoscrizionale che va dai margini di Montesacro a Porta Pia attraverso le due grandi direttrici di Corso Trieste e via Nomentana. Dalla descrizione dei piatti più riusciti e dall’indicazione dei prezzi si ricava la constatazione di quanto sia cara una città come Roma se in genere sia primi che secondi vanno in doppia cifra (dai 10 euro in su) e i dolci iniziano ad avvicinarsi a questo confine. Per non parlare del ricarico dei vini sempre esagerato in Italia. Si rivela la tendenza per la deriva etnica. Passata di moda la Cina è il Giappone a recitare la parte del leone, lasciando un piccolo spazio alla Thailandia, all’Arabia, persino alla lontana Corea. I piatti della cucina povera, spesso esaltati, ora sono diventati oggetti di culto rispetto soprattutto ai valori crescenti del colesterolo. Ma c’è ancora sacro rispetto e valorizzazione per trippa, coda alla vaccinara, gricia. Certo oggi, per chi è vissuto nei tempi della lira, può far sinceramente impressione che pur nel totale ridimensionamento nel consumo di carne, una costata arrivi a costare 25 euro, cioè quasi le 50.000 lire di una volta. Ma per chi non può spendere c’è sempre l’escamotage non banale della pizza. Cucinata in tanti (troppi?) modi, anche nell’orribile variazione con la nutella o con le patate fritte. Con ovvia costante lievitazione di prezzo. Da quanto sono affollati i locali in questo emisfero di Roma nord si è quasi portati ad avvalorare l’affermazione di un politico navigato quanto vintage. L’Italia è il paese dell’intatto benessere perché i ristoranti sono quasi sempre tutti pieni. In particolare a Roma dove l’edonismo e il piacere per queste pratiche è consolidato.
data di pubblicazione:28/09/2018

da Antonio Iraci | Set 28, 2018
Florence Green, oramai vedova da diversi anni, vuole scrollarsi di dosso la tristezza che pervade la sua vita e decide di realizzare il suo sogno nascosto che è quello di aprire una libreria. Sfortunatamente sceglie il posto sbagliato: la piccola cittadina di Hardborough sulla costa inglese. Florence si troverà presto ad affrontare non solo lo scetticismo della gente del luogo ma, essenzialmente, l’ostruzionismo della ricca Mrs. Gamart che vuole assolutamente difendere la propria influenza culturale su questa cittadina in perenne letargo. A tutto questo si aggiunge lo scandalo sollevato dalla vendita di libri quali Lolita di Nabokov e Fahrenheit 451 di Ray Bradbury che sicuramente non facilitano il compito di farsi ben volere dalle persone del posto.
La regista catalana Isabel Coixet è ben nota al pubblico italiano grazie al successo ottenuto nel 2005 con La vita segreta delle parole, presentato al Festival di Venezia nella Sezione Orizzonti e premiato in patria con ben quattro premi Goya tra cui quelli per miglior film e migliore regia. Nel 2003 con La mia vita senza me (candidato agli European Film Awards come miglior film e due premi Goya) si era fatta notare anche alla Berlinale dove, nell’edizione di quest’anno, ha presentato La casa dei libri.
Tratto dal romanzo The bookshop di Penelope Fitzgerald del 1978, il film è ben costruito, con una fotografia che conferisce alla pellicola un respiro di aria fresca liberandola dall’atmosfera polverosa della libreria di Florence (Emily Mortimer) alla quale la ventosa costiera britannica fa da contrappunto. La protagonista è un personaggio che dietro l’apparente fragilità di una vedova indifesa nasconde invece una buona dose di coraggio e di risolutezza di fronte alle situazioni avverse che le si presentano; dovrà infatti lottare molto contro l’aristocratica Mrs. Gamart (Patricia Clarkson) che cercherà, in tutti i modi, di ostacolare l’attività della libreria ricorrendo a stratagemmi politicamente poco corretti.
Il finale, seppur non possa definirsi un happy end, non cancella tuttavia quella prevedibilità che distoglie in parte l’interesse dello spettatore. All’incontestabile bravura degli interpreti si registra, di contro, una narrazione poco interessante e del tutto priva di qualsiasi coinvolgimento emotivo: ne risulta un film lento e a tratti addirittura noioso, riscattato dall’unica nota positiva rappresentata dalla figura di Florence che ama non solo leggere i libri ma anche accarezzarli, per scoprirne quel fascino segreto che va al di là della carta stampata.
data di pubblicazione:28/09/2018
Scopri con un click il nostro voto: 

da Rossano Giuppa | Set 25, 2018
(Teatro Argentina – Roma, 19/22 settembre 2018)
Un mondo senza barriere ed un teatro senza confini. La risposta alla mancata caduta dei muri ed alle separazioni tra popoli non può che essere di natura culturale: questa la sfida di Roma Europa 2018 che si apre ad artisti dell’Africa, della Cina, dell’Iran, dell’Argentina per far conoscere l’immaginario di altri paesi e permettere il confronto con altre visioni del mondo.
Allo spettacolo Kirina spetta l’apertura di questa trentatreesima edizione. È un’opera per 9 danzatori, 1 attore, 4 musicisti, 2 cantanti e 40 figuranti, nata dalla collaborazione tra il coreografo Serge-Aimè Coulibaly (già danzatore per Les Ballets C de la B di Alain Platel e fondatore della Faso Danse Théâtre), la cantante maliana, icona della musica mondiale, Rokia Traorè e lo studioso e scrittore Felwine Sarr nelle vesti di librettista.
Kirina è il nome della località situata nell’odierna Guinea, dove si è svolta l’ultima battaglia da cui è nato l’impero mandingo nell’Africa Occidentale: parte proprio da quel luogo questa speciale creazione polimorfa, che racconta e descrive il percorso di un popolo, colto nel suo momento di massima forza e splendore.
Il protagonista Sundjata Keita è anzitutto una figura storica: il fondatore dell’impero del Mali che unificò in un regno pacifico e avanzato varie popolazioni di ceppo mandingo verso la metà del duecento, ma Keita è anche una figura mitologica per i popoli dell’Africa occidentale, una sorta di Orlando che si reincarna e si rigenera e le cui gesta sono state cantate per secoli e tramandate nel tempo.
Un racconto complesso e stratificato che è una lunga marcia verso la nascita del primo impero centralizzato africano, e che in chiave contemporanea rivendica l’essenza della storia e della cultura africana.
Kirina è uno spettacolo di teatro danza che sfugge a ogni tentazione di esotismo o di ricostruzione nostalgica o etnica: musiche tra il tribale e l’elettronico, sublimi voci femminili e coreografie asciutte e incisive, emotivamente legate alla cultura pop.
La forza dello spettacolo si basa sull’interazione tra la potenza delle voci e l’originale disegno dei passi dei danzatori che basta da sola a far rivivere la storia di Sundjata. Meno convincente la musica, non sempre coivolgente, e l’impianto complessivo che non emoziona.
data di pubblicazione:25/09/2018

da T. Pica | Set 24, 2018
Presentato alla 75° Mostra di Arte Cinematografica Internazionale di Venezia l’ultimo film di Roberto Andò non convince, un po’ già come era avvenuto con Le Confessioni nel 2016.
Vi siete mai addormentati al cinema? Io no, ma c’è sempre una prima volta e non pensavo potesse accadere con una pellicola dalla trama gialla interpretata da un cast di tutto rispetto come quello chiamato da Andò per interpretare i protagonisti della sua Storia senza nome.
Valeria (Micaela Ramazzotti) è una delle segretarie del produttore cinematografico Vitelli (Antonio Catania) nonché ghostwriter del noto sceneggiatore Alessandro Pes (Alessandro Gassman), del quale è stata amante ancora innamorata. L’affascinante e donnaiolo Pes, infatti, da anni non riesce a scrivere nulla di avvincente e anche per l’ultimo lavoro promesso a Vitelli si avvale della penna di Valeria. Proprio a ridosso della scadenza della consegna del plot di Pes, Valeria diviene la “depositaria” di una storia avvincente e misteriosa, quella del furto del quadro “Natività” di Caravaggio, da parte di un altrettanto misterioso e sfuggente signore anziano, Alberto Rak (Renato Carpentieri). Affascinata e rapita da questa storia, la bella ghostwriter la riversa nello scritto della nuova sceneggiatura di Alessandro Pes dal titolo Una storia senza nome. Trattandosi però di una storia tratta da fatti realmente accaduti ed essendoci tra i soci finanziatori del film anche un produttore, legato ai mafiosi protagonisti della Storia Senza Nome riferita a Valeria dall’investigatore in pensione Rak, si innescano subito una serie di “manovre”, sotterfugi e rapimenti finalizzati a mandare in fumo la realizzazione del film: la trama infatti è assai scomoda e compromettente per Cosa Nostra. Nonostante la storia a tinte gialle dovesse avvincere e tenere alta l’attenzione, il film non riesce a decollare e appare lento, monotono, a tratti inverosimile anche per un’interpretazione non brillante degli attori, in particolare di Micaela Ramazzotti e Laura Morante (nel ruolo della madre di Valeria) che sotto la direzione di Andò non sembrano le divine che propriamente sono nel firmamento del Cinema italiano contemporaneo.
Tanti elementi (spunti della trama, la storia della Natività di Caravaggio, l’intreccio tra mafia, arte, cultura e politica, il cast) lasciavano sicuramente sperare in un film d’impatto, dai toni più fermi, decisi, avvincenti. Purtroppo, però, la storia senza nome portata sul grande schermo da Andò si perde, a tratti pare un presa in giro, arranca su se stessa fino a un finale quasi ridicolizzante che sugella la delusione delle alte aspettative dello spettatore.
data di pubblicazione:24/09/2018
Scopri con un click il nostro voto: 









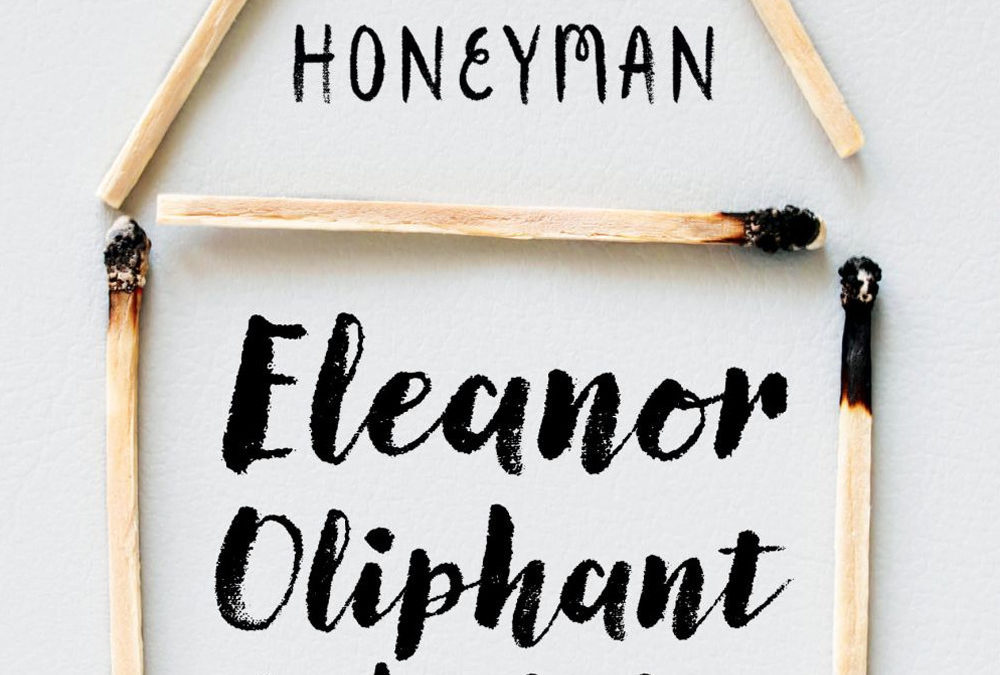









Gli ultimi commenti…