
da Antonella Massaro | Ott 23, 2018
(FESTA DEL CINEMA DI ROMA – 13ma Edizione, 18/28 ottobre 2018)
Il confine tra giusto e sbagliato, tra virtù e peccato, tra educazione e diseducazione è sempre particolarmente labile in una società chiamata a fare i conti con stereotipati pregiudizi e con la paura di ciò che, in un modo o nell’altro, appare “diverso”. The Miseducation of Cameron Post è un affresco delicato e profondo dell’adolescenza vissuta su quel confine: senza morbosa tragicità, ma con realistica “normalità”.
In una Festa del Cinema particolarmente attenta alle tematiche “di genere”, The Miseducation of Cameron Post si colloca dalla prospettiva, ironica ma disillusa, dell’età adolescenziale.
Cameron (una impeccabile Chloë Grace Moretz) è una liceale che cerca di sembrare come tutte le altre ragazzine della sua età, con tanto di brufoloso accompagnatore al ballo della scuola. Intrattiene però una relazione con la coetanea Coley (Quinn Shephard), che fa parte del suo stesso gruppo di studio della Bibbia: è un rapporto coinvolgente e idilliaco, ma quando le due ragazze vengono scoperte, Cameron è costretta a “ricoverarsi” in nella comunità religiosa God’s Promise.
All’interno del centro i ragazzi deviati, affetti dalla sindrome ASS (attrazione per persone dello stesso sesso) o con la passione per le droghe leggere, sono chiamati a un processo di rieducazione che dovrebbe portarli a prendere consapevolezza dei loro peccati e a guarire, con l’aiuto di Dio e dei responsabili della comunità, dalle proprie perversioni.
Il percorso con il quale Cameron è chiamata a confrontarsi si rivela a tratti paradossale. Da una parte, la causa di tutti i mali sembra essere proprio quella famiglia tradizionale, basata su sane relazioni eterosessuali, di cui tutti cantano il mito e che dovrebbe rappresentare la via della salvezza dal peccato. Dall’altra parte, gli educatori, pur ostentando serenità e sicurezza, sono forse più instabili emotivamente degli ospiti che pretenderebbero di rieducare. L’incontro con Jane Fonda (Sasha Lane) e Adam (Forrest Goodluck) servirà a Cameron per portare a termine il suo processo di “diseducazione” e di consapevolezza.
Il film di Desiree Akhavan, vincitore del Gran Premio della Giuria all’ultima edizione del Sundance Festival, è tratto dall’omonimo romanzo di Emily M. Danforth, che ha acceso i riflettori sull’equivoca realtà dei centri di rieducazione americani per ragazzi che di problematico hanno solo i pregiudizi con cui sono chiamati a fare i conti.
I toni del racconto, mai morbosi o eccessivamente cupi, rendono plasticamente la “normalità” di quello che si pretende di additare come anormale, restituendo l’impressione che la realtà distorta e “diseducativa” sia proprio quella attorno a cui è costruito God’s Promise: sono concessi il karaoke con canti religiosi e le rock band che intonano canti al Signore, mentre viene censurata l’innocente e travolgente esibizione di Cameron, che canta a squarciagola sulle note di What’s up.
I personaggi sono caratterizzati con lodevole precisione e il cast funziona in maniera pressoché perfetta. La sequenza finale, poi, vale il film intero.
data di pubblicazione: 23/10/2018


da Antonio Jacolina | Ott 23, 2018
(FESTA DEL CINEMA DI ROMA – 13ma Edizione, 18/28 ottobre 2018)
Starr (Amandla Stenberg) è una 16nne afro-americana, vive due vite. La prima nel suo quartiere periferico ed emarginato dove la maggior parte delle persone sono nere e povere e dove dominano le gang e le droghe. La seconda è invece nel suo ambiente scolastico in uno dei migliori istituti privati della città ove l’hanno iscritta i genitori per darle migliori opportunità e dove il contesto è bianco e ricco. Non è facile per la ragazza vivere in equilibrio in questi due mondi così lontani e diversi fra loro. Un giorno, dopo una festa da vicini di casa, un suo amico d’infanzia viene ucciso senza aver fatto nulla da un poliziotto bianco. Starr è l’unica testimone, gli equilibri saltano ed inizia per lei un viaggio di scoperta di se stessa, delle sue convinzioni, appartenenze e verità …
Tillman è un affermato sceneggiatore e discreto regista americano che ha esordito nel 2000 con Men of honor e ci regala oggi un’opera forte, evocativa e bella, tratta da un romanzo di successo di pari titolo di A. Thomas. Un film che può sembrare essere solo una storia di crescita e formazione giovanile, un teen-movie sui problemi amorosi adolescenziali, in realtà il regista sa andare ben oltre lo spirito narrativo di cornice e realizza un lavoro che parla non solo ad un audience giovanile ma anche ad un pubblico adulto di tutte le età. Difatti, sia pure dalla prospettiva di una giovane, ci fa riflettere tutti su: dignità dell’individuo, forza della verità, solidarietà familiare, giustizia sociale ed identità individuale e collettiva.
Starr è una ragazza che è alla ricerca del suo “essere chi” e scopre ciò in cui credere e ciò che effettivamente è, solo dopo una presa di coscienza di se stessa davanti alla brutalità della polizia, del razzismo e della violenza di ogni tipo. Tutto il film è in perfetto equilibrio fra mondo scolastico e storia individuale da una parte, e mondo emarginato e dramma sociale dall’altra, senza sacrificare mai spazio e qualità di nessuna delle due parti. La narrazione è supportata da una buona sceneggiatura dietro la quale si vede tutta la forza del libro da cui è tratta, i dialoghi sono ben definiti e realistici, il ritmo è costante senza pause o cedimenti. La regia sa poi abilmente alternare momenti di allegria o leggeri con svolte drammatiche, sentimenti di dolcezza e rabbia individuale con sentimenti di commozione e rabbia collettiva. La composizione del cast, come tipico delle produzioni americane, è perfetta fin nei ruoli più marginali. Emerge su tutti, e, praticamente, illumina il film con la sua bellezza e con il suo splendido sorriso, la giovanissima e talentuosa Stenberg. La sua interpretazione ha una forza creativa che cresce in capacità e profondità in ogni scena, cesellando con intensità il suo personaggio. Nel ruolo del padre giganteggia Russel Hornsby.
Il film di Tillman è senza dubbio un film da vedere e da godere, uno dei suoi migliori. Un film che è anche fortemente rappresentativo della realtà odierna della comunità nera degli Stati Uniti, stretta fra una nuova auto rappresentazione di se stessa sul piano della famiglia, della comunità, delle nuove generazioni e, di contro, la permanenza di vecchi pregiudizi e mai scomparsi razzismi. Un film che è uno sguardo giovane, fresco e consapevole su tale realtà e che merita tutta la simpatia, l’empatia e gli apprezzamenti dello spettatore. Decisamente un bel film.
data di pubblicazione:23/10/2018


da Giovanni M. Ripoli | Ott 23, 2018
(FESTA DEL CINEMA DI ROMA – 13ma Edizione, 18/28 ottobre 2018)
Nic Sheff è bello, bravo e intelligente ed è circondato dall’affetto della sua famiglia benestante e liberal, ma dopo aver provato, come tanti suoi coetanei, la metanfetamina, diventa totalmente dipendente da tutte le droghe possibili e immaginabili. La storia è il vero calvario cui si sottopone il giovane, ma anche la sua famiglia per tentare il problematico recupero. Come si dice in questi casi: tratto da una storia vera.
Beautiful boy è la dolcissima canzone di John Lennon dedicata al figlio Sean ed è anche un brano che si ascolta in sottofondo nel film di Felix Van Groeningen dal titolo omonimo. Anche nella pellicola si parla di un bellissimo ragazzo con dei problemi…
Già ammirato nei paesi di lingua inglese, il film di Van Groeningen, quarantaquattrenne regista e sceneggiatore belga (il suo Alabama Monroe del 2012 fu candidato agli Oscar) oltre a una buona storia, tratta dalle biografie degli stessi reali protagonisti, David Sheff e Nic Sheff, ha l’indiscusso merito di proporre una recitazione “da Oscar” per gli attori, il padre ( Steve Carrell) e il figlio (Timothèe Chamalet, già ammirato nel film di Guadagnino). La regia, pur solida, non mostra tracce di particolare originalità, attenendosi a uno stile sobrio e rigorosamente classico. Scelta forse meditata e voluta per una storia forse non originale, ma, purtroppo ancora attualissima in differenti realtà. Il regista sceglie di raccontarci quello che accade in una famiglia della middle class americana, aperta e felice prima della scoperta della “tossicità” del loro bellissimo e apparentemente bravissimo Nic. Nel film viviamo con il padre, la madre (AmyRyan) e la seconda moglie di David (l’intensa Maura Tierney), le innumerevoli “guarigioni e ricadute” del giovane. Più volte ci illudiamo che dopo cliniche riabilitative, ripensamenti, ansie, paure, pentimenti, rischi di overdose, il ragazzo sia finalmente uscito dal tunnel della dipendenza, ma, per quasi due ore, si tratta solo di illusioni per la famiglia e per il pubblico. l’Happy end, però, giunge nel finale e sembra legato principalmente all’affetto ritrovato nel focolare domestico e alla nuova consapevolezza del giovane. Beautiful Boy, è nel complesso un buon film che attraverso flash back, una narrazione solida e soprattutto una assai convincente prova di attori, offre uno spaccato realistico di un percorso doloroso, comune a tante famiglie. Certo la pellicola non entra nel merito di approfondimenti psicologici sulle motivazioni che portano alle dipendenze, ma si apre e bene ad esplorare il forte rapporto affettivo padre-figlio, cardine del film stesso, grazie – come detto – alle notevoli performances dei due attori, dove Steve Carrell è un padre decisamente credibile: lacerato ma mai melenso, sempre nelle righe nel dolore come nei suoi entusiasmi, e Chamalet, cui è facile prevedere una candidatura agli Oscar, è al pari perfetto, sia nei momenti più drammatici, sia in quelli gioiosi e persino poeticamente dolci (come nei giochi con i piccoli fratellini nati dal secondo matrimonio del padre). Dunque, film pur alle prese con un tema non facile, risulta avvincente e mai noioso, accettabilissimo proprio perché privo di quella retorica che spesso è sottesa in pellicole similari.
data di pubblicazione:23/10/2018


da Antonio Iraci | Ott 22, 2018
(FESTA DEL CINEMA DI ROMA – 13ma Edizione, 18/28 ottobre 2018)
Jared, figlio del pastore protestante di una piccola cittadina dell’Arkansas, è costretto dal padre a seguire una terapia riabilitativa di conversione dopo aver confessato di essere gay. Mandato in un centro specializzato, dovrà seguire un rigido programma allo scopo di modificare forzatamente il proprio orientamento sessuale. Una maggiore presa di coscienza di sé determinerà in lui un radicale cambiamento ma non nella direzione che gli si voleva imporre.
Questa tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma affronta in maniera decisa problematiche ancora attuali nella società americana e che, per estensione, riguardano anche la realtà in cui ci troviamo: la discriminazione razziale e la difficoltà a manifestare apertamente la propria identità sessuale. Su quest’ultimo punto il film Boy Erased, che porta la firma del regista e attore australiano Joel Edgertorn, sembra essere perfettamente calzante per gettare uno sguardo nell’animo di un adolescente al quale viene impedito di essere se stesso, prima dalla famiglia e poi dalla società in cui vive. Il protagonista, interpretato da Lukas Hedges, è circondato da un ambiente impregnato di una religiosità austera tutta rivolta a suscitare in lui infondati sensi di colpa solo per il fatto di essere attratto da individui dello stesso sesso. Al padre, da buon pastore protestante, non rimane che applicare le proprie insane convinzioni e imporre al figlio quel radicale “trattamento” necessario per essere accettato dagli altri. Il ruolo dei genitori è interpretato da un ingombrante Russel Crowe e da una sempre affascinante Nicole Kidman, meno ingessata del solito, che riescono a manifestare quel sentimento di impotenza, mista a rabbia, che sentono nei confronti del loro figlio Jared. Una violenza psicologica, a tratti anche fisica, che si percepisce e della quale non ci si riesce a liberare.
Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico dello scrittore Garrad Conley, il film ripercorre con un senso di grande sensibilità il travaglio del giovane protagonista e le difficoltà che dovrà affrontare per accettarsi e farsi accettare. Nello strepitoso cast troviamo anche lo stesso regista, nella parte del terapeuta, mentre un piccolo ruolo viene ricoperto da Xavier Dolan, sul quale non è necessario soffermarsi data la sua conclamata notorietà. Un film coraggioso del quale se ne consiglia vivamente la visione.
data di pubblicazione:22/10/2018


da Rossano Giuppa | Ott 22, 2018
(Teatro Vitttoria – Roma, 11/20 ottobre 2018)
Un uomo siede da solo davanti a un’enorme prigione in un paesaggio desertico. Chi è? E perché si trova in questo luogo? È una sua libera scelta oppure sta scontando una qualche forma di punizione?
Si apre con questi interrogativi The prisoner, ultimo lavoro di Peter Brook diretto insieme a Marie-Hèlène Estienne e presentato in prima italiana per il Roma Europa Festival al Teatro Vittoria, dall’11 al 20 ottobre.
La storia è quella del giovane e irrequieto Mavuso che uccide suo padre dopo averlo sorpreso a letto insieme a sua sorella. Mavuso in realtà ama la propria sorella Nadia e uccide il loro padre per gelosia. Lo zio Ezekiele diventa giudice di questa situazione, che è frutto di grande amore ma che ha portato a un assassinio, e condanna Mavuso a una punizione esemplare: dovrà rimanere sulla collina di fronte alla prigione, da solo a guardare le mura per un tempo indefinito, aspettando una presunta redenzione, mentre a farlo prigioniero, più che le sbarre, sono i suoi fantasmi.
Brook ed Estienne mettono in scena una parabola sul tempo della pena, uno spettacolo stupefacente che affronta i temi della punizione, della giustizia e del crimine con quel consueto tocco vibrante e poetico che caratterizza la sua scrittura scenica.
Il cast è formato da un eccezionale gruppo di attori di varie nazionalità, Hiran Abeysekera, Hayley Carmichael, Hervé Goffings, Omar Silva e Kalieaswari Srinivasan.
Gli autori antepongono la meditazione al dramma, partendo da una scenografia sospesa e immobile che racconta soprattutto il percorso tutto intimo e personale di Marvuso verso la salvezza, dal piano della redenzione a quello della consapevolezza.
Uno spettacolo rarefatto, assolutamente asciutto e essenziale. Tutto viene appunto semplicemente messo in scena, con un sapiente uso delle luci, senza interpretazioni, rivelando nodi, interrogativi, umanità cui è lo spettatore a dover dare un senso. E sono spesso i corpi, gli sguardi, i volti, la fisicità a essere assolutamente espressivi. L’umanissimo teatro antropologico del grande regista.
data di pubblicazione:22/10/2018

da Rossano Giuppa | Ott 22, 2018
(Teatro Olimpico – Roma, 17/19 ottobre 2018)
Un mondo in caduta libera, pieno di conflitti, ma carico di energia e forza anarchica e propulsiva, una commedia violenta dal sapore agrodolce. Dieci meravigliosi danzatori in scena accompagnati da un gruppo di straordinari musicisti live, per il Grand Finale di Hofesh Shechter al Roma Europa Festival dal 17 al 19 ottobre al Teatro Olimpico, “una danza intorno all’abisso per indagare i grandi temi del presente” come la precarietà della quotidianità, i disastri politici ed ecologici, la violenza e il terrore, “senza rinunciare a quel black humor che è ormai firma del coreografo”. Una danza ai confini del mondo, al suono dell’apocalisse, ma con quella componente british, che tradisce un ottimismo leggero e fiducioso. È il marchio di fabbrica Hofesh Shechter, coreografo israeliano trapiantato a Londra, riconosciuto a livello internazionale come uno degli artisti più emozionanti della danza contemporanea, tornato ospite al RomaEuropa Festival per la terza volta. Regista e coreografo, ma anche musicista, Hofesh Shechter fa parte di quel gruppo di straordinari artisti nati, cresciuti in Israele e poi emigrati nel mondo (Ohad Naharin, Sharon Eyal, Gai Behah,).
Un lavoro che amalgama danza, teatro e musica, guardando al passato e aprendo a nuove strade.
Una nebbia avvolge la scena e la platea, efficacissime luci e sonorità di contrasto tra classico e contemporaneo enfatizzano le gestualità dei performer, a tratti enfatiche, a tratti devastanti. Un piano sequenza che scorre in uno spazio in perenne evoluzione fatto di pieni e di vuoti, di storia e di rivolta. È il talento di Shechter quello di analizzare ed esorcizzare, allo stesso tempo, i demoni del nostro presente.
Spettacolo comico, cupo e meraviglioso, carico di eccessi, di forza, bellezza, dinamismo che ti devasta ma che ti auguri non finisca.
data di pubblicazione:22/10/2018

da Antonio Jacolina | Ott 22, 2018
(FESTA DEL CINEMA DI ROMA – 13ma Edizione, 18/28 ottobre 2018)
Agosto 2000, il sottomarino nucleare russo Kursk affonda, a seguito di alcune esplosioni, nel mare di Barents. Solo 23 membri dell’equipaggio riescono a rifugiarsi nell’unico scompartimento stagno rimasto intatto. Mentre a bordo i marinai lottano per sopravvivere, a terra le loro famiglie lottano contro la cortina di silenzio che le autorità cercano di porre attorno all’incidente. Una corsa contro il tempo per salvarli fra le inefficienze dei soccorsi e le esitazioni politiche se accettare o meno gli aiuti internazionali.
Thomas Vinterberg, sceneggiatore e celebrato regista danese, ci propone un film che è agli antipodi della Carta Cinematografica Dogma 95 di cui egli stesso è stato uno dei cofondatori ma da cui si è ormai molto allontanato da anni, passando così da Festen fino al remake di Via dalla pazza folla. Siamo difatti ben lontani dai vincoli di verità e sinteticità imposti dal Movimento, siamo piuttosto nel filone tutto commerciale del drama-movie centrato su un evento catastrofico, nella ennesima riproposizione di una “storia vera” senza però avere la profondità analitica di un documentario. La pellicola traendo spunto dall’evento agisce infatti in assoluta libertà creativa ed inventiva nel generale contesto degli eventi reali di cui, fra l’altro, moltissimi sono gli enigmi ancora insoluti.
Il film si apre con una citazione de Il cacciatore e richiama ovviamente le varie atmosfere di U-Boot96 e di tanti film sui sommergibili, nel corso della narrazione l’attenzione si sposta però velocemente sul lato umano della tragedia, sui suoi effetti nelle azioni e nella psiche dei marinai intrappolati e nella vita dei loro familiari. L’occhio del regista si focalizza sul dolore, sulla perdita, sui valori della famiglia, della fratellanza, del mutuo sostegno, sulla vita e sulla morte. Il sottomarino e l’incidente sono come uno specchio che riflettono il dolore umano del vivere sotto l’assillo del Tempo che passa e l’effetto di forza consolatoria che riesce ad avere la solidarietà.
Il risultato di tale impegno è un lavoro intenso, ben costruito, egregiamente realizzato, con un ritmo coinvolgente. La messa in scena è sobria, priva degli artifizi rutilanti delle produzioni hollywoodiane ed il cast è un cast tutto europeo. Fra i tanti spiccano il talentuoso attore danese Matthias Schoenaerts nei panni di un ufficiale di bordo, la francese Léa Saydoux in quelli della sua combattiva moglie e Colin Firth un alto ufficiale della Marina Britannica.
Ciò non di meno, Kursk è un lavoro riuscito solo in parte. Il film, nonostante tutto l’impegno, perde infatti mordente proprio quando esce dal dramma claustrofobico chiuso nelle pareti dello scafo inabissato e va a seguire il dramma parallelo delle famiglie a terra. L’alchimia non funziona, i due piani narrativi sembrano quasi due diversi film, due diverse mano.
Pur con questo difetto il lavoro di Vinterberg resta comunque accettabile perchè sostenuto dal suo innegabile mestiere di regista. Un film accettabile ma convenzionale che pur pieno di buoni propositi e buoni sentimenti non suscita nessuna empatia o reazione da parte dello spettatore. Proprio da Vinterberg ci saremmo aspettato molto di più.
data di pubblicazione:22/10/2018

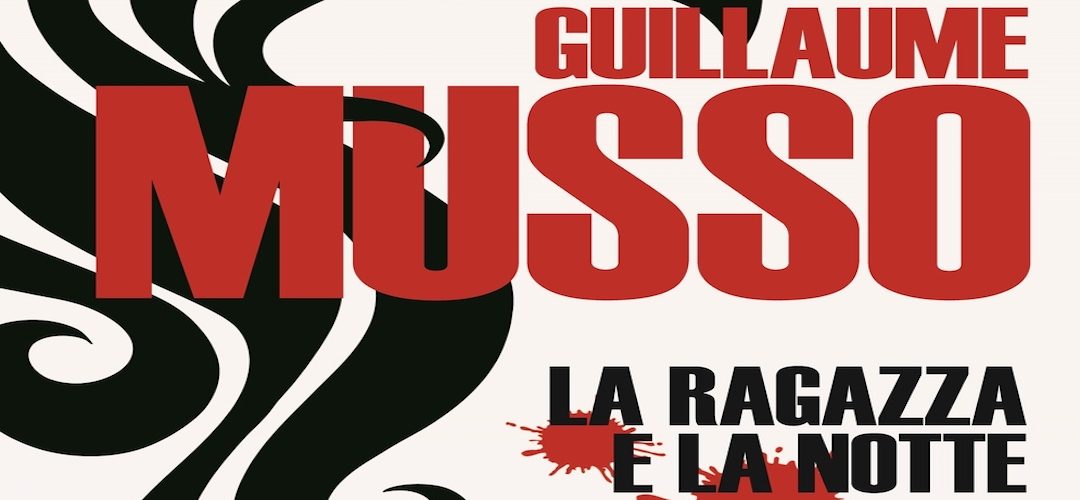
da Antonietta DelMastro | Ott 21, 2018
 È la prima volta che leggo Guillaume Musso e devo dire che il libro mi è veramente piaciuto, un bel noir, un cold case ricco di suspense con un intreccio che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina!
È la prima volta che leggo Guillaume Musso e devo dire che il libro mi è veramente piaciuto, un bel noir, un cold case ricco di suspense con un intreccio che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina!
La storia si svolge su due binari temporali diversi, la location è quella di Cap d’Antibes nel prestigioso ed elitario liceo Saint-Exupéry, la nostra voce narrante è quella di Thomas Degalais, ex studente del liceo ora romanziere di successo trasferitosi negli USA, innamorato di Vinca Rockwell la ragazza più affascinante del liceo “… mi sono spesso interrogato sulla natura dell’ascendente che Vinca esercitava su di me, sulla vertigine fascinosa e dolorosa che mi apriva dentro, e ho sempre pensato all’effetto di una droga.”. Insieme a lui, personaggi fondamentali per il romanzo, saranno Maxime e Fanny.
I tre ex studenti e ottimi amici dei tempi del liceo si sono completamente persi di vista appena finita la scuola, ognuno di loro ha percorso strade diverse e ora si ritrovano in occasione della festa per i 50 anni del Saint-Exupéry; ma a riportarli in Costa Azzurra non è stata la nostalgia per gli anni passati insieme ma i misteri che avvolgono la scomparsa, 25 anni prima, di Vinca Rockwell e del suo professore di filosofia, Alexis Clement, del quale tutti la ritenevano l’amante. I segreti che avvolgono queste sparizioni, che legano indissolubilmente i tre ex compagni di scuola, stanno per crollare come le pareti della loro vecchia palestra ed è questo il motivo che li ha riportati, dopo così tanto tempo, al Saint-Ex, questo e le minacce anonime che sono arrivate loro.
Benché tutta la storia si svolga in pochi chilometri quadrati insieme a Vinca, Thomas, Maxime e Fanny troviamo molti altri personaggi di cui Musso tratteggia magistralmente psicologia e sentimenti, le descrizioni “fisiche” di ognuno di loro sono tali da riuscire a “vederli” mentre si muovono all’interno della storia, le descrizioni degli incantevoli luoghi in cui si dipana la storia sono veramente mozzafiato “il percorso angusto ma lastricato, a picco sulle falesie. L’aria era pura e tonificante. Il mistral aveva spazzato via le nuvole e il cielo era disseminato di stelle. Dai bastioni della città vecchia alla baia di Nizza, passando per le montagne retrostanti, si godeva di una vista mozzafiato.”
Assolutamente da leggere.
data di pubblicazione:21/10/2018

da Maria Letizia Panerai | Ott 21, 2018
(FESTA DEL CINEMA DI ROMA – 13ma Edizione, 18/28 ottobre 2018)
Una romantica storia d’amore che diviene struggente perché conosce la tristezza della separazione e che, invece di spegnersi, si autoalimenta. E così l’amore diviene strumento per difendersi dalle ingiustizie e dal dolore, quell’amore che rende forti se viene instillato sin da bambini, come cura per affrontare le brutture del mondo.
Se la strada potesse parlare di James Baldwin è il romanzo da cui Barry Jenkins ha tratto ispirazione per il suo ultimo film, che riesce a mescolare, fedele al racconto, romanticismo e tristezza, melanconia e dolcezza, rabbia e dolore. “Beale Street è una strada di New Orleans, dove sono nati mio padre, Louis Armstrong e il jazz. Ogni afroamericano nato negli Stati Uniti è nato a Beale Street, è nato nel quartiere nero di qualche città americana, sia esso a Jackson, in Mississippi, o a New York. Beale Street è la nostra eredità. Questo romanzo parla dell’impossibilità e della possibilità, della necessità assoluta, per dare espressione a questo lascito…”
Siamo nel quartiere di Harlem a Manhattan negli anni ’70. Tish ha appena diciannove anni ed ama profondamente Alonzo, detto Fonny, che ne ha ventidue: i due sono cresciuti insieme e sono dunque inseparabili sin dalla tenera età e, seppur giovanissimi, il loro è un amore profondo. I genitori di lei ne sono perfettamente consapevoli, forse perché anche loro si amano ancora molto, mentre quelli di Fonny, in continuo litigio tra loro, non vedono di buon occhio la ragazza. Queste diverse vedute non impediscono alla coppia di progettare un futuro insieme e l’improvvisa gravidanza di Tish consolida quel legame già così stretto. Ma i loro romantici progetti di una felice vita in comune s’interrompono allorquando Fonny viene accusato di un reato che non ha commesso.
Il tema principale di questo film è l’amore, coniugato attraverso l’indissolubile legame di coppia, attraverso l’altrettanto indissolubile legame con la propria famiglia, attraverso le radicate amicizie del quartiere in cui si nasce e si diventa grandi, tramite un codice sacro non scritto che le famiglie afroamericane hanno, perché l’amore rende forti e pronti ad affrontare i colpi duri della vita, come i pregiudizi razziali ancora tanto radicati nella società americana e non solo.
E solo così, quando il più naturale dei progetti che un uomo e una donna possano avere nella propria vita naufraga in seguito ad un’ingiustizia, il sentimento che li unisce, se forte, può resistere anche alla più dura delle prove. Barry Jenkins, premio Oscar per il bellissimo Moonlight, è riuscito a trasferire sullo schermo la poesia dell’amore ma anche la sua forza che nasce dal contagio che si trasmette in famiglia, in una pellicola emotivamente avvolgente da non perdere.
data di pubblicazione:21/10/2018


da Antonio Iraci | Ott 21, 2018
(FESTA DEL CINEMA DI ROMA – 13ma Edizione, 18/28 ottobre 2018)
La polizia sta seguendo le tracce di Piero, sospettato principale per una rapina effettuata in una discoteca romana. Sua cugina Giulia, amante dei programmi polizieschi, convoca i suoi fidati amici per iniziare insieme un attento esame dei pochi indizi di cui dispone. Sarà proprio lei, detective per caso, a risolvere l’enigma e portare all’arresto del vero colpevole.
In questa tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma è veramente lodevole che gli organizzatori, o meglio i selezionatori delle pellicole, abbiamo trovato lo spazio per questo film dove, accanto ai nomi di alcuni attori professionisti, recitano per la prima volta giovani disabili. Il regista Giorgio Romano, qui al suo esordio, precisa che nel suo lavoro non si tratta affatto di disabilità e insieme a Daniela Alleruzzo, che ne ha curato il soggetto, ha deciso di portare sul grande schermo una commedia simpatica e divertente che, con la giusta dose di ironia, riesce a dare spazio alla diversità. Un esperimento sicuramente ben riuscito che rende concreti i sogni e le ambizioni di questi attori in erba, che hanno così avuto la possibilità di esibire la propria abilità recitativa.
I ragazzi, che hanno già calcato le scene a teatro, fanno parte dell’Associazione L’Arte nel cuore, un’Accademia dove vengono formati giovani diversamente abili per essere immessi nel circuito teatrale e cinematografico internazionale. In un programma così impegnativo, dove vengono ogni giorno presentati grandi film di importanti registi, fa bene respirare un’aria più leggera e frizzante che abbatta ogni barriera, che si frappone tra ciò che è considerato normale dal diverso, e offra spazio anche alla voce di chi ha talento, a prescindere dalla propria disabilità.
Il progetto, promosso dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE, pone lo spettatore a considerare i giovani attori come i veri protagonisti della scena perché l’essere diverso non significa essere automaticamente sbagliato o fuori posto ma sovente, per essere diverso, ci vuole molto coraggio.
data di pubblicazione:21/10/2018











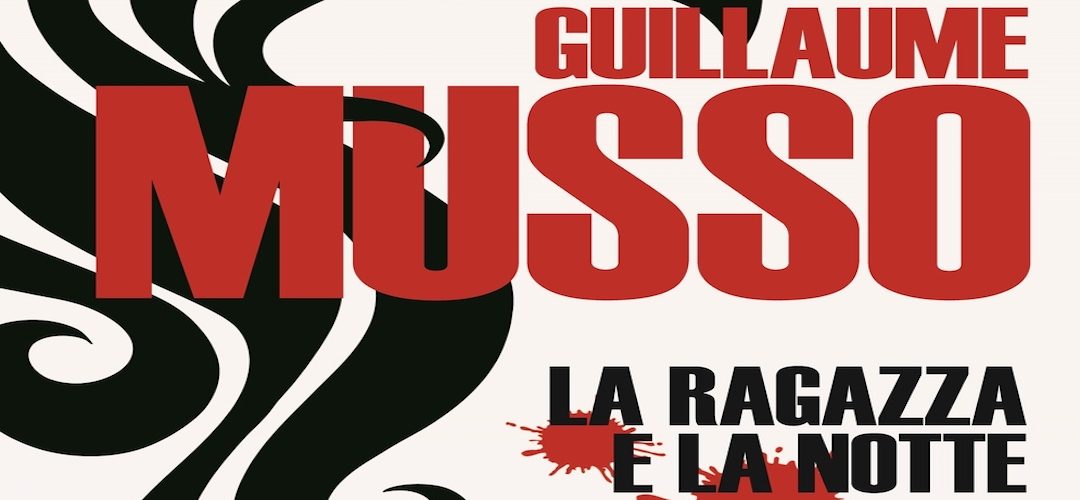








Gli ultimi commenti…