
da Rossano Giuppa | Gen 16, 2019
(Teatro Vascello – Roma, 14/16 gennaio 2019)
Mare Mater, la nave dei bambini è un racconto meraviglioso e straordinario, come solo le storie vere sanno essere. L’opera di Fabio Cocifoglia con Manuela Mandracchia, Luca Iervolino, Giampiero Schiano, insieme ai Ciprix, una compagnia di musical composta interamente da ragazzi, in scena al Teatro Vascello dal 14 al 16 gennaio 2019, è il frutto di un complesso lavoro di scrittura realizzato grazie all’importante contributo archivistico del Museo del Mare di Napoli.
E’ la storia della Nave-Asilo “Caracciolo”, una corvetta non più utilizzata, che tra il 1913 e il 1928 pose Napoli al centro dell’interesse pedagogico internazionale. Si stava portando avanti un esperimento educativo straordinario, pensato e voluto dalla signora Giulia Civita Franceschi e che aveva accolto a bordo della nave circa 750 bambini e ragazzi detti “i caracciolini”, provenienti soprattutto dai quartieri spagnoli e recuperati da una condizione di abbandono per insegnare loro i valori ed i mestieri del mare e garantirgli una prospettiva di vita decorosa. E il mare restituisce la dignità a questi ragazzi; non più figli di nessuno, non più esseri dimenticati e sbandati nella città di Napoli, ma finalmente futuri uomini e donne strappati alla miseria ed educati al lavoro e alla vita.
In scena, un’istitutrice (Manuela Mandracchia) ed il suo bagaglio di ricordi che riaffiorano assieme a due ex caracciolini ora uomini (Luca Iervolino e Giampiero Schiano) che identificano l’inquieta consapevolezza di un passato lontano ma anche il tormento per aver fatto il possibile ma forse non il massimo per non averli potuti salvare tutti.
Pezzo dopo pezzo in scena prendono vita i ricordi, l’esperienza umana e formativa in grado di restituire ai destinati all’oblio una rinnovata dignità umana. La sveglia, la colazione, la cura personale, la scuola, il pranzo, il riposo, le attività di pesca. La giornata, all’interno della nave scuola, viene ricordata nei minimi dettagli a comporre un puzzle perso nel tempo.
Ma l’apparizione del gerarca fascista incaricato di sollevare la signorina Giulia Civita Franceschini dal suo incarico, stroncherà ogni tentativo di consolazione lasciando la protagonista con la cupa sensazione che alla fine non si era fatto abbastanza.
Educatrice ma anche madre premurosa, Manuela Mandracchia domina la scena e ci conduce attraverso la propria coscienza seguendone il ritmo attraverso immagini vive e forti, ricordi la cui apparizione reca con sé, nello stesso tempo, gioia e dolore. Dolore di una perdita ed incapacità di abbandonarsi alla rassegnazione e, soprattutto, concedersi il perdono.
Un lavoro profondo e intenso condotto da Fabio Cocifoglia su una donna in bilico tra tenerezza e coraggio nell’affrontare scelte difficili per quel periodo storico. Un racconto che diventa poesia e che incanta.
data di pubblicazione:16/01/2019
Il nostro voto: 
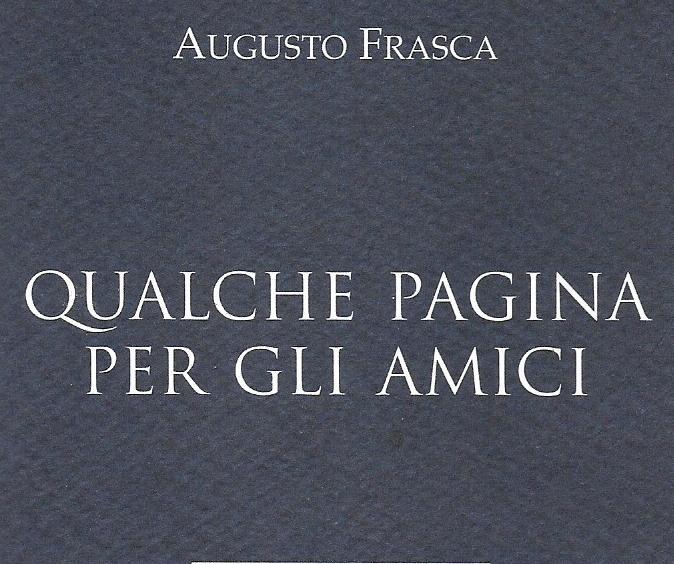
da Daniele Poto | Gen 15, 2019
 Un prezioso volumetto in edizione limitata che sin dal titolo pattuisce una sorta di profilo basso. Ci vuole coraggio per scegliere un’etichetta così vaga e generica. Ma l’obiezione formale (la cornice) è presto superata per il valore prezioso dei contenuti che distillano sessanta anni di esperienza del giornalista, del curatore di pubbliche relazioni, capace di documentare con lingua impeccabile la fitta trama di incontri importanti vissuti in prima persona, a volte in trincea, nel passato millennio. Frasca confessa che ha vissuto intensamente e regala ai suoi lettori perle di un’animata autobiografia personale e/o professionale. La maggior parte degli ambiti è sportiva ma non solo. Si svaria da Vittorio Pozzo a Gianni Agnelli, in un’ampia sintesi cronologica, passando per le due fondamentali esperienze formative dei mondiali di atletica del 1987 e dei mondiali di calcio del 1990. Sono medaglioni icastici con grande controllo di scrittura tra cui trapela il rispetto per i miti, l’ammirazione per personaggi che hanno fatto grande l’Italia e qualche idiosincrasia. Il senso critico porta Frasca a uscire dal coro degli indiscriminati ammiratori di Mennea. Un campione olimpico discusso come Schwazer è messo all’indice col riscontro di fatti obiettivi. Saggistica polifonica aperta al cinema, al teatro e alle arti alla luce dei mille interessi dell’autore. Un libro abbagliante che non lascia indifferenti e che apre con abile sintesi spiragli di approfondimento possibili per i tanti personaggi sbozzati alla luce di un incontro, di un’esperienza personale. Un testo difficilmente catalogabile ma di grande fascino. Gli amici potranno capirlo anche nel senso di una nostalgia comune per un’Italia che non c’è più. Una generazione potrà riconoscersi nei “migliori anni della nostra vita”. Oggi l’incanto sembra sparito: nella fretta, nel consumismo, nell’ansia di divorare gli attimi. Frasca prova a restituire senso e memoria al nostro passato indicando una possibile direzione per il futuro, in chiara controtendenza rispetto al mainstream. I libri come si sa, servono anche a questo. A disegnare nuovi percorsi e altre vite.
Un prezioso volumetto in edizione limitata che sin dal titolo pattuisce una sorta di profilo basso. Ci vuole coraggio per scegliere un’etichetta così vaga e generica. Ma l’obiezione formale (la cornice) è presto superata per il valore prezioso dei contenuti che distillano sessanta anni di esperienza del giornalista, del curatore di pubbliche relazioni, capace di documentare con lingua impeccabile la fitta trama di incontri importanti vissuti in prima persona, a volte in trincea, nel passato millennio. Frasca confessa che ha vissuto intensamente e regala ai suoi lettori perle di un’animata autobiografia personale e/o professionale. La maggior parte degli ambiti è sportiva ma non solo. Si svaria da Vittorio Pozzo a Gianni Agnelli, in un’ampia sintesi cronologica, passando per le due fondamentali esperienze formative dei mondiali di atletica del 1987 e dei mondiali di calcio del 1990. Sono medaglioni icastici con grande controllo di scrittura tra cui trapela il rispetto per i miti, l’ammirazione per personaggi che hanno fatto grande l’Italia e qualche idiosincrasia. Il senso critico porta Frasca a uscire dal coro degli indiscriminati ammiratori di Mennea. Un campione olimpico discusso come Schwazer è messo all’indice col riscontro di fatti obiettivi. Saggistica polifonica aperta al cinema, al teatro e alle arti alla luce dei mille interessi dell’autore. Un libro abbagliante che non lascia indifferenti e che apre con abile sintesi spiragli di approfondimento possibili per i tanti personaggi sbozzati alla luce di un incontro, di un’esperienza personale. Un testo difficilmente catalogabile ma di grande fascino. Gli amici potranno capirlo anche nel senso di una nostalgia comune per un’Italia che non c’è più. Una generazione potrà riconoscersi nei “migliori anni della nostra vita”. Oggi l’incanto sembra sparito: nella fretta, nel consumismo, nell’ansia di divorare gli attimi. Frasca prova a restituire senso e memoria al nostro passato indicando una possibile direzione per il futuro, in chiara controtendenza rispetto al mainstream. I libri come si sa, servono anche a questo. A disegnare nuovi percorsi e altre vite.
data di pubblicazione:15/01/2019

da Paolo Talone | Gen 14, 2019
Roma, giovedì 10 gennaio 2019
Torna dal 16 al 20 gennaio al teatro India, dopo essere stato presentato proprio qui a giugno dell’anno scorso in occasione del festival Roma Città Mondo, Famiglia scritto e diretto da Valentina Esposito per la compagnia Fort Apache Cinema Teatro, con Alessandro Bernardini, Christian Cavorso, Chiara Cavalieri, Matteo Cateni, Viola Centi, Alessandro Forcinelli, Gabriella Indolfi, Piero Piccinin, Giancarlo Porcacchia, Fabio Rizzuto, Edoardo Timmi, Cristina Vagnoli e con Marcello Fonte.
Per l’occasione abbiamo incontrato Chiara Cavalieri, una degli interpreti del lavoro, e abbiamo chiesto a lei qualche cosa sullo spettacolo, rubandole qualche minuto prima delle prove.
Iniziamo dalla compagnia: Fort Apache Cinema Teatro.
La compagnia Fort Apache nasce nel 2014 per volontà della regista, Valentina Esposito, che più di dieci anni fa aveva iniziato un percorso di teatro all’interno del Carcere di Roma Rebibbia N.C.. Il suo desiderio fu poi quello di continuare a lavorare con gli ex detenuti fuori dal carcere, inserendoli in un vero e proprio meccanismo lavorativo all’interno del mondo dello spettacolo tramite collaborazioni tra Fort Apache e agenzie di spettacolo, casting e registi. Questa è la conferma di come il teatro possa essere un sistema di reinserimento sociale e professionale. La compagnia è formata quindi da tutti attori professionisti, detenuti in misura alternativa, ex detenuti e non. Il laboratorio inoltre collabora in maniera attiva con l’Università La Sapienza di Roma.
Nella tua carriera hai fatto chiaramente tanti tipi di spettacoli dal teatro classico al contemporaneo, ma hai lavorato anche con migranti, richiedenti asilo, con persone disabili. In questo caso come sei entrata a far parte della compagnia?
Ci sono capitata un po’ per caso, anche se sono convinta che le esperienze non capitano a caso nella vita. Col tempo ho imparato che se ti arriva un’esperienza o un personaggio in un dato momento è perché ti deve arrivare. Quando mi è arrivata la proposta di questo progetto mi sono subito entusiasmata e ora mi ci ritrovo dentro in pieno. Famiglia è il nome dello spettacolo e “famiglia” a tutti gli effetti è diventata questa compagnia per me. D’altronde si lavora insieme e si cresce insieme grazie al lavoro di Valentina che come regista ci da tanto campo libero per la ricerca emotiva del personaggio e dei rapporti che li legano agli altri. È un lavoro di condivisione, e questa è una cosa preziosa. È la prima volta che partecipo a un progetto con ex detenuti e sia umanamente che artisticamente continuo a crescere.
Possiamo chiamarlo teatro sociale?
Possiamo chiamarlo come vuoi… ma il teatro è teatro! Qualsiasi aggettivo ci si metta dopo. Il termine “sociale” nell’accezione più formale è quando il fare teatro viene attuato con un obiettivo “educativo”. In questo caso possiamo chiamarlo sociale perché parte da un gruppo di persone che hanno affrontato esperienze di detenzione. Proprio ieri sentivo un’intervista di Valentina Esposito circa la tematica teatro e carcere e sono rimasta affascinata da questa cosa: il teatro nelle carceri fa diminuire in maniera drastica la recidiva dal 65% al 6% tra coloro che partecipano all’attività artistica e questo è un dato straordinario.
Per questo lo spettacolo viene proposto anche ai ragazzi delle scuole superiori. Nonostante affronti tematiche forti la risposta dei ragazzi è sorprendente, sono attenti e si emozionano. La risposta positiva dei ragazzi si vede anche dai messaggi e dalle richieste di amicizia che ci arrivano sui social dopo lo spettacolo, segno che ciò che volevamo dire è stato da loro recepito.
Andiamo allo spettacolo. Di cosa parla Famiglia?
Parla di rapporti familiari esplorando tutte le sfaccettature tra padre e madre, madre e figlio, fratelli, il conflitto generazionale padre-figlio soprattutto, sulle colpe dei padri che si ripercuotono sui figli e sui figli dei figli. L’occasione per far incontrare tutti è un matrimonio, al quale partecipano anche coloro che sono morti, perché anche loro continuano a essere presenti nella vita familiare. Anzi, forse sono proprio quelli che comandano sulle azioni dei vivi.
Si parla quindi di un concetto universale come la famiglia e quindi non ci si può non riconoscere almeno un po’. E se ne parla alternando momenti di leggerezza e ilarità, momenti di confronto acceso tra i vari personaggi e momenti di assoluta intimità.
Il tuo ruolo?
Io interpreto Filomena, una donna del sud sopraffatta dal contesto sociale e patriarcale che era tipico del secolo scorso (il personaggio appartiene al passato, si parla di almeno di 3 generazioni fa) e che insieme alle altre donne presenti in scena tenta di ricucire ciò che è stato disgregato. Non voglio svelare oltre altrimenti come si dice nel gergo moderno “spoilero” troppo.
Nella compagnia anche Marcello Fonte, premio EFA e Palma d’oro a Cannes 2018 come miglior attore per Dogman di Matteo Garrone. Sarà un vero piacere vederlo in scena con la compagnia con la quale ha sempre lavorato fin da quando si è formata.
Come dice Chiara, che salutiamo e ringraziamo, serve il teatro per tornare a riflettere. Sedersi a teatro e uscire con qualcosa che ti tocca nel profondo è una possibilità che, considerando che tutti siamo vittime della fretta, dell’indifferenza e dell’eccessiva tecnologia, raramente ci è data.

da Daniele Poto | Gen 14, 2019
(Teatro di Carbognano, 13 gennaio 2019; Teatro Sette – Roma, 15 gennaio/10 febbraio 2019)
La saga della Stremate colpisce ancora. Una nemesi che si ripercuote sui loro destini trent’anni dopo. Un piccolo giallo di famiglia.
Prima nazionale in Tuscia, verso dell’approdo nel piccolo feudo teatrale capitolino di Michele La Ginestra nell’occasione co-regista dell’operazione. Questa volta la saga delle Stremate arriva alla tapa conclusiva. Perché il trio è confinato in una casa di riposo da cui sembra destinato a non uscirne più. I nodi delle puntate precedenti si sciolgono in un giallo di famiglia forse un po’ macchinoso per chi non è al corrente degli sviluppi delle precedenti puntate. Ma più del risultato finale contano le tappe intermedie di una scoppiettante machina di comicità. Un teatro leggero che assolve però piacevolmente e senza volgarità il proprio compito: l’intrattenimento. La maggiore età porta a vuoti di memoria, a fenomeni di sordità. I difetti abbondano nelle simpatiche vecchiette con ampie storie alle spalle. Pastiche per sole donne che godono di una formidabile sinergia interpretativa in una macchina oleata a dovere. L’interazione dei dialoghi è praticamente perfetta e qualche movimento di scena, relativa alla scarsa mobilità del trio anziano, vivacizza l’andamento. In provincia lo spettacolo funziona a dovere con la collaborazione di un pubblico che quasi anticipa le battute e i tic delle invecchiate ragazze in scena. Il dispiacere è per il capolinea della vicenda ma non si può escludere un ultimo guizzo di classe considerando le capacità di recupero affabulativo del collettivo muliebre. Sinceri applausi a scena aperta con Federica Cifola che piazza le battute più mordaci. Come anticipato meno ci interessa lo scioglimento che appare piano e un po’ frettoloso in capo a ottanta minuti di felice esibizione. Non era sicuramente il giallo e la ricerca del colpevole il focus dell’operazione teatrale.
data di pubblicazione:14/01/2019
Il nostro voto: 

da Maria Letizia Panerai | Gen 14, 2019
 Big Night è un film del 1996 co-diretto da Campbell Scott e Stanley Tucci, che ne ha curato anche la sceneggiatura assieme a Joseph Troiano, e narra delle vicende di due fratelli italiani di origini abruzzesi, Primo (Tony Shalhoub) e Secondo (Stanley Tucci) Pilaggi, emigrati come ristoratori sulla costa del New Jersey. I due hanno profonde diversità di vedute nella gestione del loro ristorante: Primo (il maggiore) è uno chef caparbiamente legato alla tradizione della cucina italiana e non vuole saperne di accettare compromessi, mentre Secondo cerca di accontentare i gusti della sparuta clientela che frequenta ancora il loro locale seppur con un’idea distorta di quella che è la tradizione culinaria italiana. Sull’orlo del fallimento per i loro disaccordi, i Pilaggi subiscono anche la concorrenza spietata di Pascal, un altro emigrato titolare di un ristorante italiano di grido sempre pieno, dove però la cucina tricolore viene reinventata secondo degli stereotipi, molto americani, che fanno inorridire Primo. Pascal, pur stimando Primo come chef, rifiuta a Secondo un prestito che potrebbe risollevare le loro sorti, ricorrendo anche ad un inganno per dare la spallata finale all’attività dei due fratelli: li convince ad organizzare una sontuosa cena alla quale invitare il famoso cantante italoamericano Luis Prime, costringendoli a dare fondo alle loro ultime risorse economiche per un banchetto degno del personaggio la cui presenza, da un punto di vista pubblicitario, avrebbe finalmente risollevato la loro attività di ristorazione.
Big Night è un film del 1996 co-diretto da Campbell Scott e Stanley Tucci, che ne ha curato anche la sceneggiatura assieme a Joseph Troiano, e narra delle vicende di due fratelli italiani di origini abruzzesi, Primo (Tony Shalhoub) e Secondo (Stanley Tucci) Pilaggi, emigrati come ristoratori sulla costa del New Jersey. I due hanno profonde diversità di vedute nella gestione del loro ristorante: Primo (il maggiore) è uno chef caparbiamente legato alla tradizione della cucina italiana e non vuole saperne di accettare compromessi, mentre Secondo cerca di accontentare i gusti della sparuta clientela che frequenta ancora il loro locale seppur con un’idea distorta di quella che è la tradizione culinaria italiana. Sull’orlo del fallimento per i loro disaccordi, i Pilaggi subiscono anche la concorrenza spietata di Pascal, un altro emigrato titolare di un ristorante italiano di grido sempre pieno, dove però la cucina tricolore viene reinventata secondo degli stereotipi, molto americani, che fanno inorridire Primo. Pascal, pur stimando Primo come chef, rifiuta a Secondo un prestito che potrebbe risollevare le loro sorti, ricorrendo anche ad un inganno per dare la spallata finale all’attività dei due fratelli: li convince ad organizzare una sontuosa cena alla quale invitare il famoso cantante italoamericano Luis Prime, costringendoli a dare fondo alle loro ultime risorse economiche per un banchetto degno del personaggio la cui presenza, da un punto di vista pubblicitario, avrebbe finalmente risollevato la loro attività di ristorazione.
Di Big Night, gustosa commedia amara a sfondo gastronomico ambientata negli anni Cinquanta, si apprezza come scena migliore proprio la cronaca della cena e della sua preparazione. Il piatto forte della cena, decisiva per il rilancio del ristorante dei fratelli Pilaggi, è rappresentato dal timballo di ziti di cui, nel film, ne vengono enfatizzate le difficoltà di esecuzione. Piatto unico della cucina centro-meridionale, il timballo si cuoce in uno stampo a forma di campana rovesciata e pare che il suo nome derivi proprio da questo tipo di recipiente di cottura che assomiglia ad un ”tamburo”: da qui “timballo”. Diverso negli ingredienti, il timballo è un piatto molto ricco ed in uso nelle feste e nelle grandi occasioni, tipico non solo della cucina abruzzese ma anche campana e siciliana, i cui ingredienti sono i più disparati: dalla pasta al riso, alla carne sia in forma di ragù che in polpettine, le uova sode, scamorza o mozzarella, salumi, affettati o anche verdure, il più delle volte fritte. Deve essere preparato per tempo e calma, aggiungendo via via gli ingredienti che spesso sono cotti separatamente e poi assemblati: una volta cotto, deve “riposare” per compattarsi bene.
Eccovi la ricetta di mia nonna Romilda, abruzzese doc, del suo timballo di ziti con polpettine, che ricorda moltissimo il timballo dei fratelli Pilaggi.
INGREDIENTI: ½ kg di ziti da spezzare a mano – 6 etti di macinato di vitella – 3 scamorze appassite non molto asciutte – 2 etti di parmigiano grattugiato – passata di pomodoro – 4 uova – olio extravergine d’oliva q.b. –– sale e pepe q.b.- pangrattato q.b. – noce moscata q.b. – 3 uova sode facoltative.
PROCEDIMENTO:
Usare metà del macinato di vitella per fare un sugo con pomodoro e basilico, non troppo ristretto. L’altra metà del macinato servirà per fare, con un po’ di pazienza, delle polpettine aggiungendo semplicemente sale, pepe e una grattatina di noce moscata e soffriggendole a fuoco lento in olio extravergine d’oliva, facendo prima riscaldare appena l’olio e buttandocele dentro.Spezzare le zite a mano in modo irregolare e lessarle con poco sale e molto molto al dente; in una grande ciotola sbattere le uova con un po’ di sale, versarci gli ziti appena scolati e mescolare (rigorosamente con le mani) sino a quando le uova si saranno amalgamate con gli ziti. Quindi, ungere bene una teglia tonda con i bordi molto alti (possibilmente di rame fuori ed alluminio nell’interno) con burro o olio, aiutandosi sempre con le mani, e facendoci poi aderire bene del pangrattato; a questo punto cominciare a fare gli strati ma non più di tre: sugo-parmigiano-pasta-polpettine-parmigiano-scamorza tagliata a dadini-pasta-sugo e così via. Terminati i tre starti di pasta completi di tutti gli ingredienti, ai quali si possono aggiungere facoltative delle uova sode a pezzetti, e facendo in modo di terminare con il sugo su cui mettere parmigiano e scamorza a dadini e polpettine, mettere in forno preriscaldato a 180° fissi per 30/40 minuti; passato il tempo, vedere se sopra il timballo si è creata la crosticina, in caso contrario accendere per 5 minuti il grill.
Tirare fuori dal forno il timballo e farlo riposare per almeno 20/30 minuti, coperto con un canovaccio di lino: l’attesa garantirà che si compatti bene permettendo così di tagliare le porzioni facendo prima un cerchio nella parte centrale, in caso si usi il tegame tondo come da tradizione. Si mangia tiepido, per gustarne tutti i profumi. Emozionante!

da Daniele Poto | Gen 12, 2019
(Teatro della Cometa – Roma, 8/20 gennaio 2019)
Una rivisitazione gogoliana in salsa romanesca. Un monologo multi voci che sarebbe piaciuto a Luigi Magni, omogeneo all’atmosfera dei Papa.
Ci stupisce Francesco Acquaroli che il grande pubblico ha conosciuto per le grandi caratterizzate parti di cattivo in Suburra e in Rocco Schiavone. Non è Samurai e non è Samuele a teatro dove riacquista i panni del protagonista assoluto in una prova d’attore lunga sessanta minuti, con ampio uso del romanesco ottocentesco. Mutuando Gogol e la perdita di un naso che sembra equivalere a una penosa perdita dell’identità per il protagonista che una mattina si risveglia senza naso e vaga per la città alla ricerca di questo fondamentale sporgente attributo che è anche un modo per farsi riconoscere ed accettare in società. E’ un innesco kafkiano che permette all’attore di mutuare tante voci, persino quelle femminili, Il tema affronta il pregiudizio sociale sulla presunta anormalità. L’uomo senza naso si dibatte in una Roma popolaresca, dominata dalla curia e dalla voglia di sopravvivenza, una jungla dove la sua ricerca si fa quasi disperata. Perché il naso trovato inizialmente non calza e dunque il volto non è più quello di prima. E un uomo senza naso che uomo è? Grande è il suo sollievo quando dopo la discesa agli inferi riacquista questo pezzo fondamentale che è vita, olfatto, riconoscimento sociale. L’alter ego del Kovalev gogoliano ci fa scoprire la Roma sparita, il porto di Ripetta, Trastevere d’antan e si avvale del prezioso sottofondo sonoro e creativo delle musiche originali di Pino Cangialosi, suonate dagli altri componenti della famiglia, cioè Flavio Cangialosi e Livia Cangialosi mentre Alessia Sambrini ha molte parti in commedia occupandosi di scene, costumi, disegno, luci e aiuto regia. Uno spettacolo gradevole nei limiti spettacolari del piano A di partenza. Un monologo dai colori cangianti in cui Acquaroli non straripa ma spazia su vari registri tutti molto coerenti e omogenei.
data di pubblicazione:12/01/2019
Il nostro voto: 

da Paolo Talone | Gen 11, 2019
(Teatro Argentina – Roma, 8/20 gennaio 2019)
Torna in scena Don Giovanni, archetipo del seduttore in continua ricerca del piacere, emblema del libertino che pagherà duramente i suoi capricci. Panni nuovi nell’allestimento di Valerio Binasco eppure fedeli al grande classico.
Una regia innovativa, moderna, priva di qualsiasi elemento che riconduca la memoria a un’immagine codificata, il Don Giovanni di Binasco si presenta in una veste depauperata di tutti gli orpelli che la tradizione teatrale, cinematografica e musicale ha messo addosso al personaggio nel corso del tempo. Un testo studiato, inghiottito e digerito in ogni sua singola parte, restituito sulla scena in maniera arricchita, dignitosa e rispettosa. Insieme ai costumi, che in questa edizione rimandano a una moda contemporanea attraverso l’occhio di Sandra Cardini, si rinnova anche il testo, allungato con veloci battute, come baffi colorati, che vanno ad aggiungere nuovi lazzi e sarcastici siparietti a una commedia già di per sé maliziosamente provocatoria. Della scena seicentesca rimane solo un pallido, sbiadito, scrostato indizio nelle scenografie ideate da Guido Fiorato, nulla di più di una parete fornita di stucchi e pannelli che si aprono, a volte, per far allungare lo sguardo all’esterno verso un mondo oscuro e minaccioso. Spariscono i giochi affascinanti delle macchine che trasportano spiriti e delle botole che inghiottono personaggi, le statue perdono la parola e il fantastico lascia il posto a visioni intime, tradotte sul volto degli attori e a noi lasciate solo intuire. I piani si mescolano in questo spettacolo, si confondono, l’immanente dialoga sfrontato con il trascendente, lo spazio del sacro si confonde nel profano, l’umano si innalza superbamente a sfidare il divino, del quale si sono perse tra l’altro le tracce, tutto è alla portata della nostra esperienza. Anche la gigante luna sullo sfondo, con la sua luce pallida e bugiarda, si presenta in palcoscenico, personaggio tra i personaggi, a significare il collasso di un cielo che non ha più motivo di essere chiamato tale. La morale si fa debole, la religione non è più l’alto baluardo da difendere, tutto finisce a terra dopo una vorticosa carambola, come gli inconcludenti ragionamenti di Sganarello (un ottimo Sergio Romano), oppure vanno in fumo, come la sigaretta che si accende Donna Elvira (Giordana Faggiano) che smette così di essere riferimento di lealtà e fedeltà. Don Giovanni sembra essere in questa edizione ancora più spietato, dissacrante, bambinesco, empio, irriverente, dissimulatore, incostante, ipocrita di quanto già non lo sia nella pièce di Molière, e Gianluca Gobbi, di straordinaria bravura perfetto in questo ruolo anche per la sua importante presenza fisica e la sua potente voce, ce lo restituisce in pieno, con un carico notevole di energia diabolica e sarcastica. Sul finale rallenta leggermente il ritmo, forse per la mancanza delle macchine previste per lo stupore degli spettatori, ma l’allestimento rimane comunque di grandissimo livello.
data di pubblicazione:11/01/2019
Il nostro voto: 

da Giovanni M. Ripoli | Gen 5, 2019
Da semplice operaio del settore elettrico ad Amministratore Delegato della potente Halliburton, a Vice presidente degli USA con ampie deleghe. Il film ripercorre la straordinaria carriera di un uomo senza grandi scrupoli come Dick Cheney, nell’ombra, vero artefice della politica americana sotto la presidenza di G.W. Bush.
Già apprezzato regista della Grande Scommessa, sapida commedia nera arricchita dalle interpretazioni di Christian Bale e Amy Adams, Adam Mc Kay, cinquantenne regista e sceneggiatore di Philalphia, si ripete affrontando un tema più impegnativo, la biografia di un discusso artefice, sotto traccia, della politica americana, Dick Cheney. Ancora una volta, lo fa alla sua maniera: la satira spinta e una regia spiazzante e variegata nel ritmo e nelle invenzioni. Ancora una volta, utilizzando i suoi attori feticcio, uno straordinario e camaleontico Bale (Cheney in tutte le età e in tutte le stazze) e una perfetta Amy Adams (Lynne, l’affidabile e ambiziosa compagna di una vita), affiancandogli altri grandi interpreti, tutti candidabili agli Oscar, quali Steve Carell (nel ruolo di Donald Rumsfeld) e Sam Rockwell (uno stralunato G.W. Bush). La pellicola segue il percorso di Cheney dall’arresto per guida in stato di ubriachezza, agli stimoli a cambiar vita offertigli dalla ancor giovane e ambiziosa fidanzata, ai primi timidi contatti con la politica nel partito repubblicano (sarà il fedele portaborse di Donald Rumsfeld) alla costante ascesa nell’olimpo della vita politica ed economica ai tempi del modesto e impacciato G.W. Bush.
Seppure con qualche momento di stanca, forse acuito dalla voce del narratore che vorrebbe rappresentare l’americano medio (destinato, fra l’altro ad un finale che non rivelo…), il film è qualcosa di totalmente differente da altri analoghi biopice, nella sostanza, l’occasione per una rappresentazione, forse crudele e impietosa, ma certamente realistica di un ‘America dove non ci sono nobili ideali (emblematica la clamorosa risata di Rumsfeld in risposta alla domanda del giovane Cheney: “ma noi in che cosa crediamo?”) ma solo mezzi anche perversi per raggiungere il potere e il denaro ad ogni costo.
Ecco allora che il film se da un lato è “solo”la storia del più giovane capo gabinetto della Casa Bianca (durante l’amministrazione Ford), ex giovane sbandato, “salvato” da Lynne Ann Vincent e assurto a cariche sempre più prestigiose e remunerate, dall’altro è un percorso della vita americana politica e non che ripercorre eventi che hanno coinvolto il mondo intero con conseguenze spesso catastrofiche. Ribadisco, tuttavia, che il tono della narrazione è lieve e disinvolto, spesso arricchito di momenti anche divertenti, anche se le didascalie che accompagnano i titoli, ci riportano alla triste storia degli ultimi anni. Ci ricordano, ad esempio, l’invasione dell’Iraq costruita al tavolino su prove inesistenti che costò la morte ad oltre 30 mila soldati americani e a quasi 600 mila civili iracheni… Verrebbe da esclamare col cinismo di Cheney: È l’America bellezza!
La pellicola di Mc Kay, dunque, è molto densa: anche grazie ai grandi interpreti, tutti da Oscar nelle varie categorie, il risultato è un film, raffinato, un tantino verboso, ma che fa pensare e non lascia indifferenti.
data di pubblicazione: 5/1/2019
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Jacolina | Gen 3, 2019
“Dio è natura, e la natura è bellezza” in queste parole pronunciate da Van Gogh (Willem Dafoe) è riassunto tutto il significato e la vera chiave di lettura con cui il cinquantenne e talentuoso regista americano Julian Schnabel ha inteso rappresentare il rapporto con la natura del pittore olandese negli ultimi tormentati ma anche fruttuosi anni della sua vita. Anni spesi tutti fra le campagne di Arles nel sud della Francia, alla ricerca ossessiva della giusta luce e del giusto sole per i suoi paesaggi, fra gli incontri scontri con Gaugin e fra continui ricoveri e dimissioni dal nosocomio di Saint Remy.
Schnabel si è affermato giovanissimo con un film su un altro pittore maledetto, Basquiat nel 1998, ha poi vinto ai festival di Venezia e di Cannes fino all’Oscar come migliore regista nel 2008 con il suo Lo scafandro e la farfalla. Appassionato ed apprezzato pittore oltre che regista, l’autore ci racconta, con cognizione di causa e dichiarata empatia, tutte le difficoltà dell’essere pittore, del dipingere la Natura, la ricerca dell’attimo di follia sottostante l’esplodere della scintilla creativa/artistica. Come da sua dichiarazione resa durante l’ultimo Festival del Cinema di Venezia, il suo intento era proprio di centrare il suo racconto sul “significato e sul tormento dell’essere artista”. Il film può quindi essere tutto qui, non siamo però davanti ad un classico biopic, anzi siamo ben lontani, forse anche per qualità, da quelli che lo hanno preceduto: Brama di vincere del 1956 di V. Minnelli, con un indimenticabile K. Douglas, e dal più recente Vincent e Theo del 1998 di R. Altman, e poi ovviamente, lontanissimi dalle tante produzioni più o meno divulgative od artistiche sul pittore olandese che unitamente al nostro Caravaggio, per drammaticità delle loro vite, per l’eccezionalità della loro Arte e per l’amore degli appassionati, condivide il record di essere al centro di innumerevoli documentari o fiction in tutto il mondo.
È quindi proprio e solo sulla vicenda dell’essere artista di Van Gogh che si sofferma il regista cercando di renderci con passione e partecipazione gli aneliti della sua anima, la sua sensibilità, l’affannosa ricerca creativa, la complessità ed il tormento della sua fragile personalità. Schnabel si fa però prendere proprio da questa sua passione, da questa sua empatia, tenta di trasmetterci quanto prova l’artista, ed ecco allora che la macchina da presa viene volutamente usata quasi come un pennello, come a voler restituire allo spettatore la follia visionaria del pittore. Abbondano quindi primi piani prolungati, ci sono inquadrature sfuocate, dissolvenze, camera a mano che accompagna l’artista nel suo camminare, quasi pellegrino, fra le campagne ed i boschi alla ricerca dell’attimo e dell’apparizione del Paesaggio, dell’Infinito e dell’Eternità. Ne risulta così, a tratti, quasi danneggiata anche l’intensa e vibrante interpretazione di Dafoe, supportato da un pregevole cameo di una splendida Emmanuelle Seigner. Purtroppo questo eccesso di mentalismo e le contraddizioni di cui sopra rallentano ed appesantiscono il giusto ritmo del film ed incidono fin troppo sul modo di raccontare, riducendo brio ed incisività. Dunque, uno Schnabel sempre autoriale e buono, ma molto lontano dalle eccellenze cui ci eravamo un po’ abituati.
data di pubblicazione:03/01/2019
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 3, 2019
Dopo essere stato presentato in concorso nell’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, finalmente è stato distribuito nelle sale l’attesissimo lavoro di Luca Guadagnino, tratto dall’omonimo film di Dario Argento: più che un remake, Suspiria, a detta dello stesso regista, è un doveroso omaggio a un autore che lo aveva letteralmente impressionato quando, appena adolescente, aveva avuto l’opportunità di vedere al cinema quello che sarebbe divenuto a breve un cult a livello internazionale. Una sfida non facile: trarre ispirazione da un soggetto così conosciuto dai cinefili di tutto il mondo è già di per sé un rischio, soprattutto per il genere horror.
Il film di Guadagnino segue le orme indelebili tracciate da Dario Argento in una rivisitazione dove, al di là delle linee fondamentali del plot originario, il regista inserisce del suo dandone una personale lettura in chiave più metafisica, in cui sono coinvolte donne e solo donne, che coesistono nella prestigiosa scuola di danza Markos Tanz ubicata nella Berlino ancora divisa dal muro. Il film è ambientato nel 1977, proprio nell’anno in cui Argento presentò il suo film, in una Germania scossa dai violenti attacchi terroristici della Raf, gruppo terroristico di matrice marxista-leninista chiamata anche banda Baader-Meinhof dal nome dei suoi fondatori, che il regista ha voluto porre come sfondo all’azione misteriosa che si svolge all’interno dell’Accademia. Fondamentale la figura della coreografa Madame Blanc, una magnetica ed eterea Tilda Swinton alla sua ennesima collaborazione con il regista, in una evocazione della grande Pina Bausch, la cui scuola ha decisamente rivoluzionato il concetto di danza contemporanea, ed intorno alla quale gravita l’apprensione emotiva che accompagna l’intero film. Il tema centrale è quello della stregoneria e della magia nera che ci riporta ad alcune riflessioni sul concetto dell’illusione e dell’ultraterreno, con uno sguardo particolare alla funzione delle donne, tema che sin dai primi fotogrammi è sintetizzato in una frase contenuta in un quadro “Una madre è una donna che può sostituire tutti ma non può essere sostituita”, e che si riallaccia al concetto di Mother nella trilogia di Argento.
Un mix quindi tra horror e stregoneria con uno sguardo anche alla psicoanalisi dal momento che tra i personaggi spicca la figura del dottor Klemperer interpretato da Lutz Ebersdorf, storico psicoanalista degli anni sessanta attivo anche nel teatro sperimentale di quegli anni.
Comunque il film rimane sicuramente una concreta testimonianza dell’universo femminile e dei suoi misteri, tema che come dichiarato dallo stesso regista in conferenza stampa a Venezia, trova ispirazione nella cinematografia del grande regista e drammaturgo Rainer Werner Fassbinder, uno dei maggiori esponenti del cinema tedesco moderno.
Suspiria si può considerare un esperimento realmente riuscito solo se non lo si vede come un fedele remake del capolavoro di Dario Argento: Guadagnino ha voluto seguire un suo stile personale cercando di affrontare per la prima volta il genere horror, con un taglio diverso e scevro da qualsiasi condizionamento. Nonostante l’eccessiva durata, il film non annoia grazie anche alla ricercatezza della fotografia e degli effetti speciali che lasciano lo spettatore con il fiato sospeso, coinvolgendolo in terrificanti tensioni emozionali. Bravissime le giovani interpreti, tra cui va menzionata Dakota Johnson nella parte della protagonista Susie Bannion, attrice oramai di fama internazionale dopo che nel 2015 ha vestito i panni di Anastasia Steele in Cinquanta sfumature di grigio di Sam Taylor-Johnson.
data di pubblicazione:03/01/2019
Scopri con un click il nostro voto: 



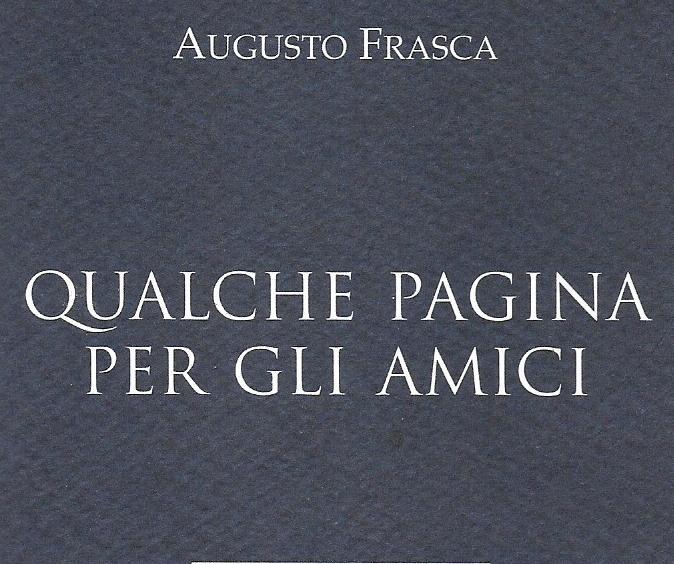

















Gli ultimi commenti…