
da Antonio Iraci | Gen 28, 2016
(Teatro dell’Orologio – Roma, 19 gennaio/14 febbraio 2016)
Quattro fratelli sono riuniti in casa della madre per prepararle una sorpresa in occasione del suo compleanno. Paolo, organizzatore dell’incontro, è ricercatore in un centro sperimentale ed espone in questa occasione una teoria non ancora testata secondo la quale sarà possibile riplasmare il corpo di un defunto, anche dopo diversi anni dalla sua morte, semplicemente utilizzando micro particelle subatomiche rimaste nei luoghi più frequentati in vita: sia pur per un’ora potrebbero riabbracciare il padre, già morto da alcuni anni, per poi salutarlo definitivamente.
Se ci dovessimo di nuovo interrogare sulla morte che ne verrebbe fuori, visto che da millenni generazioni di filosofi hanno elaborato disquisizioni senza mai arrivare ad una definizione certa?
Ma la morte è veramente la fine della vita o la vita è la fine della morte?
Filippo Gili completa così il suo percorso metafisico chiudendo la Trilogia di Mezzanotte, per la regia di Francesco Frangipane: partendo da una realtà concreta, va oltre il conosciuto per indagare un mondo ancora tutto da scoprire non avendo gli strumenti necessari per decifrarlo.
Il redivivo, l’uomo che nella narrazione grazie al buon esito dell’esperimento torna in vita in seno alla famiglia, si sente all’inizio disorientato, non riconosce lo spazio né il tempo, due categorie fittizie che noi utilizziamo, e si ritiene quindi quasi fuori posto tra i suoi affetti perché ingabbiato in un corpo che non gli appartiene più, in un tempo che scorre, sia pur a ritroso, e che scandisce un ritmo a lui ora completamente estraneo. Se è pur vero che riabbracciare dopo anni la sua famiglia lo renda felice, nel contempo però ne percepisce la paura e lo sgomento, perché per una sola ora è tornato in vita per poi rientrare in una dimensione in cui l’attimo dura un’eternità.
Ottime le prove degli attori in scena, essenziale l’allestimento a cura di Francesco Ghisu e soprattutto ben riuscito il gioco delle luci di Giuseppe Filipponio che, in una alternanza di chiari e scuri, fa piombare a volte gli spettatori, per un tempo indeterminato, in una totale assenza di luce quasi a voler significare che al di là del tunnel non ci sarà il chiarore ma il buio assoluto della nostra ignoranza.
data di pubblicazione:28/01/2016
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 28, 2016
Mamma Roma (Anna Magnani) è una prostituta che grazie alla sua determinazione, approfittando di alcune circostanze a lei favorevoli, riesce a liberarsi dal giogo imposto dal suo protettore (Franco Citti) e a ricostruirsi una vita più rispettabile vendendo verdura in un mercatino rionale di Roma.
Il figlio Ettore (Ettore Garofalo) passa il tempo insieme ad altri borgatari ad organizzare piccoli furtarelli e si invaghisce di Bruna (Silvana Corsini), ragazza più grande di lui e anche lei avviata al meretricio.
A questo punto, pur di distogliere il figlio dalla ragazza, Mamma Roma interviene decisa ed organizza tutta una messa in scena nei confronti di un ristoratore di Trastevere al fine, poi, di costringerlo a procurare al ragazzo un lavoro come cameriere ed allontanarlo così dalle amicizie poco raccomandabili di cui si circondava.
Quando tutto sembra aver raggiunto il giusto verso ricompare il vecchio protettore che costringe Mamma Roma di nuovo a prostituirsi di notte, all’insaputa del figlio, facendo ripiombare la donna in una stato di grande prostrazione, proprio mentre sembrava essere uscita dal tunnel della mala vita ed aver raggiunto una posizione sociale più dignitosa.
Venuto a sapere da Bruna del mestiere della madre, Ettore ritornerà alle cattive compagnie e, sorpreso a rubare, verrà arrestato e morirà in preda ad una sorte di febbre violenta legato ad un lettino di contenzione, invocando invano la madre che disperata tenterà poi il suicidio.
Ancora una volta Pasolini rivolge la sua attenzione ai problemi delle borgate romane degradate, all’esigenza di riscatto morale e sociale che spinge quel microcosmo a cercare invano una via d’uscita dalle proprie miserie e debolezze. Qui siamo anche in presenza di un rapporto intenso e inscindibile tra madre e figlio, un affetto che va al di là di qualsiasi ostacolo che il destino frappone, come a voler deliberatamente e sadicamente prendersi gioco delle umane sventure dei due protagonisti.
Mamma Roma vende al mercato carciofi e pertanto non possiamo non omaggiare la figura indimenticabile di questa attrice se non con questa ricetta di carciofi imbottiti.
INGREDIENTI: 8 carciofi romaneschi o cimaroli – 100 grammi di pan grattato – 100 grammi di formaggio pecorino grattugiato – 30 grammi di uvetta di Corinto – 2 spicchi d’aglio – prezzemolo, olio d’oliva sale e pepe q.b..
PROCEDIMENTO: Pulire bene i carciofi e lasciarli in acqua con succo di limone. Preparare un impasto composto dal pan grattato, il formaggio pecorino, l’uvetta, il prezzemolo abbondante tagliato fino e i due spicchi d’aglio anch’essi tagliati a pezzetti molto piccoli. Aggiungere un poco di sale, pepe ed olio d’oliva tanto quanto basta per ottenere una massa molto umida.
Effettuare una fessura con un coltello sulla testa del carciofo, introdurre a pressione con il dito l’impasto e disporre a testa in giù tutti i carciofi in una casseruola con un fondo di abbondante olio d’oliva ed una tazzina di acqua. Lasciare cuocere per circa mezz’ora con il coperchio. Lasciare raffreddare e servire a temperatura ambiente.

da Antonio Iraci | Gen 25, 2016
(Teatro India – Roma, 20/24 gennaio 2016)
A birritta cu’ i ciancianeddi (Il berretto a sonagli) è una commedia che Pirandello scrisse nel 1916, direttamente in dialetto siciliano, per farla rappresentare dalla compagnia teatrale di Angelo Musco il quale volle subito snellirne il testo originario, troppo pieno di riferimenti e riflessioni sulla condizione esistenziale dell’uomo, al fine di renderlo più leggero, sicuramente più comico e quindi più adatto alla sua interpretazione.
I vari personaggi ruotano intorno alla figura di Beatrice, sposata con il Cavaliere, che monopolizza l’azione con la sua incontrollabile gelosia dopo aver scoperto che il marito la tradisce con la bella Nina, moglie del contabile Ciampa. Incitata dalla tenace Saracena, Beatrice deve assolutamente vendicare l’affronto subìto e convoca in casa il delegato Spanò, che rappresenta la legge, per sporgere denuncia ed organizzare l’arresto dei due amanti. Dissuasa invano dalla fedele serva Fana, dal fratello Fifì e dalla madre Donna Assunta, la donna rimane tuttavia decisa a rendere pubblico il tradimento, consegnare alla giustizia la coppia fedifraga e riacquistare la propria libertà. Convocato con un pretesto Ciampa, lo stesso ammette di essere al corrente, come tutti in paese, della tresca amorosa e sostiene che sarebbe capace, in preda all’ira, di uccidere la bella moglie pur di riscattare la propria dignità di uomo tradito.
Ma la ragione sembra aver qui il sopravvento e suggerisce che la soluzione migliore è mettere le cose a tacere, senza sollevare un gran polverone che non conviene proprio a nessuno.
Qui Pirandello introduce un concetto molto significativo, che poi sarà la peculiarità non solo della sua opera drammaturgica ma del proprio modus vivendi privato: ognuno di noi è come se avesse dentro la propria testa tre strumenti, tre corde, che può manipolare a proprio piacimento secondo le circostanze. La corda pazza è quella che ci fa agire d’istinto, senza valutare le conseguenze dell’azione posta in essere; quella seria rimette le cose a posto portandoci verso la ragione ed ha una funzione critica oltre che morale; la corda civile, infine, è quella che svolge un’azione mediatrice, convenzionale, di facciata e che ha spesso il sopravvento in quanto imposta dal buon vivere civile.
In questi termini sembrerebbe quasi che Pirandello voglia riprendere i temi analitici appena elaborati da Freud che sosteneva che la psiche umana è come divisa in tre settori che interagiscono tra di loro (id, super ego, ego), solo che mentre Freud ne ricava uno studio meramente introspettivo, rivolto allo studio del sé, in Pirandello il sistema è invece rivolto verso l’esterno, verso il sociale. Ognuno di noi quindi è come un burattino (pupo), una maschera che si muove in pubblico cercando di non infrangere le convenzioni borghesi, evitando possibilmente di esternare la propria vera natura e mettendo così in perenne conflitto il sé con gli altri, nella continua ricerca dell’equilibrio.
Ecco che Beatrice pur agendo d’istinto per rivendicare giustamente la propria dignità di donna tradita ed umiliata (una femminista “ante litteram”), dopo aver ottenuto l’arresto dei due amanti, si troverà ad essere quasi forzatamente ricondotta alla ragione dagli altri che la convinceranno ad adottare una posizione di compromesso, in cui l’unica strada percorribile per salvare le apparenze ed evitare scandali inutili, che non giovano a nessuno, è quella di fingersi pazza e di confessare di aver agito solo d’impulso. Come? Gridando a tutti quella verità a cui nessuno crederà.
Valter Malosti, regista oltre che interprete di Ciampa, è riuscito a portare in scena con grande accortezza una tra le più complesse opere drammaturgiche di Pirandello adattando il testo originario, per renderlo comprensibile ad un vasto pubblico, pur mantenendo l’incisività del dialetto siciliano nella narrazione stessa. L’allestimento scenico di Carmelo Giammello risulta essenziale e congeniale per esaltare la bravura degli attori della Compagnia Teatro di Dioniso.
Posti esauriti in sala e pubblico entusiasta.
data di pubblicazione:25/01/2016
Il nostro voto: 

da Antonio Iraci | Gen 22, 2016
(Teatro della Cometa – Roma, 14/31 gennaio 2016)
La scena si apre su una stanza d’ospedale. Su uno dei due letti giace immobile, perché in coma profondo, Emanuele. Altri tre personaggi si troveranno nella stanza: Marco, compagno di Emanuele, Ilaria, sorella di Marco, Dario, marito di Ilaria.
I tre personaggi interagiscono verbalmente tra di loro, punzecchiandosi benevolmente su dissertazioni sostanzialmente un poco banali quali l’uso appropriato del congiuntivo per identificare il periodo ipotetico più che l’indicativo reale, oppure la definizione del termine bisessuale, sul quale sembra persista ancora una innocente confusione di base.
Ognuno dei tre si troverà, quasi per caso, da solo in stanza con Emanuele, con il quale intavolerà un dialogo dove verranno fuori debolezze, confidenze, malumori ma anche tenerezze. Ma questo dialogo non può che essere un monologo in quanto Emanuele è in coma e non può parlare, forse potrà sentire, ma certo non può interagire. Ecco quindi che l’altro diventa lo sdoppiamento del sé per lasciare che dica o faccia quello che ognuno di loro avrebbe voluto sentirsi dire o fare.
In un gioco quindi apparentemente convenzionale, trattato però con una giusta ironia, ci troviamo di fronte ad un fatto concreto che è l’infermità, probabilmente irreversibile, di Emanuele ma ciascuno dei tre personaggi sembra ancora voler credere nel miracolo per costruirsi un alibi di positività e sdrammatizzare qualcosa che ha tutte le caratteristiche della ineluttabilità. Il finale, imprevisto ma prevedibile, arriverà come tutti i finali per mettere un punto ma anche una virgola perché la vita va comunque avanti e, con le sue piccole ovvietà, risulterà comunque qualcosa che vale la pena di vivere e sicuramente di sperimentare.
Veramente attenta la regia di Riccardo Scarafoni, che interpreta molto bene anche il ruolo del compagno/fidanzato di Emanuele (Francesco Venditti). Molto fluida la recitazione degli altri due sulla scena: Ilaria (Veruska Rossi) e Dario (Fabrizio Sabatucci) entrambi nel ruolo di genitori attenti nei confronti della figlia, ma sostanzialmente divergenti nei metodi punitivi da applicare dopo aver scoperto che la stessa ogni tanto si concede una canna.
Quindi tutto all’insegna del totale minimalismo, nei dialoghi e nei contenuti, senza sostanziali colpi di scena tali da impressionare lo spettatore che comunque segue, sorride, applaude quasi a confermare che nella vita, anche di fronte alla morte, un tocco di leggerezza non ci starebbe proprio male.
data di pubblicazione 22/01/2016
Il nostro voto: 
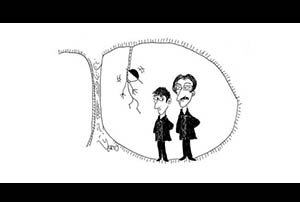
da Antonio Iraci | Gen 16, 2016
(Teatro dell’Orologio – Roma, 12 e 15 gennaio 2016)
Con La Variante E.K. si chiude la trilogia Niente di nuovo sotto il suolo presentata ieri al teatro dell’Orologio dal duo composto da Luca Ruocco e Ivan Talarico (produzione DoppioSenso Unico). Dopo aver affrontato i temi dell’alienazione e della malattia-morte in questo terzo lavoro si parla del suicidio e sulla metodologia migliore per conseguire il risultato desiderato. E.K. è uno del pubblico, scelto a caso a svolgere il ruolo di protagonista nella rappresentazione, che seguendo la logica del non logico è chiamato a configurare il personaggio pronto al suicidio.
Solo che è inesperto, non conosce ancora la tecnica del cappio ed è anche indeciso se tentare altre forme che però potrebbero risultare meno efficaci (colpo di rivoltella alla tempia, il veleno…). Tornati all’idea originale del cappio per impiccarsi, si accettano consigli utili per l’azione perché E.K. è imbranato, impacciato anche quando assume la fisionomia di un cavallo, perché, diciamolo pure, lui è proprio naif se non fosse per quella sua mania per il west…
Seguendo quindi il filone del surreale Luca e Ivan trattano un altro tema particolarmente triste che è quello del suicidio, tutto svolto con una ironia accompagnata da un sano cinismo, di sicuro impatto tra il pubblico che risulta divertito da quei dialoghi brevi e completamente sconclusionati.
Un tipo di teatro, definirei anarchico-dadaista, dove viene sovvertita ogni regola sia nell’impostazione scenica che nella narrazione per il linguaggio utilizzato privo di una qualsiasi consequenza logica.
Non credo che ci sia altro da dire se non che il duo di DoppioSenso Unico ha confermato ancora una volta la sua bravura in uno stile tutto proprio di recitazione insegnandoci che il teatro è soprattutto improvvisazione, il che non toglie nulla alla validità e profondità di significato di un testo (che qui non c’è).
data di pubblicazione 16/01/2016
Il nostro voto: 







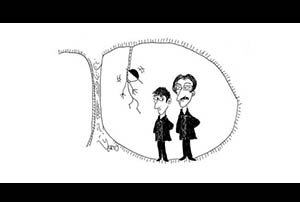





Gli ultimi commenti…