
da Antonella Massaro | Gen 15, 2015
Approda nelle sale italiane Hungry Hearts di Saverio Costanzo, dopo il fortunato sbarco al Lido della 71ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: generosi applausi del pubblico e doppia Coppia Volpi ai due attori protagonisti Adam Driver e Alba Rohrwacher.
La storia, tratta dal romanzo Il bambino indaco di Marco Franzoso, è un potente crogiolo di sentimenti estremi, perennemente in bilico sul delicato filo della imperscrutabile tensione psicologica.
Per Mina e Jude galeotto fu il maleodorante bagno di un ristorante cinese di New York. Cupido scocca implacabile la sua freccia sotto forma di porta che non ne vuole sapere di aprirsi. La passione, il matrimonio e la gravidanza sembrano seguire il copione della storia ideale, fino a quando l’amore materno di Mina per il suo bimbo “speciale” diviene una soffocante coperta di affetto. È decisa a mantenere pura e sana la sua creatura, a proteggerla da ogni possibile contaminazione che possa derivare dal mondo esterno. A partire dal cibo. Quel cibo maleodorante con il quale si apre il film e che attribuisce alla scena di apertura del film un significato (forse) più profondo del semplice “siparietto galeotto”. I tentativi di arginare l’amore di una madre inconsciamente trasformatasi in potenziale carnefice nella sua bolla di assoluto isolamento si succedono con un ritmo incalzante, che tuttavia non si rivela sorretto da un finale sufficientemente solido.
Malgrado lo sforzo nel tratteggiare la psiche di personaggi indubbiamente complessi, Hungry Hearts restituisce un’impressione di incompletezza, dovuta forse ai blocchi troppo rigidamente contrapposti nei quali la storia risulta articolata. Ottima la prova di Alba Rohrwacher, con un Adam Driver non sempre alla sua altezza.
Il film è recitato in inglese. Adam Driver però canta “Tu si ‘na cosa grande” in italiano. E la festa di matrimonio è scandita dalle note di Flashdance. Una colonna sonora che rende immediatamente riconoscibile Hungry Hearts come prodotto da “grande pubblico”. Al botteghino l’ardua sentenza.
data di pubblicazione 15 /01/2015
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Gen 4, 2015

Il mondo è popolato da tre categorie di uomini: le pecore, i lupi e i cani da pastore. Chris non è nato né per subire passivamente il male né per prestare a quel male le proprie fauci: la missione alla quale è destinato è quella di difendere chi non ha la forza o la capacità di badare a se stesso, anche quando ciò comporti la definitiva eliminazione dell’avversario.
In American Sniper Bradley Cooper presta il suo volto e i suoi muscoli a Chris Kyle, il cecchino “Leggenda” dei Seals, che ha messo a segno 160 bersagli durante la guerra in Iraq. Per quanto il film si riveli a tratti intriso di celebrativo patriottismo, Clint Eastwood sembra scongiurare il rischio di una compiaciuta celebrazione della guerra americana “di difesa e di liberazione” e delle sue logiche fatte (anche) di uno straripante ego virile, che magari indossa la maschera dell’insindacabile senso del dovere e veste il mantello del supereroe che protegge la città dall’alto, con il potere della sua mira infallibile.
La storia di Chris Kyle, forse esageratamene patinata per ciò che attiene alla sua dimensione privata al fianco dell’impeccabile mogliettina Sienna Miller, finisce piuttosto per mostrare come tra i fumi e le polveri del campo da battaglia la dicotomia bene/male divenga meno nitida dell’immagine delle Torri gemelle che si sgretolano guardata attraverso il televisore. Nel momento in cui nel mirino finiscono donne e bambini, persino il più fedele e intrepido cane da pastore prova la lacerante sensazione di trasformarsi in lupo spietato.
Quel campo da battaglia che si rende esperienza inevitabilmente totalizzante per i combattenti che, per le ragioni più diverse, decidano di mettervi piede. Anche quando si torna a casa, non si torna mai veramente. Il rombo di un motore, un suono metallico, un cane che gioca con un bimbo: ogni dettaglio della “vita” finisce per assumere la consistenza della “morte”.
132 minuti di ritmo incalzante per un film che in più di una sequenza lascia lo spettatore con il fiato sospeso e che, pur non essendo forse tra le prove migliori di Eastwood, si caratterizza per quel misto di spettacolarità e di esistenzialismo che rendono riconoscibile il suo cinema.
data di pubblicazione 04 /01/2015
Scopri con un click il nostro voto: 

da Antonella Massaro | Gen 4, 2015
Big Eyes di Tim Burton racconta al grande pubblico la storia vera di Margaret Keane, la pittrice dei bambini con gli occhi grandi.
Gli occhi, si sa, sono lo specchio dell’anima e Margaret l’anima la vede così: sconfinata, sproporzionata, ingombrante, sgranata sul mondo e sugli altri occhi. Gli occhioni dei suoi bimbi resterebbero però uno dei tanti orpelli da bancarella se il secondo marito di Margaret, Walter Keane, affabulatore con la smania di diventare artista, non si appropriasse fraudolentemente delle opere della moglie immettendole nel tritacarne dell’arte massmediatica. Quell’arte in cui i critici riescono a vedere solo del banale kitsch involgarito dall’ossessione della serialità, ma che il resto del mondo è disposto a comprare senza riserve. E quando le tele diventano troppo costose, si passa alla loro riproduzione: poster, cartoline, biglietti d’auguri venduti nella galleria d’arte di Walter e negli scaffali del supermercato.
Margaret, dopo aver divorziato dal primo marito, non se la sente di mettere nuovamente in discussione quella potestà maritale alla quale persino un prete si sente in dovere di richiamarla, nell’America degli anni Sessanta non ancora pronta a metabolizzare un’arte fatta da donne. Per questo continua a dipingere e a lasciare che Walter si goda l’inebriante ubriacatura del successo. Continua a dipingere in maniera bulimica, nevrotica, patologica, fino a quando la classica goccia che fa traboccare il vaso non la convincerà a cambiare vita e a trascinare suo marito in tribunale.
Pronunciare il nome “Tim Burton” significa accostare a quel nome l’aggettivo “visionario”, ma in Big Eyes di visionario c’è davvero molto poco, se si fa eccezione per la sequenza del supermercato e quella del tribunale e per gli abbaglianti colori della fotografia dell’inizio e della fine del film che esaltano lo sguardo di Amy Adams, più sconfinato, sproporzionato, ingombrante e sgranato di quello dei suoi bambini.
Una bella “favola vera” sostenuta dalle interpretazioni magistrali di Amy Adams e Cristoph Waltz, ma con scarsa capacità di sorprendere e di incantare.
data di pubblicazione 04 /01/2015
Scopri con un click il nostro voto: 
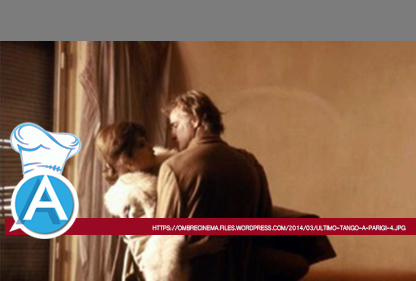
da Antonella Massaro | Gen 2, 2015
Un appartamento vuoto nell’ormai leggendaria Rue Jules Verne di Parigi, due sconosciuti che si incontrano per caso, due corpi che si fondono per istinto, due anime che si avvicinano per necessità, secondo i tradizionali canoni di un’attrazione tanto irresistibile da divenire fatale.
Dopo aver assistito alla prima newyorkese di Ultimo tango a Parigi (1972), Pauline Kael, tra i critici americani più rappresentativi della sua epoca, scrisse che la proiezione del film di Bertolucci equivaleva, nella storia del cinema, a quel che “La sagra della Primavera” di Stravinnskij aveva rappresentato per la storia della musica e, più in generale, della cultura. Un’opera in grado di gettare una platea di persone adulte, dotate di una solida formazione culturale, in un autentico stato di shock e di spalancare al cinema le porte di quella potenza evocativa che il grande schermo stava sperimentando, forse per la prima volta, in maniera così drammaticamente esplicita.
Ultimo tango a Parigi, prodotto dal “coraggioso” Alberto Grimaldi, è anche noto per essere stato il protagonista di una vicenda giudiziaria talmente articolata e discussa da far meritare all’opera di Bertolucci il titolo di autentico leading case nei rapporti tra arte cinematografica e diritto, sia in riferimento alla scure della censura amministrativa sia (e forse soprattutto) per la possibile rilevanza penale di film considerati “osceni” (articoli 528 e 529 del codice penale).
Tanto nelle sentenze relative al “caso Ultimo tango” quanto nell’immaginario collettivo, l’emblema di una (pretesa) offesa al comune sentimento del pudore è rappresentata dalla scena, peraltro non prevista nella versione ufficiale della sceneggiatura edita da Einaudi nel 1973, in cui Marlon Brando “porge” all’ignara Maria Schneider un panetto di burro per scopi non propriamente domestici, dissacrando con le sue parole quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù che è la famiglia.
Tanto rumore per un panetto di burro?
Sicuramente dissacrante, ma quantomeno pertinente, è la ricetta di biscotti al burro che abbiamo voluto abbinare a questo autentico capolavoro della cinematografia mondiale.
INGREDIENTI: – 350 gr di farina “00” per dolci (arricchita con amido di frumento) – 1 cucchiaio abbondante di zucchero – 2 uova intere – 1 pizzico di sale – 250gr di burro (tirato fuori dal frigo almeno ½ ora prima) – 1 bustina di lievito per dolci –zucchero a velo q.b.
PROCEDIMENTO: Accendete come prima cosa il forno a 150° termo-ventilato; amalgamare quindi bene gli ingredienti aggiungendo al centro della farina adagiata su di una spianatoia: il pizzico di sale, il lievito, le due uova, lo zucchero, il burro molto morbido fatto a pezzettini. Lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo e quindi mettere l’impasto per circa 15 minuti nel frigorifero avvolto nella pellicola trasparente; dopo averlo fatto riposare in frigo, con il mattarello tirare sfoglie alte 1 cm. e tagliarle con formine varie. Adagiare quindi i biscotti così ottenuti su una leccarda foderata con carta da forno e infornare a 150° termo-ventilato per soli 12 minuti. Dopo aver cotto tutti i biscotti (non basterà una sola infornata), a freddo cospargeteli con zucchero a velo e conservarli in una scatola di latta con il fondo ricoperto di carta oleata.
Sono ottimi con il the.
CONSIGLI: Si possono aggiungere all’impasto degli aromi, come ad esempio i semi di un baccello di vaniglia, la buccia grattugiata di ½ limone, dello zenzero tritato o semplicemente della cannella in polvere.

da Antonella Massaro | Dic 29, 2014
(Museo dell’Ara Pacis – Roma, 26 settembre 2014 / 25 gennaio 2015)
Henri Cartier-Bresson (1908-2004) ha immortalato attraverso l’obiettivo della sua macchina alcuni degli snodi più significativi del secolo scorso, cesellando al tempo stesso quegli scatti senza tempo che nell’immaginario comune identificano ormai la Fotografia per antonomasia.
La poesia e il gusto per la composizione dell’immagine da una parte, l’impegno politico e la testimonianza dall’altra. Henri Cartier-Bresson è Uno, Nessuno e Centomila nell’esposizione allestita a Roma presso il Museo dell’Ara Pacis, che celebra il genio eclettico del suo “occhio assoluto”, divenuto in breve tempo “occhio del secolo”.
È affascinato dalla rassicurante infallibilità della matematica e della sezione aurea, ma anche fatalmente attratto dalla deformazione surrealista dei corpi e dello spazio. È l’artista che lascia la macchina in paziente attesa che “succeda qualcosa” davanti al suo occhio e che cattura poi “l’istante decisivo” come un cacciatore fa la con la sua preda, ma è anche il fotografo a servizio della stampa comunista e tra i fondatori della Magnum Photos, l’agenzia che inaugura un nuovo modo di fare e di intendere il reportage.
Durante il percorso disegnato dalla mostra, la fotografia assume progressivamente la consistenza del “documentario”, mostrando una vocazione sempre più chiaramente ed esplicitamente politico-sociale. Dietro lo scatto minuziosamente composto che, rievocando le atmosfere di alcuni dipinti di Renoir, ritrae un momento di svago in riva alla Senna si cela il traguardo delle prime ferie retribuite ottenute dai lavoratori francesi, così come dietro i volti sorridenti del gioco a premi “Il mistero del bambino scomparso” si nasconde la celebrativa simbologia salvifica del comunismo. Nessuna “interpretazione” è per contro necessaria a fronte della vibrante sequenza del processo popolare allestito nei confronti di una collaborazionista nazista o davanti al pianto dirotto di una donna accartocciata sulle macerie di Dessau.
L’occhio dello spettatore è catapultato in un vorticoso viaggio attorno (e nel) mondo: l’Africa delle colonie, la Cina della cartamoneta che si svaluta vertiginosamente, la Cuba di Fidel Castro e dei conturbanti corpi femminili, l’India dei funerali di Gandhi, la Russia in cui troneggia ancora per molto tempo la gigantografia di Stalin.
Il tutto intervallato dagli stracci che alludono al mistero dell’erotico velato, dalle donne in nero che nelle stradine di Scanno volteggiano come note su uno spartito, da quei celeberrimi scatti del 1932, “Dietro la stazione Saint-Lazare” e “Hyères”, che condensano mirabilmente la perfezione di un’arte al cospetto della quale è inevitabile l’estatica contemplazione.
Per me la fotografia non è un lavoro, ma piuttosto un duro piacere; non cercare niente, aspettare la sorpresa, essere una lastra sensibile.
Il momento dello scatto si colloca a metà strada tra il gioco del borsaiolo e del funambolo. Un gioco perpetuo, accompagnato da una tensione estrema.
L’uomo. L’uomo e la sua vita, così breve, così fragile, così minacciata. […] Io mi occupo quasi esclusivamente dell’uomo. I paesaggi sono eterni, io vado di fretta.
data di pubblicazione 29 /12/2014





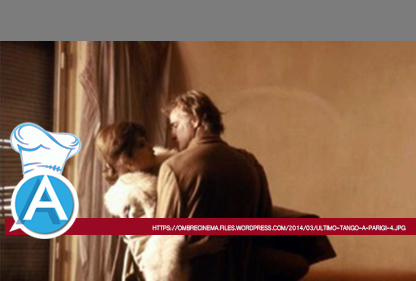






Gli ultimi commenti…