
da Gabriella Ricciardi | Gen 7, 2016
New York, 1952, a pochi giorni dal Natale, Carol, una meravigliosa Cate Blanchett, si aggira nel reparto giocattoli di un grande magazzino sotto gli occhi rapiti di Therese Belivet (Rooney Mara) che lì lavora come commessa. I guanti dimenticati sul bancone dalla elegantissima signora, saranno la scusa per rivedersi. Therese è molto più giovane di Carol che dal suo matrimonio ha avuto, cinque anni prima, una bambina molto amata con la quale vive in una villa fuori città; una prigione dorata dove è obbligata a rispettare le convenzioni alto borghesi per poter rimanere accanto a sua figlia. Ma il matrimonio è alla fine, segnato da una precedente unione di Carol con Abby e dall’ostinazione del marito che pensa di poter “riparare” i desideri omosessuali della moglie con la psicoterapia e forzarla ad amarlo. Therese è una ragazza ancora insicura, ma non esita a seguire Carol in un viaggio attraverso gli Stati Uniti che sarà anche il loro percorso di trasformazione. La timida Therese tra le braccia di Carol scopre se stessa e la sua determinazione, e al ritorno diventerà una fotografa al “Times”. Carol proverà ancora a essere una moglie irreprensibile; ma l’amore per Therese l’ha cambiata per sempre, spingendola a rinunciare perfino alla custodia della piccola pur di vivere con lei.
Una appassionata storia d’amore, morbida, dai colori tabacco, dalle risposte appena accennate o dai silenzi, in un esercizio magistrale di equilibri tra la forza tellurica della passione e il coraggio che ci vuole per viverla.
Un film che racconta l’impossibilità di negare se stessi, la forza dei propri sentimenti, ma Todd Haynes lo fa scegliendo la strada della sottrazione, in modo da spingere anche lo spettatore a sentire l’urgenza di non sprecare nessuna occasione. Girato a basso budget e che invece mantiene l’eleganza vellutata del genere a cui si ispira, il melò di Douglas Sirk de La magnifica ossessione, o alla regia perfetta di Howard Hawks de Il grande sonno, tanto da rendere Carol un’emanazione luminosa di Lauren Bacall. La loro storia d’amore, raccontata in un lungo flashback, sarà il tempo in cui Therese cercherà dentro di sé una risposta alla richiesta di Carol che è tornata a cercarla, come se anche noi stessimo guardando dentro noi stessi, valutando il rischio di essere felici. Eleganza, e una bellezza che ha il pregio di non restare solo formale ma di essere la sostanza stessa del film, intensità che le commediole nostrane nemmeno sfiorano.
data di pubblicazione 07/01/2016
Scopri con un click il nostro voto: 
———————————————————————————————————————————————————————
Estratto da: INCONTRI RAVVICINATI – Todd Haynes (Festa Cinema Roma 2015) -23 Ottobre 2015
https://www.accreditati.it/incontri-ravvicinati-todd-haynes-festa-cinema-di-roma-2015
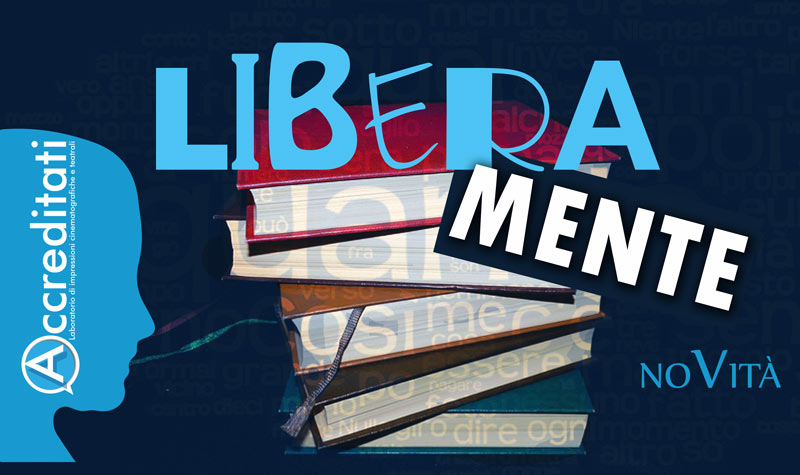
da Gabriella Ricciardi | Nov 29, 2015
Sei anni fa con Accabadora, Michela Murgia raccontava un legame molto particolare in cui venivano trasmessi saperi antichi, da Tzia Bonaria a Maria, e che rendeva quest’ultima capace di sostituire la prima nel gesto ultimo da portare a chi soffre permettendogli di lasciare la vita con meno strazio. Saperi profondi e arcaici che possono essere “insegnati” solo in una dimensione maieutica in cui l’allievo riconosce la statura e l’importanza dell’altro, scegliendolo come proprio maestro.
Anche in Chirù della stessa autrice, appena uscito per Einaudi, si stabilisce un legame, una iniziazione che è il cardine della storia come lo era nel romanzo precedente.
Chirù, un diciotenne dalla chioma folta e gli occhi neri come onici, è un giovane violinista; individuata in Eleonora la sua maestra, si presenta a lei con l’irruenza e la determinazione della giovinezza. Eleonora è un’affermata attrice di teatro e non è la prima volta che ha un allievo, ci sono già stati Alessandro, Teo e Nin; ma mentre i primi due hanno trovato la loro strada con successo, Nin ha lasciato a Eleonora un ricordo doloroso e un rimorso. Per questo ora Eleonora è cauta e timorosa di fronte alla richiesta di Chirù, tanto da volare a Roma da Fabrizio, uno dei suoi amori più importanti, per confrontarsi con lui su quest’arte difficile che anche lui ha esercitato in passato, e scoprire se è davvero pronta ad assumere di nuovo il ruolo che Chirù le chiede. Ma i timori di Eleonora, vengono prepotentemente scalzati da un sentimento di appartenenza – Lo riconobbi dall’odore di cose marcite che gli veniva da dentro, perché quell’odore era lo stesso mio.– che le fa affiorare negli intensi mesi della loro relazione, schegge di ricordi. Un’infanzia con un padre violento che la costringe ad un apprendistato precoce sull’arte del fingere; gli amori e i primi successi come attrice in una Roma che la vede ancora impacciata; una solitudine abituata “all’autarchia del cuore” che comincia a incrinarsi. E proprio i ricordi ripresi e rimasticati le permetteranno di giungere a una nuova fioritura, a sbocciare e ad aprirsi a un nuovo e importante amore.
Chirù è arrivato nella sua vita come vengono i legni alla spiaggia, levigato e ritorto, scarto superstite di una lunga deriva; ed è questo riconoscersi reciprocamente come pezzi fallati, al di là dei vent’anni che li separano, a permettere questa trasformazione, tanto da non sapere più chi sta conducendo e chi è condotto.
L’apprendistato di Chirù, quello che lo dovrebbe condurre senza fallire al successo o comunque a saper riconoscere le opportunità che la vita saprà offrirgli, è un cammino puntellato di libri consigliati, di tessuti pregiati da riconoscere, ma soprattutto è un addestramento ad andare al di là delle apparenze e delle spiegazioni banali, perché gli esseri umani intessono solo relazioni complesse nelle quali bisogna sapersi muovere. E un’artista, per poter diventare tale, deve temprare e misurare il proprio talento anche su questa capacità sociale. I loro appuntamenti, nei tre mesi dopo il primo incontro, nei bar, nei caffè, sulla spiaggia del Poetto battuta dal maestrale, sono interrotti dalla tournée teatrale di Eleonora che apre il romanzo ad altri luoghi: Stoccolma, Praga, Firenze; come se fossero differenti stati d’animo di un cuore che va progressivamente sciogliendosi dal ghiaccio e dai colori lividi del freddo nordico, per approdare nella Roma dell’epilogo, calda, accogliente e primaverile.
Michela Murgia possiede il “mestiere” della scrittura, inteso come il pregio assoluto del saper scrivere. La capacità che racchiude il talento e l’ufficio, il mestiere appunto, esercitato come un bulino dall’orefice. Come la sua Eleonora, la Murgia è capace di scandagliare i sentimenti fino a sminuzzarli per il lettore, trovando sempre la parola giusta, quella più incisiva e suggerente, e questo rende le sue pagine preziose ed asciutte, perfino sontuose nelle descrizioni di profumi e paesaggi, ma in questo romanzo i sentimenti restano pensieri, acuti, articolati, ma pensieri. Chirù è un musicista ma sceglie un’attrice come sua mentore; mi direte non è importante perché il loro è un colloquio d’anime – anche se il corpo fa il suo gioco silente – che si stabilisce molto al di là delle categorie rigide che siamo abituati a maneggiare sia riguardo ai rapporti d’amore che alle arti. Ma è questa sorta di “divina predestinazione”a non convincere, e non perché sia impossibile riconoscere un “simile”, ma perché questa scelta viene consegnata al lettore come assodata. Non veniamo a saperne di più leggendo, anche se apprendiamo che lo stato di “orfanità” li riguarda entrambi, perché entrambi si sono dovuti prendere cura da soli della propria educazione, al margine di quella dei genitori biologici.
Chirù non ha esitazioni, in mezzo a tante persone si presenta a lei con un’esigenza chiara. Sa che lei e lei soltanto potrà insegnarli un modo adulto di proporsi, di proporre il proprio talento che per vincere ha bisogno di appoggiarsi ad un sapere articolato, non riducibile a una sola maestria, come quella del violino nel suo caso.
Le arti di Eleonora e Chirù, restano però una pagina sfocata, un’occasione che entra nel meccanismo narrativo per far girare la narrazione e spingerla verso altri luoghi. Certo le città della tournée offrono colori e temperature che rispondono a un paesaggio e a un cambiamento di passo interiore, ma non ci si addentra mai nello specifico di ciascun mestiere, di ciascun linguaggio, come se non fosse determinante la condizione artistica che li lega. Il basso tuba di tutto il romanzo è il potere, o meglio, l’amore che si misura con il potere. Il potere e le sue declinazioni sono la grammatica di ogni amore, questo sembra dirci la Murgia, ed è il territorio che l’autrice voleva dichiaratamente esplorare, ma la storia non decolla, ha un passo corto e slabbrato seppur servito da una scrittura cesellata e acuta.
Questi due personaggi sono stretti in un passo a due che non produce suono e non coinvolge; più belle e vere le pagine dei ricordi personali e familiari di Eleonora. Loro restano un “esercizio” l’uno per l’altra, un tentativo di fare luce sulle strette maglie che reggono insieme il potere e l’amore, tentativo continuamente rimandato, fino a che giunti alla fine, scopriamo di non aver trovato una cifra diversa da quella dichiarata sin dall’inizio dove due “legni marci” si erano attratti come dice la stessa Eleonora: Io vorrei poter dire che fra di noi c’è stata un’affinità elettiva, ma la verità è che questo ragazzo aveva delle cose marce dentro e io le ho riconosciute, perché sono le stesse che ho io.
Un’attrazione che si tramuta in affrancamento, ma restiamo spettatori di questa trasformazione, in nessun momento ne veniamo emotivamente contagiati o intellettualmente coinvolti, come se la compressione della storia ci lasciasse vedere la trama della stoffa, ma non il suo spessore. I modi, la consistenza di questo “travaso”, di questo apprendistato mutuo ci sfuggono, come se quell’immediato riconoscersi escludesse la possibilità di essere raccontato; come se il loro passo a due (e non perché il ballo debba essere perfetto, al contrario la vita è colma di passi falsi, di cadute) fosse tutto ballato all’inizio e non avesse senso spostare ancora la coppia nella sala. Arriva repentina la fine, una fine narrativamente semplice, che lascia il lettore a misurarsi con delle sentenze che hanno promesso senza sbocciare, come se ci fossero tutte le premesse per un grande romanzo, tutte le voci e le possibili complicazioni, ma sono appena sfiorate, suggerite e si passa ad altro.
Chirù ha una particolarità: diversamente dai personaggi letterari che abbiamo conosciuto sino ad ora, non ha vissuto e vive solo nelle pagine del libro della sua autrice, ma nelle settimane che hanno preceduto l’uscita in libreria del romanzo è stato un profilo Facebook, tutt’ora attivo. La pagina di Chirù Casti (il cognome è solo sul profilo) è raggiunta da circa seimila persone al giorno che leggono i suoi post, guardano le foto pubblicate e si commuovono sulle parole scritte ad esempio, per commentare i fatti di Parigi. Che sia questo d’ora in avanti il modo in cui i personaggi amati o odiati di una storia continueranno a essere presenti nella nostra vita? Forse il libro passerà, nelle librerie, come accade ormai di consueto, tra poco sarà difficile trovarlo, ma forse Chirù Casti continuerà il suo dialogo con il popolo della rete che, forse, il libro non lo ha neppure letto.

da Gabriella Ricciardi | Ott 23, 2015
The Price of Salt è il secondo romanzo di Patricia Highsmith che dopo il fortunato esordio con Strangers on a Train, adattato da Hitchcock (successivamente Delitto per delitto), non trovò un editore a causa della storia omosessuale che vi si narrava. Fu pubblicato con uno pseudonimo ed ebbe un grande successo; eppure fu rieditato solo negli anni 80 con il nome della sua autrice e con il titolo con cui oggi lo porta sugli schermi Todd Haynes, Carol, presentato a Cannes 2015 dove Rooney Mara ha vinto il premio come miglior attrice.
Haynes, che più volte nel suo cinema ha reinventato il genere del melò in chiave moderna, anche in questo caso trascina emotivamente fin da subito lo spettatore in una appassionata storia d’amore ammorbidita dal velluto, dai colori tabacco, dalle risposte appena accennate e spesso dai silenzi, in un esercizio magistrale di equilibri tra la forza tellurica della passione al suo manifestarsi e l’impreparazione, la reticenza, di chi la sente e non può o non riesce ad abbandonarcisi. Haynes ha dichiarato che ciò che lo aveva colpito della Highsmith era l’essere riuscita a stabilire “un’analogia tra la patologia della mente criminale che racconta nel resto della sua opera, e la patologia della mente amorosa, imponendo la stessa visione ansiogena a entrambi gli stati.”
New York, 1952, a pochi giorni dal Natale Carol, una meravigliosa Cate Blanchett, si aggira nel reparto giocattoli di un grande magazzino sotto gli occhi rapiti e incuriositi della commessa Therese Belivet (Rooney Mara). I guanti lasciati sul bancone dalla elegantissima signora, proprio come in un romanzo cavalleresco, saranno il mezzo attraverso il quale le due donne si rivedranno. Therese è molto più giovane dell’altra che dal suo matrimonio con Harge ha avuto, cinque anni prima, una bambina amatissima. Carol vive in una villa fuori città, una prigione dorata dove è obbligata a rispettare le convenzioni di un mondo alto borghese per poter stare accanto a sua figlia. Ma il matrimonio è alla fine, provato da una precedente unione di Carol con Abby e dall’incomprensione del marito che come i genitori, pensa di poter “riparare” i desideri omosessuali della moglie con la psicoterapia e ricondurla alla ragione. Therese è innamorata dell’obbiettivo della macchina fotografica con la quale scopre il mondo, e respinge timidamente il suo fidanzato che vuole sposarla, perché nel fondo sente di non potergli corrispondere. Non ha ancora i mezzi, a parte l’obbiettivo, per conoscere se stessa, ma non esita a seguire Carol.
La loro storia d’amore, raccontata in lungo flashback, racchiude il percorso di trasformazione che le due donne compiono nel loro viaggio verso Ovest. La timida Therese tra le braccia di Carol scopre se stessa e la sua determinazione, e al ritorno non sarà più una commessa ma una fotografa del “Times”. Carol proverà ancora, negando se stessa, a essere una moglie irreprensibile per poter restare accanto a sua figlia; ma l’amore per Therese la cambia per sempre, spingendola a rinunciare perfino alla custodia della piccola pur di vivere con lei.
Un film che racconta passioni forti, ma Haynes ha scelto la strada della sottrazione, seppur attraverso una raffinatissima eleganza, evidente sia negli ambienti che nei costumi, smorzandola, filtrandola, in modo da spingere lo spettatore a sentire l’urgenza di cambiare le cose, a forzare quella quiete che le case e i panni ripropongono. Un film girato a basso budget e che invece mantiene l’eleganza vellutata del genere cinematografico che reinventa, quello della bellezza melò di Douglas Sirk de La magnifica ossessione, o della perfezione registica di Howard Hawks de Il grande sonno, tanto da rendere Carol un’emanazione luminosa di Lauren Bacall. La pelle diafana sotto la quale vibra il desiderio per Therese, quella stessa raffinata eleganza che muta impercettibilmente a seconda di dov’è e di chi la guarda. Se sono gli occhi di Therese o il suo obbiettivo si rivela anche fragile, fragilità che invece socialmente si trasforma in sicurezza, e la Blanchett passa da uno stato all’altro con la morbidezza e la naturalezza della grande attrice. Corrono verso l’Ovest, ma sanno che la loro vera battaglia andrà condotta in città. È in quel teatro del mondo che devono trovare la loro dimensione sociale, quella del lavoro, quindi politica sembra dire Haynes, per poter essere se stesse e vivere il loro amore. Gli uomini di questa storia sembrano non avere alcun mezzo per comprendere cosa accade alle donne in generale e alle loro in particolare. Sono increduli e si affidano al controllo, alle minacce, e perdono, annunciando l’inizio di una rivoluzione sociale che cambierà per sempre i rapporti tra i sessi. Mentre Therese cerca dentro di sé una risposta alla richiesta amorosa di Carol, dietro un vetro offuscato dalla pioggia dove scorre la storia del loro amore e il film che stiamo vedendo, si alternano i sentimenti declinati in colori, la complessità e l’ambivalenza di ogni storia d’amore.
Come in Lontano dal paradiso, Haynes, per raccontare le trasformazioni e le contraddizioni sociali, sceglie un’America sulla soglia del cambiamento, gli anni 50, con uno stile cinematografico capace di assorbire la lezione dei grandi film di quegli anni e restituirlo arricchito della complessità sociale ed emozionale del presente. Come se anche noi e non solo Therese, stessimo guardando attraverso un vetro a quel laboratorio così sorprendente che è la vita, da una distanza ovattata e morbida, proprio come il serico bianco e nero de Il grande sonno, ancora chiusi dentro una macchina appannata dall’acqua, ma ormai a solo un passo dal futuro.
data di pubblicazione 23/10/2015

da Gabriella Ricciardi | Ott 19, 2015
Ellen Page non ha più il visino della ragazzina, un misto di provocazione e tenerezza che aveva in Juno; in Freeheld ha quello di Stacie, una ragazza innamorata delle moto e dei motori e di Laurel (Julianne Moore), una poliziotta integerrima che vorrebbe che il loro amore restasse una cosa privata, ben custodito tra le mura domestiche. Ma l’amore è capace di rompere gli argini che Laurel ha faticosamente costruito per poter avere una carriera pari a quella dei suoi colleghi maschi, e dopo un anno dall’incontro, eccole ristrutturare la casa che hanno scelto per vivere in coppia. Una villetta americana come ce ne sono tante, con giardino e cane, rispondente in tutto e per tutto ai desideri delle due donne che questo chiedono alla vita. Dalle note di regia di Peter Sollett apprendiamo che alla vera storia di Laurel Heaster e Stacie Andree e alla battaglia che la coppia ha combattuto per ottenere giustizia, era già stato dedicato il documentario premio Oscar di Cynthia Wade, e che lui quindi nel suo film, più che l’aderenza alla verità, voleva raccontare come emotivamente l’avevano vissuta Stacie e Laurel, “la storia universale di due persone che solamente cercano un modo per amarsi”. E un modo le due donne lo trovano fino a quando alla pluridecorata dectetive del New Jersey non viene diagnosticato un cancro ai polmoni con nessuna speranza di cura. È in quel momento che Laurel capisce di non avere più tempo e che l’unica cosa che vuole, anche se per questo dovrà esporsi pubblicamente, è che i funzionari della Contea di Ocean, i “freeholders” (i “proprietari”) riconoscano a Stacie il diritto di godere della sua pensione maturata in 23 anni di fedele servizio. Alla battaglia si uniscono l’attivista gay per i diritti civili Steven (Steve Carell) e il detective Dane (Michael Shannon), da sempre compagno di lavoro di Laurel e legato a lei da affetto e stima profondi.
Nella serata inaugurale del loro amore vediamo una splendida Julianne Moore e la Page davvero capaci di ricreare sullo schermo l’elettricità dei primi incontri, reale, senza sbavature né esagerazioni. Una cosa “normale”, di quella normalità che poi le due donne rivendicheranno spesso nel corso del film, straordinaria, ma solo come lo sono tutti gli amori allo stato nascente. Una naturalità invidiabile e lontanissima dai timidi quanto maldestri tentativi italiani. Ma ecco che la vicende soffre la prima evidente ellissi perché, in men che non si dica, sono demolite le resistenze di Laurel e la coppia vive una giornata romantica e felice sulla spiaggia. Il film si propone di raccontare, almeno nelle intenzioni del regista, una storia d’amore, ma diventa da subito invece un film di genere, di quelli che conosciamo bene sulle battaglie civili, di quelli che mentre ti raccontano dell’ingiustizia che stanno denunciando, allo stesso modo ti dicono quanto l’America è capace di porre in crisi se stessa e i suoi “credo” politici, ribaltando l’ingiustizia iniziale in trionfo finale.
Dobbiamo credere al forte amore delle due donne perché ce lo dicono, ma non lo vediamo cinematograficamente narrato, non lo sentiamo, se non in quella serata iniziale. Assistiamo sgomenti e commossi all’avanzare implacabile della malattia, così come all’immancabile momento (in questo genere cinematografico) in cui anche ai duri si scioglie il cuore, e gli agenti di polizia finalmente si recano in massa all’assemblea pubblica per sostenere la lotta della loro collega. Il tutto molto veloce, come se più che a un film stessimo assistendo a una parabola esemplare di una battaglia ben condotta, corretta.
E se il film non sostenesse un diritto sacrosanto che è quello di ottenere diritti uguali per tutti, che siano coppie di fatto o matrimoni, gay o eterossessuali, come lo guarderemmo? Cosa ne avrebbero fatto i Dardenne? Mentre Laurel sta morendo, Stacie le è vicina e continua a dirle che la ama; non nego di aver pensato a Love Story, alle lacrime versate su amori infranti dalla morte, perché anche quello è un genere cinematografico, l’amore che vince la morte che è annientamento. In questo caso l’amore vince (e per davvero), ma è il ritmo del film che non convince, nonostante tenga insieme in modo meritorio la battaglia civile di una comunità e la battaglia privata contro la malattia, l’amore e il diritto e, non da ultimo, quanto ancora costa a una donna essere riconosciuta professionalmente come o più dei suoi colleghi maschi, senza cedere a compromessi.
data di pubblicazione 19/10/2015




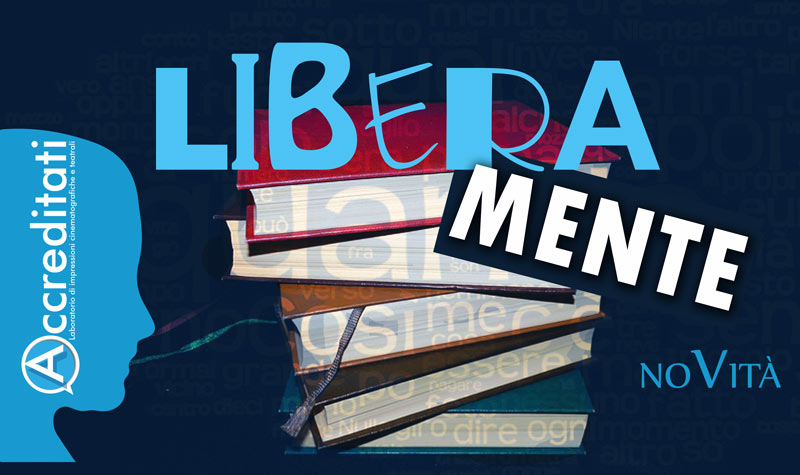







Gli ultimi commenti…