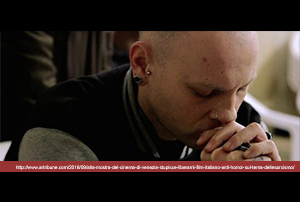
da Gabriella Ricciardi | Ott 5, 2016
Liberami, vincitore di Venezia Orizzonti, è un bel film sulla possessione demoniaca. Senza calcare la mano verso derive di genere racconta il mondo degli esorcismi con ironia. Un documentario rigoroso che si guarda come un film.
Liberaci dal male. Il coro dei fedeli aggiunge Amen, poi normalmente se ne vanno tutti “in pace”. Non accade così nel bel film di Federica Di Giacomo, Liberami – antropologa di formazione, fresca di vittoria veneziana nella sezione Nuovi orizzonti – lì i fedeli arrivati da tutta Palermo per la messa del martedì pomeriggio non se ne vanno in pace, alcuni si buttano per terra, urlano, “posseduti dal maligno”. Le ci sono voluti tre anni per raccontare cosa accade a una persona “posseduta” dal diavolo e che vive in Sicilia, perché è lì che opera uno dei più richiesti esorcisti italiani, Padre Cataldo, in una periferia scorticata, in una parrocchia dove sin dalle prime luci dell’alba si accalcano gruppi di fedeli che cercano una parola di conforto o che gli venga praticato l’esorcismo. Lui ascolta pazientemente tutti, sceglie parole semplici e non ha mai un momento di cedimento, di dubbio. Gloria, Enrico, Anna e Giulia vengono allo scoperto e si lasciano filmare nei momenti più difficili della possessione. Laddove, normalmente la telecamera spinge sul pedale dell’esagerazione, del pathos o dell’horror nei film di genere, la Di Giacomo registra con discrezione la vita di chi è prigioniero del diavolo, senza enfasi e con ironia. Padre Cataldo è bonario, ma il giudizio su due genitori che gli hanno portato il figlio piccolo, un diavolo quando deve andare a scuola, è tagliente: quella famiglia non è in grazia di Dio, e soprattutto è la madre ad aver smarrito la corretta via, permettendo al diavolo di impossessarsi del più debole.
La cifra della regista è quella del vero documentarista: registra la realtà possedendo uno sguardo, una posizione intellettuale per decifrarla senza che questa diventi invadente, una tesi da dimostrare. Vediamo Padre Cataldo colpevolizzare immediatamente la madre del “bimbo indiavolato”, o in una casa, ricca di mobili e quadri pregiati, abbattersi come una scure sul superfluo che lì regna, senza risparmiare di abbondante acqua (e probabilmente rovinandole) le preziose tele seicentesche di madonne e santi, che per lui dovrebbero invece stare in una chiesa, o in un esorcismo telefonico che si chiude con gli auguri di Natale. In quei momenti si ride apertamente, e l’ironia diventa la chiave di volta, il basso continuo del film. Senza smettere di provare simpatia per il religioso e pena per i sofferenti, grazie al riso, ci si distanzia al punto giusto per guardare senza giudicare, ponendosi invece delle domande sui mondi arcani ed arcaici che convivono con la post modernità. Padre Cataldo riceve questo gregge scomposto e alla deriva, in una sala scalcinata; il tavolo è ricoperto da una cerata macchiata; le sedie spaiate. Nessuno sembra farci caso; chi va lì appartiene alla classe che compra i vestiti sulle bancarelle, e ha il trucco pesante. Nei locali alla moda del centro è il momento dell’aperitivo, ma nella chiesa di Padre Cataldo nessuno ne sa niente; due città che convivono senza incontrarsi.
È un film sulla possessione e sull’esorcismo, ma il vero racconto è affidato ai dettagli, a questo coro scomposto inzeppato dentro giacconi che imitano quelli di marca e che leggono quanto gli accade come il frutto del malocchio, di antiche invidie familiari, il male contro il bene. Sono quasi tutte donne vicine ai cinquanta, anche se Giulia ha solo tredici anni; un codice culturale che viene dal basso e da quello si alimenta. Faide familiari, corna, ma anche repressione, controllo sul corpo e sulla mente delle donne che alla fine per urlare il loro desiderio di libertà “si affidano” al male. Liberami allora diventa una supplica a stare nella vita con un altro passo, una richiesta che viene intercettata da chi, offrendo altre norme, le riporterà da dove cercano di fuggire.
data di pubblicazione: 5/10/2016
Scopri con un click il nostro voto: 
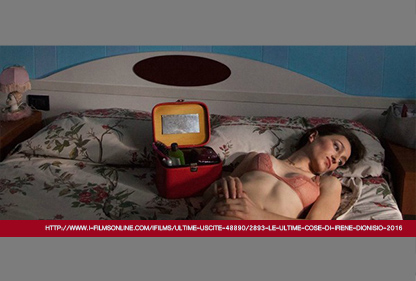
da Gabriella Ricciardi | Ott 3, 2016
Irene Dionisio è una giovane regista torinese (oggi trentenne) che con Le ultime cose, dopo essersi laureata in Filosofia estetica e sociale e frequentato il Master in documentarismo diretto da Daniele Segre e Marco Bellocchio, esordisce con questo film nel lungometraggio. Presentato a Venezia nella sezione Settimana della critica affronta in questi giorni il pubblico delle sale. La regista, con l’Associazione Fluxab di cui è socia fondatrice, cura progetti su temi come l’integrazione, le politiche culturali e le questioni di genere, temi che ha già in parte affrontato nei suoi documentari, e che costituiscono il punto di partenza anche per questo film che infatti in origine doveva essere un documentario.
Sono molte le persone che ogni giorno varcano la soglia del Banco dei pegni di Torino, tra smarrimento, angoscia e tentativi di mantenere il decoro. Cercano di ottenere una dilazione alla miseria impegnando appunto, quelle poche ultime cose che possiedono. Sandra, una giovane trans rifiutata dalla famiglia e appena tornata in città, cerca lavoro; Michele è pensionato e con sua moglie condivide la grande pena di non poter dare al suo nipotino di tre anni tutto ciò di cui ha bisogno per crescere meglio, soprattutto un indispensabile apparecchio acustico; Stefano da poco assunto al Banco, si scontra con colleghi che da tempo hanno fatto del Banco un luogo sordido dal quale ricavano soldi illeciti grazie al traffico dei pegni operato da altrettanto sordidi individui che come squali girano attorno all’edificio a caccia di bolle da riscattare e oggetti da ricomprare. Il perito “anziano” a cui Stefano è stato affidato, sottostima gli oggetti d’accordo con i rivenditori illegali all’esterno che si propongono immediatamente come compratori alternativi, offrendo compensi più appetibili a questo esercito di nuovi poveri. Stefano prova a comportarsi eticamente ma, forse perché troppo debole, alla fine sembra rinunciare alla sua posizione. Dico sembra, perché come molte altre cose di questo film, resta accennata senza essere sviluppata. La Dionisio non scava nei personaggi, li presenta e cerca di intrecciare labilmente queste storie senza riuscire però ad imbastire il racconto, e senza racconto e approfondimento manca l’interesse dello spettatore a saperne di più, a interessarsi veramente a queste vite. Lo sguardo della regista è attento alle piccolissime cose che definiscono i caratteri e le persone: monili, tinture slavate su capelli sciupati, abbigliamento da bancarella, case dignitose senza bellezza, ma non riesce a sfondare il confine che dalla documentazione, dalla testimonianza, si proietta nel racconto cinematografico, con ritmo e veri snodi drammaturgici. Insomma niente racconto corale come vorrebbe essere, dove non riescono a emergere neppure queste tre storie che dal coro dovrebbero elevarsi e allo stesso tempo rappresentarle tutte.
La stoffa c’è e il punto di partenza interessante, ma come ci ha ormai abituati Gianfranco Rosi, per far coesistere al cinema la verità della documentazione e la verosimiglianza della narrazione ci vogliono veri colpi d’ala di lirismo. Cinematografico!
data di pubblicazione 3/10/2016
Scopri con un click il nostro voto: 
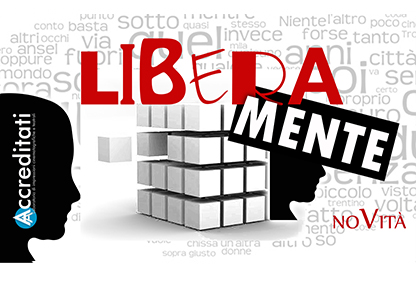
da Gabriella Ricciardi | Giu 28, 2016
Nel mondo del cinema, il mondo che amiamo e frequentiamo, ci sono molti mestieri di cui a volte, non conosciamo esattamente la cifra. Per questo abbiamo pensato di chiedere a un giovane (ha 26 anni) Direttore della Fotografia, Stefano Ferrari, qualcosa in più sul suo lavoro e sul perché, per farlo, è in America da cinque anni, dove ha partecipato a oltre a 40 progetti, tra lungometraggi, corti, video musicali e pubblicità.
– L’America, una scelta professionale o una scelta obbligata per poter lavorare?
“Ho deciso di venire a New York perché volevo confrontarmi con il mondo e mettermi in gioco. Volevo capire se la passione che stavo coltivando in Italia, nata osservando il lavoro di mio padre, anche lui Direttore della Fotografia, e poi lavorando come elettricista nel cinema, fosse veramente la strada da seguire. A 20 anni si vuol fare tutto e niente e io volevo vedere quanto fosse solida la mia passione.”
-Cosa hai fatto appena sbarcato in America?
“Durante il mio primo anno newyorkese ho frequentato il corso di cinematografia alla New York Film Academy. Una scuola che mi ha insegnato molto tecnicamente e che mi ha aperto le porte del mondo del cinema indipendente, mettendomi in contatto con persone di ogni parte del mondo. Ma è solo quando è finita l’accademia che ho conosciuto la vera faccia di NY. Una “giungla di cemento”, come dice Alicia Keys in una delle sue canzoni. Una giungla dove solo i migliori “sopravvivono”.
-E tu cosa hai fatto per sopravvivere?
“I primi lavori erano piccoli progetti. La maggior parte delle volte riuscivo solo a mangiare. Fare un po’ di esperienza e, se fortunato, un paio di buone conoscenze, era tutto il salario giornaliero che riuscivo a mettere insieme. Era un periodo di pura sperimentazione, alla continua ricerca di un’identità artistica. Tra questi progetti ricordo SIX, un corto che ha avuto un inaspettato successo nel circuito mondiale dei festival e mi ha garantito la mia prima nomination per la migliore fotografia. Oggi, i tempi di SIX sono passati e la mia carriera mi porta a lavorare in giro per il mondo e a confrontarmi con diversi mercati tra cui quello europeo. New York non è più una giungla, ma una città di cui amo i ritmi e le possibilità che offre. È la mia casa.”
-Hai un agente?
“No, ho avuto diverse proposte da parte di agenzie, ma ho preferito essere indipendente. I produttori mi contattano attraverso il mio sito o con la mail personale. Ormai il mio nome gira fra i colleghi. Funziona il passa parola e la meritocrazia.
-Cosa fa un Direttore della fotografia?
“Trasforma le parole della sceneggiatura in immagini. Insieme al regista crea il linguaggio visivo del film attraverso luci, colori e inquadrature.”
-Come e quando comincia un nuovo lavoro?
“La prima cosa è capire quale sia l’idea e l’obiettivo finale del progetto, poi leggo la sceneggiatura. Subito dopo cerco informazioni sulle persone coinvolte, soprattutto regista e produttori. È sempre importante capire con chi si ha a che fare. Quando ho deciso, mi piace avere un incontro informale con le persone coinvolte, di solito davanti a un buon caffè. Non mi piace prendermi troppo sul serio. Odio le riunioni fiume, non hanno un gran senso, soprattutto quando le uniche cose da discutere sono di carattere logistico. Al contrario, mi piace subito capire che tipo di energia ci sarà sul set. Con un po’ di esperienza, ci vuole poco a prevedere come un determinato team si comporterà durante la produzione.
I primi step di una pre-produzione sono fatti di ascolto. È fondamentale farmi un idea di quello che il regista ha in mente. Una storia la si può interpretare in molti modi e di conseguenza girarla in molti modi diversi. Il primo passo, il più importante, è trovare un linguaggio cinematografico univoco capace di tradurre la mia immaginazione, quella del regista e del resto dei collaboratori artistici, in immagine.
-Che differenze ci sono tra il mercato europeo e quello americano?
“La risposta è sempre una: le opportunità. In America il mondo dello spettacolo è visto prettamente come un business e in Europa forse, più come un’ arte, e questa interpretazione porta a qualche svantaggio, ma anche al grande vantaggio della meritocrazia. Chi lo merita va avanti, chi no, viene stritolato dai meccanismi di un sistema estremamente competitivo.
Detto questo, ho avuto invece l’opportunità di lavorare recentemente in Italia in un film con Francesco Pannofino, La Partita, una storia che racconta in chiave tragicomica diverse situazioni personali in cui le due religioni italiane, quella cattolica e quella calcistica, creano l’ambientazione della storia. Un tipica domenica italiana nella periferia romana. È un progetto che mi sta a cuore e che spero trovi la giusta distribuzione.
-Documentari?
“Ho lavorato al documentario di Marco Amenta, Magic Island, anche questo in Italia. Una bella esperienza in cui ho apprezzato la grande professionalità dei protagonisti e della troupe.
Mi piacerebbe lavorare più spesso in Italia, perché noi italiani abbiamo un bagaglio di cultura cinematografica molto ampio, ottime idee e una professionalità tangibile sul set.
-America e Italia, due modi diversi di lavorare?
“Non ho trovato grandi differenze, è più una differenza culturale e ambientale che professionale. I termini tecnici cambiano ma la sostanza rimane la stessa. In Russia invece si lavora in modo molto diverso: grande professionalità, ma altri metodi.
-Che progetti hai per il futuro?
“In agenda ho 3 documentari, uno sulla discriminazione delle donne a Hollywood, prodotto da Geena Davis; uno girato sull’isola greca di Kastellorizo sulla crisi dei rifugiati siriani e uno sulla figura di Dean Martin. Poi c’è anche un film, la storia di due ragazze tra amore, avventure e sanità mentale.
Lavori che fino ad ora, mi hanno fatto scoprire storie affascinanti, conoscere persone incredibilmente talentuose e viaggiare per il mondo.
data di pubblicazione: 28/06/2016

da Gabriella Ricciardi | Apr 23, 2016
(Teatro Argot – Roma, 21/24 aprile 2016)
Quando si spengono le luci su uno schermo viene proiettato un testo di Sarah Kane, disperato e definitivo come tutti i testi di quest’autrice. Un testo sui desideri e sull’impossibilità di provarne e realizzarli. E attorno al desiderio ragiona lo spettacolo, in questi giorni in scena all’Argot (fino al 24), Ex Antigone sulla felicità, con l’adattamento e la regia di Maurizio Panici, Creonte sulla scena che divide con Valentina Carli. L’adattamento è dal testo di Jean Anouihl che nel 42, in una Francia occupata, in parte resistente e in parte collaborazionista, vede in Antigone un’adolescente nervosa e irruente, una figura di resistente. Antigone vuole tutto, non si accontenta di una piccola felicità borghese, e per questo sfida il potere di Creonte, arroccato nella strenua difesa della necessità della mediazione.
Il mito ha questa capacità significante, quella di parlare direttamente al pubblico, di arrivare alla radice delle emozioni e farci sentire impossibilitati a decidere in maniera netta ciò che è bene e ciò che è male.
L’uomo è per sua natura e condizione un problema esistenziale ben al di là delle sue scelte etiche, non riducibile a schemi ideologici chiari. In questo schema di simmetrie continuamente smentite, l’adattamento di Panici esaspera giustamente questo fronteggiarsi dialettico, in uno scambio serratissimo tra i due protagonisti. Voce e presenza scenica molto convincente quella di Panici, un Creonte attraversato da mille dubbi espressi con una voce che viene direttamente dallo stomaco e capace di far affiorare la malinconia che gli mina l’autoritarismo. Meno convincente la giovane Valentina Carli che “dice” il testo ma non riusce a nutrirlo di emozioni. Forse anche perché meno curata la regia dei suoi movimenti scenici, risultati troppo moderni e poco “mitici”; più vera e diretta nel monologo dedicato al suo promesso sposo Emone, amore a cui dovrà rinunciare per non scendere a patti con il principio di realtà che schiaccia tutto e riduce anche l’amore ad abitudine.
Ridurre il testo allo scontro tra il potere e il suo esercizio e chi lo contesta, è riduttivo. Antigone vuole “tutto e subito – e che sia tutto intero – altrimenti rifiuto!” Non vuole essere modesta e vuole la bellezza. Con il suo grido questa Antigone vuole dirci di non accontentarci, di non trovare un bello consolatorio, ma di essere esigenti come quando eravamo ribelli. E Panici sembra proprio indicarci questa lettura, vista la scelta di far scorrere sullo schermo, dopo le parole della Kane, le immagini delle manifestazioni potenti e massive nell’America degli anni ’60. E mentre ce ne stiamo “borghesemente” seduti al buio, Panici ci ricorda che ribellarsi è giusto; e così la poltrona diventa un po’ meno rassicurante.
data di pubblicazione: 24/04/2016
Il nostro voto: 

da Gabriella Ricciardi | Apr 14, 2016
Nella lingua di Samoa esiste una parola, fa’ afafine, che definisce quei bambini e adulti poi, che non amano identificarsi in un sesso o nell’altro, una sorta di terzo sesso a cui la società samoana non impone una scelta. E Samoa è l’isola in cui Alex, il protagonista dello spettacolo teatrale Fa’ Afafine, mi chiamo Alex e sono un dinosauro, vuole andare a vivere insieme a Elliot il compagno di scuola di cui si è innamorato. Giuliano Scarpinato, palermitano, vincitore del Premio Scenario Infanzia 2014, non si è lasciato intimorire né dalle polemiche, né dalla censura che la sua città ha rivolto allo spettacolo, seppur prodotto dal Teatro Biondo, e ha continuato a spiegare a chi voleva incastrarlo in una categoria, che in realtà la “visione è più ampia: s’interroga sulla specificità di ciascuno di noi, oltre le categorie e gli stereotipi.”
Alex è uno di quei bambini che in America stanno tenendo sulle spine psicologi e sociologi, perché non riescono a scegliere un genere a cui appartenere e fanno la spola tra l’essere maschio e vestirsi come tale, e l’essere femmina e indossare un bel vestito azzurro da principessa come fa Alex sul palco.
È mattina e fuori dalla porta della camera di Alex i genitori, come in ogni casa del mondo, non fanno che incalzarlo: è tardi bisogna prepararsi e uscire di corsa per andare a scuola e loro al lavoro, ma Alex non riesce a decidere tra il decolté rosso di mamma con tacco e gli scarpini da calcio e a poco a poco dalla fessura della porta racconterà tutto ai due nervosi genitori. Lui vuole andarsene con Elliot a Samoa e non dover più decidere cosa è meglio essere. La stanza diventa una navicella spaziale per il viaggio, e le pareti mare, ricche di pesci colorati. Lui viaggia felice con i suoi amici inseparabili: una indossatrice nuda che ha abbandonato la carriera (una barbie), un maialino e un cane di gomma e quella stanza non ha più confini, è tutto il mondo, perfino la luna e il sole possono starci allo stesso tempo.
Nella bella regia di Scarpinato che interpreta il padre di Alex, (la madre è Gioia Salvatori) i genitori sono solo in video, visti attraverso la toppa della porta. I visi deformati quando gridano ad Alex di sbrigarsi o rifiutano la sua limpida indecisione, poi sorridenti quando finalmente trovano la chiave per comunicare con lui. Si travestiranno anche loro, invertendo i ruoli e coinvolgendo Alex in una coreografia divertente che li porterà a scuola insieme a dimostrare a tutti che nella loro famiglia non è poi così importante come ci si veste. I bambini in sala (lo abbiamo visto all’India a Roma) si sono molto divertiti, ma anche noi adulti perché è bello ricordare come eravamo quando acquattati nelle nostre stanze-fortezze cercavamo di essere qualcosa e qualcuno, al margine dell’educazione che genitori più o meno severi cercavano di imporre. Vederli e sentirli all’altro lato della porta, è una bella intuizione scenica che restituisce ai piccoli e ai più grandi, il senso della cesura generazionale e il divario che c’è, tra lasciare che l’altro sia come è e come vuole essere, o imporgli dei modelli che non riesce e non vuole assimilare. Questo spettacolo è la prova che il teatro cosiddetto “per ragazzi” è spesso un mondo teatrale poco esplorato al di là degli stereotipi, spesso zuccherosissimi, che non riescono a proporsi come esperienza estetica oltre che educativa per chi vi partecipa. Fa’ afafine invece vince la scommessa proponendo una regia raffinata e vicina alla sensibilità delle nuove generazioni, facendo del video una parte irrinunciabile e integrata della narrazione scenica
data di pubblicazione:14/04/2016
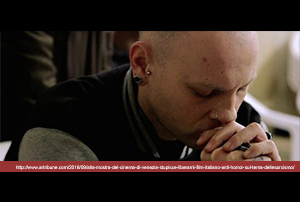


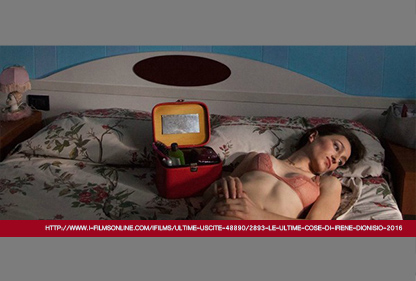
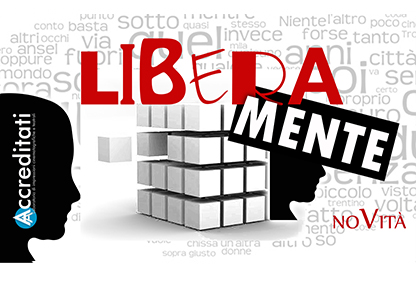








Gli ultimi commenti…