SILENCE di Martin Scorsese, 2017
In un’epoca satura di rumori, intitolare il proprio film Silence, è molto più che una scelta estetica, e Scorsese ne era così consapevole da aver aspettato quasi trent’anni per realizzarlo dal romanzo omonimo di Shusaku Endo, uno scrittore cristiano le cui pagine ricordano più i temi e il sapore di quelle di Bernanos che di Mischima.
1630. Montagne foderate da una vegetazione così fitta da essere verde smeraldo, precipitano su rocce grigie che si aprono in crateri colmi di acqua caldissima. I giapponesi chiamano Inferno quel luogo e lo usano per torturarci i cristiani che non hanno abiurato la loro fede.
In una grande stanza di un istituto religioso olandese, attraversata da una fredda luce nordica, padre Rodrigues e padre Garupe (Adam Driver e Andrew Garfield) devono convincere il loro superiore, a lasciarli partire alla volta del Giappone dove sperano di ritrovare il loro maestro, Padre Ferreira (Liam Neeson) di cui non si hanno più notizie e che pare abbia abiurato e viva ormai come un giapponese. La camera si stacca da terra e segue i tre sulla bianca scalinata dell’Istituto gesuita, rendendoli tre macchie nere lontanissime, come se fosse Dio stesso testimone di quella decisione rischiosa e definitiva, vedendo le cose da una prospettiva impossibile a chi è sulla terra, impegnati come si è nella frivolezza e durezza del vivere. Questa ripresa dall’alto sarà l’unica del film, a sottolineare che il dramma che vi si consuma è tutto dentro la dimensione umana benché parli di fede e di Dio. I padri si imbarcano a Macao di notte con una guida, Kichijiro – il vero maestro spirituale di padre Rodrigues – un giapponese dell’isola di Goto che vuol far ritorno a casa. Quel viaggio notturno è di una bellezza assoluta: l’imbarcazione che solca un mare vellutato e gonfiato dal vento in una nebbia delicata, fumosa, sta traghettando i due gesuiti in un altro regno, un regno dal quale non si può tornare indietro, perché ciò che scopriranno di se stessi renderà il loro viaggio oltre che pericoloso, iniziatico, una scena in cui Scorsese salda perfettamente il piano simbolico, metafisico, con quello delle immagini a cui si affida tutto il tormentato rapporto con la fede di Rodrigues.
In Giappone le comunità cristiane sono state decimate e vivono nel terrore. Gli abitanti del piccolo villaggio che li accoglie e nasconde sono poverissimi. La loro è una vita di umiliazioni e stenti. Non hanno che la prospettiva di morire per poter stare eternamente in paradiso. E in questo Scorsese offre la prima chiave interpretativa allo spettatore. Il potere per essere tale, per mantenere il controllo assoluto sulle persone, le umilia fino a togliergli tutto; privandoli della fede cristiana, impedendogliela, di fatto non ne determina solo la miseria con tasse esose, ma entra dentro i pensieri, dentro i cuori, estirpandone fede, desideri e dignità, perché per restare vivi devono calpestare l’immagine che venerano. La fede praticata da questi contadini, è una fede molto simile a quella dei primi martiri cristiani, una fede che sconvolge i due gesuiti determinati e forgiati dalla ferrea disciplina degli esercizi spirituali, ma fredda rispetto a questa, così animata dalla speranza. Vivono in comunità e la celebrazione della messa, di notte e in una capanna, è davvero un momento rivoluzionario, sembra dirci Scorsese, perché nulla dopo quel rito dovrebbe restare immutato. Quella intensità e coesione dovrebbe naturalmente generare la risposta di Dio, ma Dio tace. Il governo, l’Inquisitore, uccidono e Dio non concede che il silenzio in risposta a tutta quella sofferenza. Come in tutti i film di Scorsese la violenza è esplicita, reale, ma più aumenta, più genera nei due gesuiti tenerezza e compassione. Tutta la riflessione del regista sulla fede è come si percepisce Dio, l’intangibile, tanto che la sceneggiatura è estremamente asciutta, i dialoghi serrati e necessari. Il rapporto con la fede è affidato alle immagini che rappresentano il volto di Cristo, scelto nel bellissimo ritratto di El Greco, che lo fa dolcissimo, quasi triste. Anche quel volto così cercato, tace di fronte alle sofferenze, rivelandosi nel cuore di Rodrigues proprio quando sembra che tutto sia perduto. Specchiandosi nell’acqua, vede riflessa prima la sua immagine e poi sovrapporsi a questa, il volto del Cristo di El Greco e poi di nuovo tornare lui. Allora capisce che non c’è separazione tra sé e il divino, ma che l’uno vive dentro l’altro, una scoperta e un vissuto che invece Padre Ferreira non sperimenterà mai. Quando finalmente si incontrano, il maestro è davvero diventato buddista, vive con sua moglie, ha dei figli. Studia in un tempio. Ha il compito di convincere padre Rodrigues ad abiurare, la sua abiura salverà la vita a molti, come ai cinque torturati che dividono la prigione con lui e che stanno morendo di una morte lentissima e crudelissima. Ferreira lo spinge a ragionare sull’inutile sacrificio di altre vite. Non c’è nessuna religione, o divinità che valga il miracolo di una vita, con la bellezza di un volto umano che ti guarda. Rodrigues deve combattere con l’orgoglio. È il suo demone più minaccioso. Lo rende onnipotente, gli fa credere di essere come Gesù che porta la croce, non perché ogni uomo è divino e viceversa, ma perché c’è una totale identificazione dettata dall’orgoglio, con la sofferenza e morte del Cristo chiesta da un ordine superiore. Dal Padre. Inversamente ad ogni logica che vuole il Figlio allontanarsi ed emanciparsi dalla casa paterna, il padre celeste chiede il sacrificio del figlio. Scorsese non sembra sfiorato dunque dall’analisi freudiana, continuando a ritenere necessario (per lo meno alla fede) il sacrificio del figlio per saldare il divino all’umano.
Scorsese ha senz’altro guardato al Vangelo di Pasolini; lo cita quando mette Rodrigues su un cavallo e gli fa attraversare il villaggio scortato dai soldati mentre la folla lo insulta, rendendo la scena speculare a quella in cui il Cristo di Pasolini viene acclamato nella domenica delle palme. Quello che gli interessa di Pasolini è la totale umanizzazione di Cristo; un uomo che è divino perché dotato di tenerezza e compassione per i simili. Ecco perché Rodrigues cede, deve salvare quelle persone e non metterne altre in pericolo, perché cadendo, ossia abiurando, sconfigge finalmente l’orgoglio.
Lo vediamo invecchiare, aver negato la fede, parlare perfettamente giapponese, ma poi nel silenzio della casa che divide con una moglie e una figlia, ritrovarla, riuscire a riascoltare la voce di Cristo insieme a Kichijiro, l’essere debole per eccellenza, colui che per paura ha tradito ripetutamente Rodrigues, la sua famiglia, e tutte le volte ha disperatamente chiesto di essere perdonato. È lui l’umile che si deve amare, senza amare la sua fragilità non si può dire di amare gli uomini. Troppo facile amare i belli e i buoni, come lo stesso Rodrigues si dice.
Confesso di essere stata irritata per gran parte del film dall’intransigenza e dalla necessità indiscussa del proselitismo, dalla cieca devozione alle immagini che vanno custodite e protette a costo della propria vita, schegge assolute di divino per chi ve ne vede in esse. Questo culto così prosaico, apotropaico direi, mi irritava, ma Scorsese fa un passo indietro e mentre afferma la grandezza di quelle immagini, ne denuncia il loro limite di oggetti. Se ne rende conto padre Rodrigues quando non ha più niente da regalare (né un crocefisso, né un’immagine sacra) e smembra il suo rosario, capendo che ognuno di quei grani sarebbe stato il tesoro segreto di quei contadini affamati di speranza. E non è stato, ed è ancora così, nel nostro Sud, dove la devozione al proprio santo, alla sua immagine (le reliquie, le ossa, la veste) è il lessico e perno di quella fede? Scorsese ci avverte che esistere è coesistenza degli opposti. Non c’è fede senza superstizione; non c’è bene senza male; non c’è umiliazione senza riscatto; non c’è paura senza coraggio; non c’è Dio senza l’uomo.
A margine di tutta questa complessità teorica e teologica, Silence è un film di imponente bellezza, ma che come tutte le cose belle non è semplice, ossia è una bellezza lavorata dal pensiero e dalla consapevolezza profonda della materia che si tratta.
L’unica cosa che non mi ha convinta nella precisione filologica dedicata agli ambienti, ai vestiti, ai comportamenti, è la lingua. Perché dei contadini poverissimi nel Giappone del 1600 dovevano conoscere l’inglese? Come era possibile che sapessero parlare una lingua così lontana dei contadini che avevano visto solo fango e sopraffazione?
L’altra è la durata. Credo che si poteva leggermente asciugare, anche se mi rendo conto che il respiro che il regista ha voluto dare è quello biblico, esteso, di Moby Dick.
Interrogandomi sul titolo – questa parola che è condizione, e che racchiude il nero nelle sue volute grafiche – ne ho chiesto ragione a mio figlio e lui mi ha risposto così:
“Il silenzio è preghiera.” Semplice no?
data di pubblicazione:26/01/2017
Scopri con un click il nostro voto: 





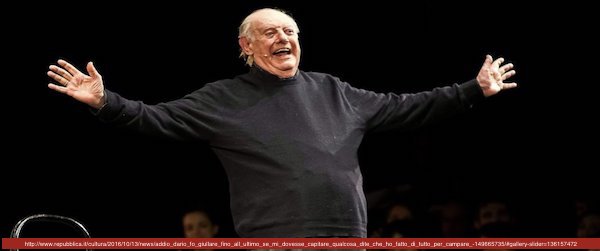





Gli ultimi commenti…